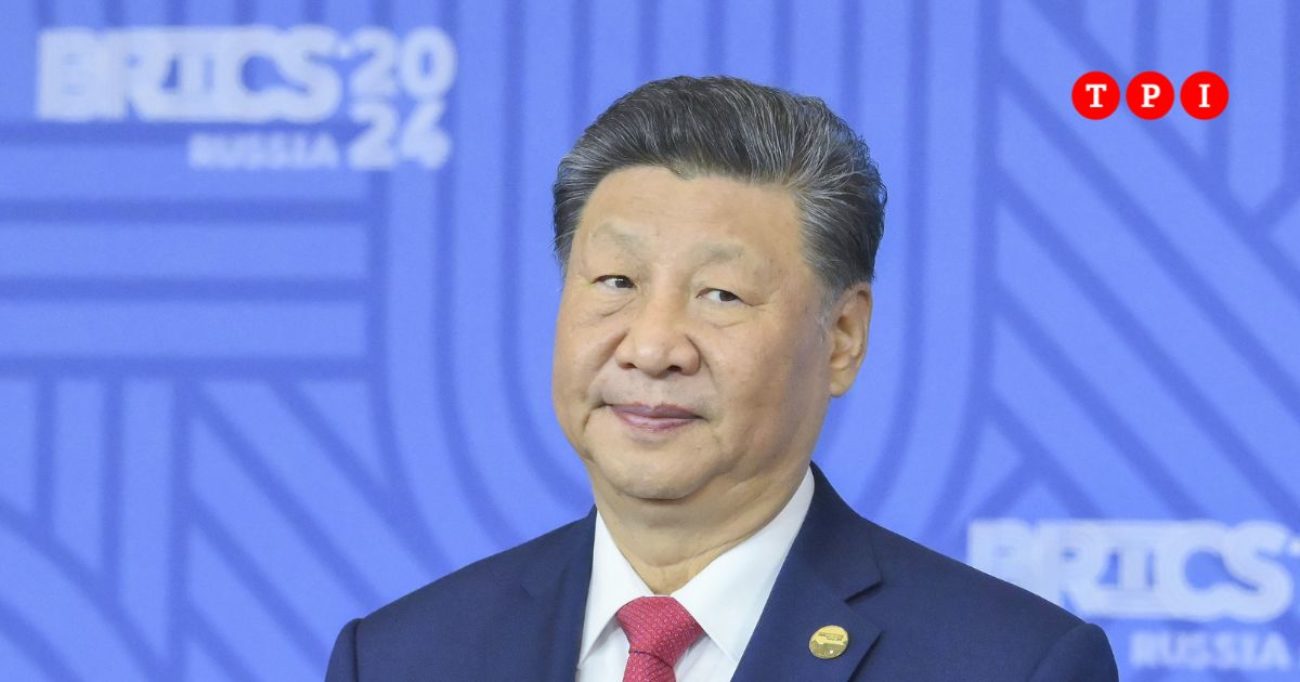Come i media devono trattare l’Isis

Si devono pubblicare video degli ostaggi? Spesso si trova una soluzione davanti all’emergenza, rischiando incoerenza e passi falsi
La ridefinizione dei limiti dell’orrore a opera dei jihadisti dell’organizzazione dell’Isis e dei loro emuli pone un interrogativo ai media incaricati di trattare la questione.
Effettivamente, l’Isis ha superato tutti i gruppi terroristici oggi noti non solo in termini di crudeltà, ma soprattutto nella regia. Retorica e ideologia medievali, filmate con la professionalità e l’estetica delle serie tv americane all’ultimo grido o con quella dei videogiochi più violenti, come nel caso del film propagandistico Flames of War, della durata di 55 minuti.
In nome del rispetto della dignità umana, si devono mandare in onda le immagini tratte dai video che mostrano gli ostaggi? Si deve sfocare il viso, trasmettendo immagini di repertorio? Spesso ci si pone il problema e si trova una soluzione quando si è davanti all’emergenza, rischiando incoerenza e passi falsi.
— Leggi Cos’è l’Isis, senza giri di parole
Alcuni media, che non si erano fatti troppi scrupoli per James Foley e i suoi compagni di sventura, dal caso Gourdel hanno improvvisamente iniziato a preoccuparsi dell’etica.
Altri, invece, che in un primo momento avevano ritenuto più opportuno il riserbo, oggi reputano che la posta in gioco a livello nazionale sia troppo alta per poter rinunciare a un’immagine shock.
Le regole che stabiliamo per gli ostaggi occidentali valgono anche per i soldati e i civili siriani e iracheni martirizzati dai jihadisti, che da tempo praticano e rendono pubbliche esecuzioni di massa e crocifissioni nella più totale indifferenza?
OGNI CASO È A SÉ
Le rivelazioni sulle condizioni di detenzione degli ostaggi occidentali, e la divulgazione di eventuali riscatti pagati da alcuni Stati in cambio della loro liberazione, suscitano regolarmente polemiche e dibattiti, talvolta accesi, tra i giornalisti. Si procede per tentativi, analizzando ogni caso individualmente.
TPI esce in edicola ogni venerdì
Quello di James Cantlie, un ostaggio dello Stato Islamico prigioniero in Siria dal novembre 2012, è particolare da tutti i punti di vista. È raro, nel mondo indiscreto della stampa, che una vicenda resti segreta così a lungo. Sono passati quasi due anni prima che le condizioni, e perfino il nome, del fotoreporter britannico quarantaquattrenne John Cantlie diventassero di dominio pubblico.
Si è dovuto attendere giovedì 18 settembre, quando è comparso nel primo video propagandistico pubblicato online dall’Isis. In un secondo video reso pubblico martedì 23 settembre e girato anch’esso probabilmente contro la sua volontà, Cantlie mette in guardia gli Stati Uniti e Barack Obama contro un nuovo Vietnam.
Perché questo silenzio? La storia eccezionale di questo prigioniero era stata taciuta per non aggravare la sua situazione, perché più complessa delle altre.
Cantlie era già stato rapito durante il suo primo soggiorno in Siria, nell’estate del 2012. Detenuto da un piccolo gruppo di jihadisti stranieri stabilitisi in un accampamento vicino al confine con la Turchia, aveva trascorso una settimana in prigionia, subendo soprusi e simulazioni di esecuzioni.
Ferito alla gamba mentre tentava invano di evadere, aveva alla fine riconquistato la libertà grazie a un attacco a sorpresa messo a segno dai ribelli moderati dell’Esercito siriano libero (Esl).
Dopo alcune settimane di riposo in Gran Bretagna, John Cantlie era voluto tornare in Siria, soprattutto per rintracciare i suoi liberatori e indagare sui suoi sequestratori.
Il 22 novembre 2012, poco dopo essere uscito da un internet point nel villaggio di Binnich, mentre si dirigeva verso il confine turco al termine di tre estenuanti settimane di reportage, Cantlie venne nuovamente rapito, con il compagno di viaggio, il giornalista americano James Foley.
La famiglia di John Cantlie e le autorità britanniche avevano richiesto un “black-out” giornalistico, soprattutto per proteggerlo dai suoi carcerieri, che si sarebbero potuti vendicare se avessero sospettato che Cantlie aveva rivelato l’identità dei suoi primi rapitori.
L’apparizione video di John Cantlie ha disintegrato il consenso che si era creato. Tuttavia, la probabilità che questi ne fossero al corrente è molto alta, viste le vere e proprie inchieste condotte dagli aguzzini sulle vittime. Ciò potrebbe spiegare il trattamento particolare riservato a Cantlie, costretto a elogiare i suoi carnefici.
RISPETTARE IL SILENZIO
Fino a quel momento, il nome del fotografo britannico non era stato mai menzionato, così come quello di Steven Sotloff, il giornalista decapitato dopo il collega americano James Foley (19 agosto) e prima dell’operatore umanitario britannico David Haines (13 settembre).
Anche in quel caso, la famiglia era riuscita a far rispettare il silenzio stampa, in particolare sulla doppia cittadinanza di Sotloff, americana e israeliana, nonostante la sua storia fosse nota nel mondo dei giornalisti interessati al jihadismo e alla Siria. Questo fatto è straordinario, tanto più che i social network, la loro risonanza planetaria e la loro velocità di circolazione complicavano notevolmente la situazione.
Dopo l’esecuzione di James Foley, alcuni hanno messo in discussione la scelta del “black-out”. In effetti, il silenzio stampa avrebbe potuto contribuire a far sottovalutare il pericolo ai giornalisti che poco conoscevano la realtà sul campo.
Ha soprattutto fatto il gioco dei governi che avevano l’intenzione di intervenire (o di non fare niente) senza dover essere sottoposti alla pressione dell’opinione pubblica. Il dibattito è stato velocemente soffocato da un rinnovato invito al “blackout”, indirizzato questa volta ai terribili videotestamento e a quelli in cui sono filmate le esecuzioni degli ostaggi, postati online dall’Isis.
Il problema è pressante, tanto più che lo Stato Islamico è la prima organizzazione terroristica a utilizzare i social network in modo così sistematico. La sua ascesa è concomitante con le rivoluzioni arabe, che hanno visto i popoli aggirare la censura statale avvalendosi di Twitter, Youtube e Facebook.
La diffusione dei messaggi tramite i social network permette all’Isis di scavalcare i media tradizionali attraverso i quali comunicava al-Qaeda (in particolare, l’emittente televisiva Al Jazeera) e di evitare che i canali di diffusione (emittenti radiofoniche, studi televisivi, antenne satellitari, etc.) rappresentino facili bersagli.
Tuttavia, la crescente collaborazione tra i grandi operatori di internet e i servizi di sicurezza occidentali inizia a dare frutti: gli account, appena aperti, vengono chiusi. L’Isis, dal canto suo, per continuare a far sentire il suo messaggio, ha reagito con un’escalation di barbarie.
L’ESEMPIO DI “FRANCE 24”
I media che hanno osato stilare un codice di condotta sono pochi. È un esercizio pericoloso. Così, France 24 si è ritrovata nella tormenta quando una nota di servizio, inviata sabato 20 settembre dal suo direttore Mark Saïkali, è trapelata tra gli altri media.
“Dobbiamo schierarci apertamente contro questi barbari. Per questo vi chiedo di prestare attenzione a ogni parola, a ogni bozza. La linea editoriale della rete è chiara: sono dei terroristi e dei barbari.
Per una volta, ci sono i buoni e ci sono i cattivi! Loro, sono i peggiori nemici della nostra civiltà. Siamo seguiti da almeno 43 milioni di telespettatori, abbiamo un’immensa responsabilità”.
La Società dei giornalisti di Radio France Internationale (Rfi), che fa capo alla stessa società di France 24 (France Médias Monde), ha reagito in modo acceso: “Questi discorsi contrastano apertamente con le regole fondamentali della deontologia”.
Spalleggiato da Le Monde, Marc Saïkali ammette che la forma può essere oggetto di discussioni, ma la sua posizione resta inflessibile.
“Ho voluto ribadire alcuni principi chiari e semplici su una rete televisiva che ogni giorno manda in onda 144 notiziari in tre lingue. Innanzitutto, lo Stato Islamico non è uno Stato, quindi noi lo chiamiamo ‘organizzazione dello Stato Islamico’. Siamo stati i primi a prendere questa decisione, a luglio, e ne vado fiero.
Inoltre, le immagini tratte dai video, che tra l’altro sono girate molto bene, fanno parte di un’operazione di propaganda. Quindi, scriviamo ‘immagini di propaganda’. Per quanto riguarda ostaggi ed esecuzioni di massa, rispetto le convenzioni di Ginevra: non faccio vedere né i boia né le vittime.
Nei dibattiti, non ho niente contro le spiegazioni, è il nostro lavoro, ma la giustificazione proprio no. Niente può giustificare questa barbarie. Per concludere, voglio evitare che si faccia confusione tra i musulmani, che siano in Francia o all’estero, e questi barbari. La nostra linea editoriale si basa sui valori della Repubblica: libertà, democrazia, uguaglianza di genere, tolleranza”.
Un comunicato diffuso dalle redazioni dei media di France Médias Monde ha messo fine alla polemica. Ricorda l’attaccamento “ai principi fondamentali del giornalismo”: esposizione dei fatti, decodificazione, analisi imparziale, “facendo grande attenzione a non diventare oggetto di manipolazioni”.
“DAESH” O “I TAGLIAGOLA DI DAESH”
I media non sono gli unici a porsi certi interrogativi. I leader sono altrettanto perplessi di fronte allo Stato Islamico. Così, il ministro degli Esteri francese Laurent Fabius, dopo aver usato vari appellativi per designare l’organizzazione (tra cui “califfato”), alla fine ha scelto l’acronimo arabo Daesh (che sta per Daoula islamiya fi Al-Iraq wal-Cham, “Stato Islamico dell’Iraq e del Levante”).
“Il gruppo terroristico in questione non è uno Stato. Consiglio di non usare l’espressione ‘Stato Islamico’ perché si presta a confusione: islam, islamisti, musulmani”, ha spiegato il 10 settembre. “Stiamo parlando di quelli che gli arabi chiamano Daesh e che io chiamerei i ‘tagliagola di Daesh'”. Da allora, François Hollande ha adottato questo slittamento semantico.
Nelle zone sotto il suo controllo, il gruppo jihadista vieta l’uso di questo acronimo, che reputa degradante viste le sue ambizioni “statali”. Anche oltreoceano, il dibattito verteva sulla traduzione di “Cham” con Siria o Levante, considerato un appellativo coloniale ma più corretto per indicare la Grande Siria.
L’Agence France-Presse, dal canto suo, ha postato sul suo blog Making of/les coulisses de l’info un articolo straordinario firmato dalla direttrice Michèle Léridon, in cui si riaffermano i valori etici e le regole editoriali dell’agenzia:
Niente freelance nelle zone in cui l’agenzia non invia i suoi dipendenti, né immagini degradanti di ostaggi o vittime, né la diffusione di affermazioni strappate con forza. Non è una panacea, ma è un buon vademecum.
*Christophe Ayad è un giornalista francese. Il suo articolo, Les médias face à l’«Etat islamique», è stato pubblicato su Le Monde. Traduzione di Lorenza Geronimo