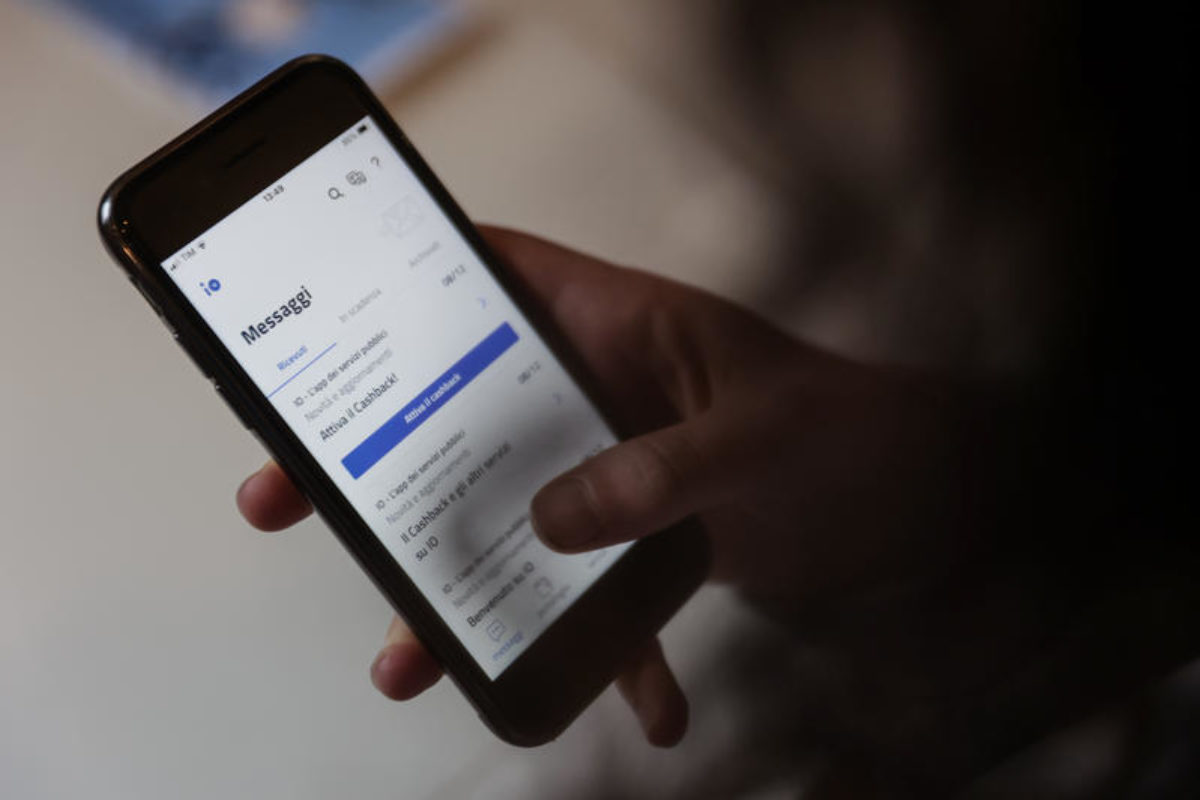Ho assistito al futuro dell’intelligenza artificiale ed è un giocattolo rotto

Dispositivi incapaci di eseguire semplici comandi. App piene di bug. E motori di ricerca con risultati surreali. Finora il sogno dell’intelligenza artificiale si è rivelato una vuota promessa. E persino Meta e Google faticano a trovare nuove idee
Mesi di attesa e promesse. Poi ad aprile è finalmente arrivato sul mercato Rabbit R1, uno dei nuovi dispositivi che puntano a fare breccia tra i consumatori sfruttando l’intelligenza artificiale. Un assistente in grado di rispondere alle richieste più disparate, a un costo (relativamente) contenuto, con un design tanto semplice quanto accattivante. Questa la promessa di Rabbit, che ha alimentato le aspettative di molti appassionati alla ricerca della “next big thing”.
Spesso, rettangolare, arancione: il design richiama volutamente quello di un giocattolo di plastica, lasciando spazio a pochi semplici elementi. Una sola fotocamera che ruota per passare dal retro alla ripresa in modalità selfie, una rotella per navigare lo schermo e un tasto laterale per attivare un microfono, come un walkie-talkie. Infine lo schermo, un rettangolo nero in cui galleggia il coniglio bianco che risponde alle domande degli utenti.
Se l’ultima novità è un flop…
Un oggetto essenziale, con cui Rabbit si aggiunge ad altre startup e big del tech che stanno sfruttando la scia di ChatGPT alla ricerca del prossimo prodotto spartiacque, dopo l’arrivo dello smartphone più di 15 anni fa. Per il momento, secondo osservatori e addetti ai lavori, i produttori di smartphone possono dormire sonni tranquilli.
Secondo l’azienda, il modello di intelligenza artificiale usato dall’R1 è ancora in una fase «molto iniziale». Questo significa che gli utenti non possono usare molte delle funzionalità annunciate negli scorsi mesi. Rispetto a un chatbot come ChatGPT, che può fornire risposte testuali a domande, Rabbit usa un modello che promette di completare azioni su diverse applicazioni, come ad esempio prenotare un’auto su Uber, inviare denaro tramite un’app di pagamenti o ordinare cibo da asporto. A febbraio il fondatore Jesse Lyu aveva dichiarato che Rabbit stava addestrando il modello su 800 applicazioni. Al momento del lancio era in grado di usarne solo quattro: Spotify, Uber, l’app per le consegne DoorDash e la piattaforma di generazione di immagini MidJourney. In futuro i prodotti Rabbit saranno in grado, secondo Lyu, di controllare i vari dispositivi “smart” disseminati per casa, semplicemente inquadrandoli. Attualmente però all’R1 mancano ancora molte funzionalità di base. Al momento del lancio non riusciva a impostare un timer né una sveglia e nemmeno scattare foto. Alcune di queste funzioni, secondo l’azienda, arriveranno con i futuri aggiornamenti.
Il problema però non sono solo le funzionalità mancanti. Nel comprendere le richieste, riconoscere gli oggetti che ha di fronte o eseguire i comandi, i bug e gli errori sono costanti. Il primo è stato notato alla stessa festa di lancio quando, secondo quanto riportato da Caroline Mimbs Nyce sulla rivista The Atlantic, i presenti si sono accorti che non c’era modo di cambiare fuso orario sui dispositivi, che erano in molti casi programmati di default sull’ora californiana. Quando la giornalista ha provato a usare l’R1 per prenotare una corsa tramite Uber non solo il dispositivo non è stato d’aiuto ma ha comunicato erroneamente che la richiesta non era stata inoltrata, costringendola a pagare una corsa che non ha mai potuto usare.
Il verdetto delle prime recensioni è stato impietoso. Le testate specializzate hanno parlato senza mezzi termini di «pasticcio». Nonostante aspetti positivi come il design e il prezzo di 199 dollari, le funzionalità mancanti, i bug costanti e la durata della batteria hanno spinto molti a interrogarsi sull’opportunità di lanciare sul mercato prodotti che non sono pronti all’utilizzo.
«Questo è il culmine di una tendenza che si insinua da anni: consegnare prodotti a malapena finiti per vincere una “gara” e poi continuare a sistemarli dopo che gli utenti hanno pagato a prezzo pieno», ha scritto su X il noto youtuber Marques Brownlee. «Giochi, telefoni, automobili, ora l’intelligenza artificiale in una scatola».
Molti mettono in dubbio la stessa ragion d’essere del dispositivo: perché non proporre semplicemente un’app? A scatenare la polemica è stato un giornalista che è riuscito a lanciare il software dell’R1 su un Google Pixel 6A, uno smartphone Android di due anni fa. Mishaal Rahman, del portale Android Authority, è riuscito a usare l’assistente e a fare domande usando il tasto del volume dello smartphone al posto di quello dell’R1. L’accusa è di aver creato un prodotto inutile, che poteva essere contenuto in una semplice app.
Come Juicero, famigerata “Nespresso dei succhi di frutta” affondata da una recensione di Bloomberg nel 2017. In quel caso l’azienda vendeva una macchina da 400 dollari per spremere pacchetti di frutta e verdura venduti dalla stessa Juicero. La start-up chiuse i battenti dopo la scoperta che i pacchetti potevano essere tranquillamente spremuti con le mani ottenendo lo stesso risultato. Nel caso di Rabbit, il fondatore Lyu si è difeso dalle critiche specificando che l’interfaccia dell’R1 non è assimilabile a un’app di Android e che, se fosse usato in quel modo, il software non riuscirebbe ad accedere ai servizi.
…la concorrenza fa di peggio
Le recenti polemiche non si sono limitate a Rabbit ma hanno anche accompagnato l’arrivo, altrettanto pubblicizzato, dell’AI Pin di Humane. Secondo quest’azienda, fondata da ex dipendenti di Apple, la rivoluzione dell’intelligenza artificiale passerà per un mini dispositivo che si indossa sui vestiti, senza alcun display con cui interagire. L’ambizione di Humane, va oltre quella di concorrenti come Rabbit e punta a immaginare un futuro post-smartphone, in cui gli utenti siano liberi di passare meno tempo con la faccia rivolta a uno schermo per dedicarsi maggiormente al mondo che hanno intorno.
L’AI Pin di Humane è grande grosso modo la metà di un pacchetto di gomme e pesa quanto quanto due batterie stilo. Si indossa sui vestiti come una spilla o un tesserino di riconoscimento grazie a un magnete che si aggancia dietro al tessuto e funge anche da batteria aggiuntiva. In tutte le dimostrazioni di Humane, l’AI Pin viene collocato sul petto, la posizione da cui il microfono, la fotocamera e gli altoparlanti funzionano meglio. È realizzato in alluminio ed è progettato per resistere alle cadute e anche ai lavaggi. A differenza di altri assistenti non rimane in ascolto in attesa di un comando vocale, ma è necessario attivarlo con un tocco. Può rispondere a semplici domande, effettuare telefonate, scattare foto e descrivere cosa si trova nelle vicinanze. Non ha uno schermo ma dispone di un laser che si proietta sulla mano: basta dare il comando a voce e aprire il palmo. Per navigare si usano i gesti, pizzicando indice e pollice per selezionare. Le foto e i video vengono caricati in un’app web dedicata da cui si possono consultare e gestire.
L’idea è di un dispositivo che può essere usato senza estrarre nulla dalle tasche né digitare alcunché su una tastiera, tantomeno fissare uno schermo, senza essere distratti dalle miriadi di applicazioni che cercano di attirare la nostra attenzione. Per inviare un messaggio o conoscere le previsioni del tempo è sufficiente parlare all’AI Pin che, grazie alla connessione, esegue i comandi e risponde alle domande. O almeno dovrebbe.
Dopo sei anni di sviluppo, il dispositivo è arrivato sul mercato ad aprile, accolto anch’esso da recensioni disastrose. Si parte dal prezzo: l’AI Pin costa 699 dollari, con un abbonamento aggiuntivo da 24 dollari al mese per la connessione. Vengono contestati anche i lunghi tempi di risposta, i frequenti errori, la scarsa durata della batteria, il surriscaldamento del dispositivo e il meccanismo di navigazione farraginoso. A complicare ulteriormente l’esperienza c’è il fatto che il numero di telefono da cui si chiama e si ricevono i messaggi non coincide con quello del proprio smartphone. Anche qui l’elenco di cose che il prodotto non è ancora in grado di fare è abbastanza lungo. L’AI Pin non può infatti impostare un timer o una sveglia o aggiungere eventi al calendario. Humane ha fatto sapere che la società sta esaminando i feedback e risolverà alcuni dei problemi con i prossimi aggiornamenti software. In attesa di novità, il giudizio degli esperti è stato netto.
«L’AI Pin è un’idea interessante che è talmente incompiuta e inadeguata che non riesco a pensare a nessuno a cui consiglierei di spendere i 699 dollari necessari per acquistare il dispositivo e i 24 dell’abbonamento mensile», ha scritto David Pierce del portale The Verge. Ancora più drastico lo youtuber Marques Brownlee, secondo cui si tratta del «peggior prodotto che ho mai recensito». «Pessimo in quasi tutto ciò che fa, praticamente sempre», ha aggiunto Brownlee, il cui canale conta 18,9 milioni di iscritti.
Il coro di critiche è stato tale da mettere in dubbio lo stesso futuro di Humane, che può contare tra i suoi investitori anche il capo di OpenAI, Sam Altman. L’anno scorso era stata valutata 850 milioni di dollari. Ora, poco dopo l’arrivo sul mercato del suo primo prodotto, sarebbe già alla ricerca di un acquirente. Secondo quanto riporta Bloomberg, il prezzo richiesto è compreso tra 750 milioni e 1 miliardo di dollari. Un livello che adesso potrebbe essere troppo alto.
Corsa all’anti-smartphone
Il flop dell’AI Pin non ha segnato solo una battuta d’arresto per Humane, che puntava su questo lancio per proiettarsi nell’Olimpo del tech. Ma anche per chi era alla ricerca di un prodotto che potesse rendere lo smartphone obsoleto, proprio come l’iPhone di Apple aveva fatto con i cellulari di Blackberry. Sono infatti anni che il settore da cui sono emersi il pc, il browser, lo smartphone non genera una novità che possa segnare una svolta di quella portata.
Nonostante le pressioni dei mercati, che hanno di volta in volta premiato le aziende impegnate nella ricerca di nuovi orizzonti, le “next big thing” degli ultimi anni hanno spesso incontrato difficoltà.
Come con il Metaverso su cui ha puntato Facebook, al punto da cambiare nome in Meta, abbandonato da molte aziende che avevano inizialmente deciso di investirci.
La stessa idea di dispositivi da indossare non è nuova. Sono passati poco più di dieci anni dalla debacle dei Google Glass, gli occhiali intelligenti che la società di Mountain View aveva lanciato nel 2013, per poi abbandonarli solo due anni dopo.
La stessa Google, diventata nel frattempo Alphabet, è nel pieno della corsa per l’intelligenza artificiale, dove sta incontrando qualche ostacolo. A metà maggio ha annunciato alcune novità al suo motore di ricerca, considerate le più importanti da anni. Si tratta di nuove funzionalità che sfruttano l’intelligenza artificiale per rispondere in maniera più diretta alle domande degli utenti. Una risposta al successo di OpenAI, legata da una partnership alla rivale Microsoft, e della sua ChatGPT.
Lo strumento, chiamato AI Overview, inserisce risposte testuali in cima ai risultati di alcune ricerche, combinando frasi generate dai suoi modelli di intelligenza artificiale con frammenti pescati dal web. Al momento è disponibile solo negli Stati Uniti mentre in altri Paesi, tra cuil’Italia, arriverà fra qualche mese.
Lo scopo è rispondere a domande più complesse e specifiche rispetto a quanto avviene con una ricerca normale. Appena lanciato, lo strumento ha però generato una grande quantità di errori che hanno subito fatto il giro dei social. Screenshot in cui Google consiglia di usare la colla per condire la pizza e di passare a una dieta a base di sassi sono diventati subito virali per poi essere ripresi dalla stampa.
Google è intervenuta aggiungendo un’etichetta alle risposte fornite con Overviews: «L’intelligenza artificiale generativa è sperimentale». Inoltre ha dichiarato di aver apportato «più di una decina di miglioramenti tecnici» ai suoi sistemi di intelligenza artificiale. Liz Reid, a capo dell’attività di ricerca del colosso tecnologico, ha ammesso che «sono certamente apparsi alcuni risultati strani, imprecisi o inutili».
Questo dopo che per qualche giorno i social si sono riempiti di screenshot pieni di consigli bizzarri. Ad alcuni è stato detto di mettere la colla nella salsa della pizza per evitare che il formaggio scivoli via. Ad altri è stato consigliato di ingerire almeno un sasso al giorno per aumentare l’assunzione di vitamine e minerali. Il primo suggerimento era preso da un post scherzoso pubblicato su un forum di Reddit più di dieci anni fa, mentre il secondo veniva da un articolo del giornale satirico The Onion.
In un caso l’agenzia di stampa Associated Press ha chiesto a Google quali funghi selvatici è possibile mangiare senza rischi e il motore di ricerca ha risposto con un lungo riassunto giudicato perlopiù corretto anche se,, secondo un’esperta citata dall’agenzia, mancava di «molte informazioni che potrebbero potenzialmente provocare l’insorgere di malattie o rivelarsi addirittura fatali».
Un altro esempio ha visto un ricercatore chiedere a Google quanti musulmani sono stati presidenti degli Stati Uniti. Il motore di ricerca ha risposto con una vecchia teoria del complotto: «Gli Stati Uniti hanno avuto un presidente musulmano, Barack Hussein Obama». Informazioni tratte da un capitolo di un testo accademico intitolato “Barack Hussein Obama: il primo presidente musulmano d’America?”. In questo caso ha trovato la fonte corretta ma l’ha interpretata nel modo opposto a quello voluto.
Risultati che possono apparire surreali ma che derivano dal funzionamento stesso dell’IA. Come spiegato da MIT Technology Review, la maggior parte dei modelli linguistici di grandi dimensioni (Llm), su cui si basano gli strumenti di intelligenza artificiale, provano a prevedere il termine successivo in una sequenza di parole. Questo li fa apparire espressivi ma li rende inclini a inventare. Dato che non hanno alcuna verità su cui basarsi scelgono ogni parola esclusivamente sulla base di un calcolo statistico. Ciò porta alle cosiddette “allucinazioni”.
Anche se Google apporterà miglioramenti a AI Overviews, potrebbe non esserci mai la certezza che le risposte siano esatte. Con il risultato di mettere in discussione l’attendibilità di quello che per Google rimane il prodotto di punta, la ricerca.