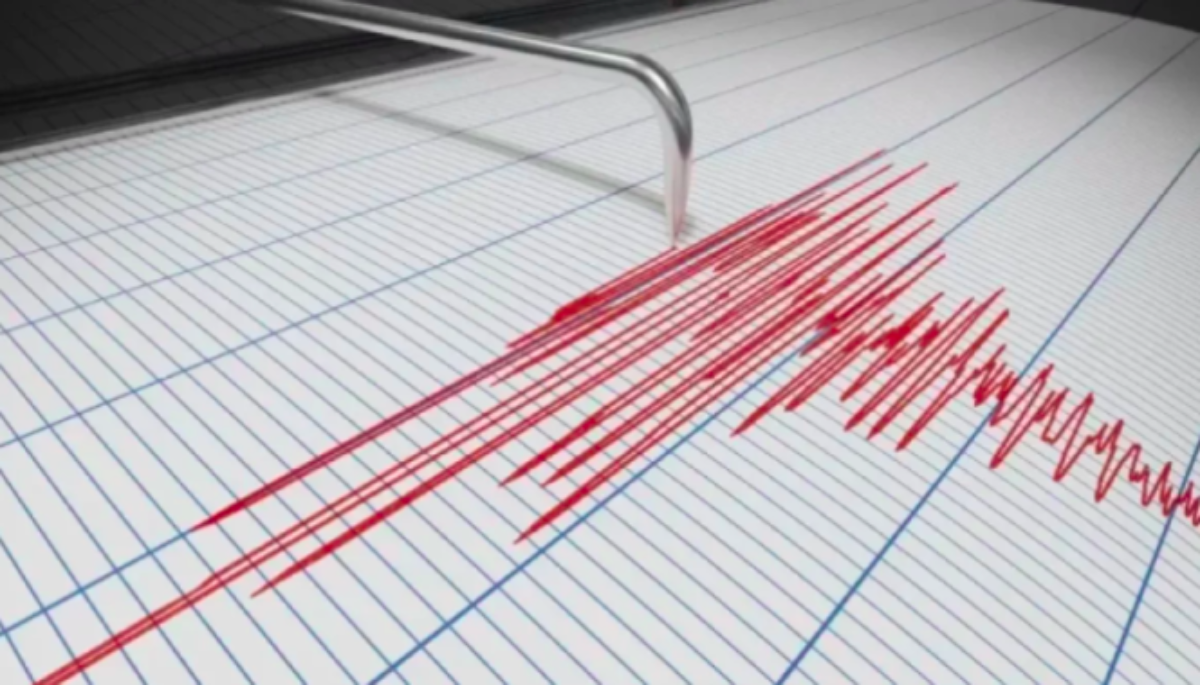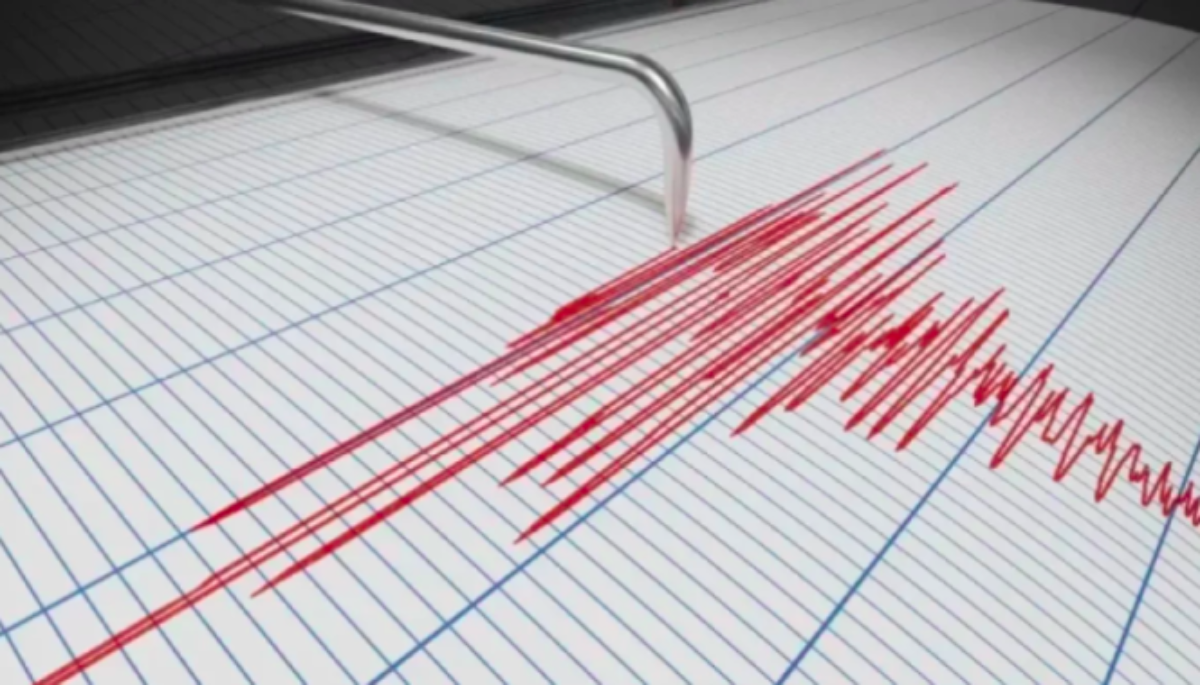La morti nel Mediterraneo e di Garissa sono la stessa storia

L'ondata incessante di migranti, il mancato soccorso per negligenza, le morti aggravate dallo scontro tra cristiani e musulmani: tutto fa parte della stessa storia
La strage di Garissa sta cambiando l’autocoscienza del Kenya come la strage di Westgate non era riuscita a fare.
All’università di Garissa il 2 aprile di quest’anno sono morte 150 persone per mano del gruppo estremista al-Shabaab: studenti, giovani, figli di famiglie che avevano riposto in quei ragazzi le speranze di tutti.
Giovani letteralmente di tutti i popoli, lingue e religioni del Kenya. Giovani che studiavano inseguendo il sogno di una promozione sociale, ma anche di un Kenya più giusto, dove tutti i cittadini possono avere gli stessi diritti.
Esattamente l’opposto dei loro assassini, rappresentanti di una società fanaticamente chiusa in se stessa e incapace di dialogo.
Ne sono state vittime anche musulmani, non solo fra gli studenti uccisi. Ne è stata vittima la mamma musulmana che abbiamo visto piangere disperatamente abbracciata alla salma del figlio, ucciso a Garissa.
La ferocia degli assassini non può più essere travestita da zelo religioso. Tutti gli altri musulmani adorano il vero Dio, misericordioso e benevolo.
I massacratori di Garissa invece erano gli esecutori di piani pensati da persone che non credono in Dio. Perché credono solo nel potere e nella ricchezza.
In questi giorni il governo del Kenya sta reagendo in modo scomposto, ansioso di mostrare che sta prendendo tutte le misure necessarie per accrescere la sicurezza, dopo la fallimentare gestione della crisi.
Eccolo, quindi, a sospendere i conti bancari di molte organizzazioni e Ong islamiche, senza peraltro provare che queste organizzazioni abbiano un qualsiasi legame col terrorismo.
Si è riproposto di chiudere entro tre mesi il campo dei rifugiati somali nel nordest del Kenya di Dadaab, rimpatriandoli tutti. Un’impresa titanica oltre che sbagliata, quasi impossibile da realizzare, anche da parte di un governo dotato di polizia e amministrazione efficienti e incorruttibili.
Ha annunciato solennemente che metterà in sicurezza la frontiera costruendo un muro – di altezza non specificata – non considerando forse che questo dovrebbe essere lungo oltre settecento chilometri, e porrebbe problemi enormi di costruzione, gestione e sorveglianza.
Un ministro ha addirittura proposto che prima di accedere all’università tutti gli studenti facciano un corso obbligatorio di antiterrorismo.
Non possiamo dimenticare che il terrorismo somalo contro il Kenya è stato scatenato dalla decisione, nel 2011, dell’allora presidente Mwai Kibaki di inviare in Somalia truppe kenyane – ufficialmente parte dell’Amisom (Missione dell’Unione africana in Somalia) – per ristabilire il potere del governo che si era installato nella capitale somala di Mogadiscio con l’appoggio delle potenze occidentali.
Gli Stati Uniti, in particolare, avevano fatto enormi pressioni sul presidente del Kenya Kibaki, garantendogli il supporto logistico per intervenire laddove l’esercito americano aveva miseramente fallito vent’anni prima. I kenyani vennero a sapere di questo intervento a cose fatte, quando i loro soldati erano già entrati in Somalia.
Oggi nessuno può dire con certezza quanti soldati kenyani siano morti in Somalia. Probabilmente molti di più degli studenti morti a Garissa, ma i veri numeri li conosce solo il Pentagono.
Ora il Kenya è stato lasciato solo a pagare il conto della violenza. La società civile kenyana, le Ong e le comunità religiose delle diverse fedi hanno assunto atteggiamenti più sfumati e ragionevoli rispetto al governo.
Sia nei mass media che negli ambienti che frequento, e sono i più vari, non ho sentito una voce in favore di risposte violente o meramente punitive.
Tutti capiscono che il cancro è anche interno: il mostro da abbattere è prima di tutto dentro di noi, e poi all’interno della società. Il grande mostro, da cui nascono tutti gli altri mali in Kenya, è la corruzione.
Personalmente ritengo che in questa crisi epocale dobbiamo abbandonare la logica della violenza e dimostrare di credere per davvero ai grandi principi che in Europa e America del Nord, più che altrove, sono cresciuti e sono stati codificati: giustizia sociale e diritti umani, democrazia, rispetto della vita di tutti.
Questi valori rappresentano una conquista di tutta l’umanità. Non possiamo permetterci di sospenderli neanche mentre resistiamo alla furia di un fanatismo ottuso e retrogrado.
Sappiamo però che nelle stanze dei bottoni delle grandi potenze predominano ancora altre logiche. Succede così che Paesi dal grande potere economico-militare si rivelino poveri di anima e di visione.
Potenze grandi nelle loro affermazioni e discorsi si rivelano meschinamente dedite alla difesa dei propri venali interessi. Grandi per il livello medio di vita, ma piccole, piccolissime perché succubi dell’economia e della finanza.
Mentre guardo sui giornali di Nairobi le foto degli studenti uccisi a Garissa, mi pare di sentire da loro un invito a uscire dalle logiche meschine, per guardare il mondo con occhi grandi e aperti. Occhi capaci di sognare, ma anche di leggere la storia.
Ecco perché il massacro di Garissa non può essere disgiunto dall’immane tragedia in atto nel Mar Mediterraneo.
L’ondata dei richiedenti asilo, i drammi delle centinaia di annegati, aggravati dalla disperazione di poveri musulmani che buttano a mare altri poveri cristiani e i morti per mancato soccorso perché nei corridoi del potere dell’Unione europea c’è ben altro a cui pensare: tutto fa parte della storia degli studenti di Garissa.
Della stessa storia fanno parte anche gli operatori della finanza, dell’economia e della politica che a New York, Washington, Londra, Parigi, Mosca, Milano e Pechino continuano a dividere il mondo in “noi” e “gli altri”. Così che chi in Africa estrae il coltan, coltiva le rose, produce il cacao o il tè e il caffè continui a vivere nella miseria più disperata.
— Leggi anche: la lotta agli scafisti non metterà fine alle morti in mare. Bruxelles deve adottare leggi che consentano più facilmente l’ingresso in Europa
Della stessa storia fanno parte i fabbricanti e mercanti di armi che hanno riempito questa nostra madre terra di ordigni sempre più sofisticati per uccidere, invece che di energia pulita, agricoltura biologica, informatica e pace.
E in questa storia ci sono anche i politici che seminano divisione e odio, che parlano di ributtare in mare gli immigrati, che hanno deciso di tagliare i fondi italiani ed europei alle operazioni di salvataggio in mare.
Le mani, probabilmente ben curate, di questi signori grondano del sangue dei loro fratelli come – anzi di più – quelle dei poveri disperati che scaraventano in mare altri disperati.
I signori della guerra che operano dalle grandi capitali del mondo, e che la guerra la fanno fare agli altri perché loro sono troppo occupati a far soldi, sono colpevoli delle sofferenze di questo nostro mondo almeno tanto quanto i signori della guerra della Somalia, del Sudan e della Libia.
Continueremo a rispondere alla violenza con una violenza ancora più grande, più pervasiva, meglio camuffata? Questa è ormai una scelta che siamo tutti chiamati a fare, come individui e come società.
Saremo capaci di fare tutti insieme un passo in avanti, di superare le divisioni e i confini e, almeno come ideale sia pur lontano, muoverci verso una comunità internazionale in cui veramente tutti abbiano gli stessi diritti?
Come reagire alla violenza e al pericolo non è dato sapere finché non ci si trova dentro.
Personalmente mi chiedo quale sarebbe la mia reazione se venissi a trovarmi faccia a faccia con un violento che vuole uccidermi. Tenterei una disperata difesa con la violenza?
O cercherei di far leva sul residuo di umanità che anche i più incalliti terroristi si spera abbiano nascosto in fondo al cuore?
Non lo so. Forse, per salvare altri a cui voglio bene, tenterei anche la difesa violenta. Ma vorrei sperare di poter reagire come hanno fatto i cristiani su quel barcone che si sono opposti alle violenza di chi voleva gettarli in mare.
Che si sono avvinghiati l’un l’altro, come hanno fatto quei quaranta giovani, seminaristi burundesi, che nel 1995 in risposta a chi voleva separarli lungo linee tribali, hanno preferito morire abbracciati, o come i lavoratori egiziani decapitati in Libia pronunciando il nome di Gesù.
Sono comunque contento della compagnia in cui mi trovo. Domenica scorsa a Kivuli, nell’estrema periferia di Nairobi, ho passato il pomeriggio ad ascoltare giovani che sono stati travolti dalla povertà, dalla droga, si sono invischiati nella piccola criminalità, per progettare insieme il loro futuro.
Ho trovato persone capaci di sorridere di se stesse, di piangere, di gridare disperate, di voler bene, di impegnarsi a cambiare. Esseri umani, vivi e veri, che sfidano anche me a essere vivo e vero.
Persone, coetanee degli studenti di Garissa, che puzzano di povertà. Insieme a loro, anch’io, e tutte le persone che magari pensano di non essere coinvolte in questa storia, voglio che ci liberiamo dalla puzza di corruzione, di odio e di morte che tutti – nessuno escluso – ci portiamo addosso.
— Leggi anche: la testimonianza di un rifugiato somalo in Italia sul perché i migranti decidono di intraprendere il viaggio della speranza in mare