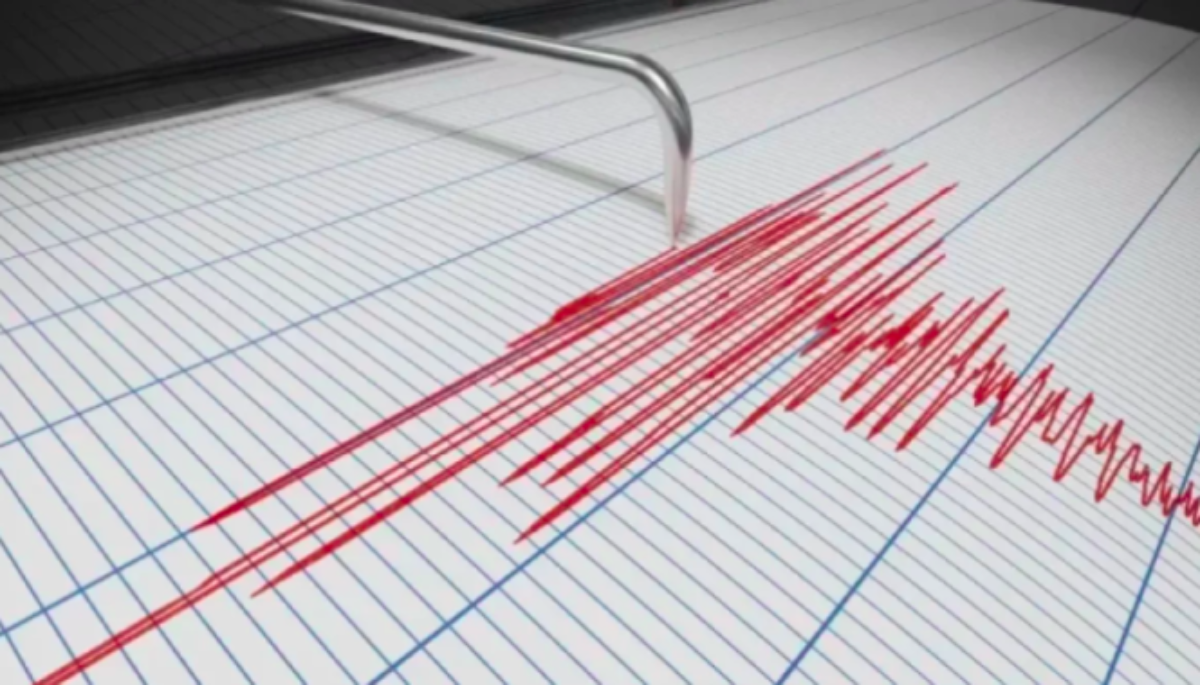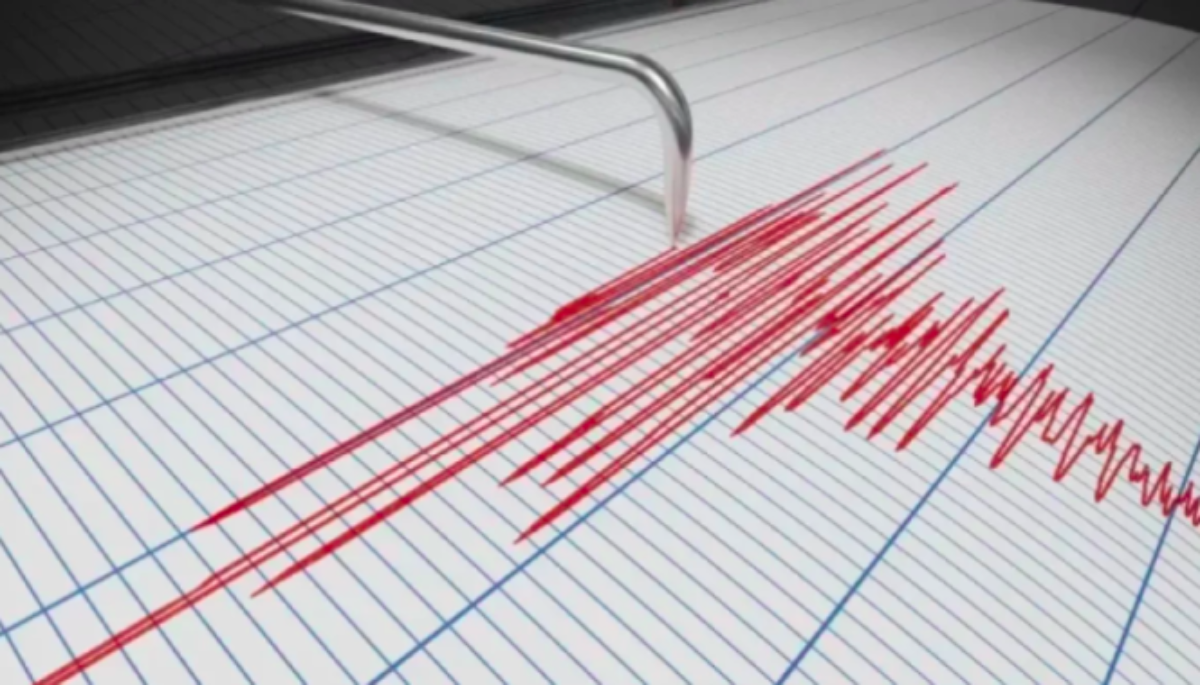Quando c’era Berlinguer

Un film con molte fallacie su un uomo dagli innumerevoli pregi
Berlinguer è uno scrittore. Un commissario. Un francese. Non lo so chi è Berlinguer, non mi interessa. Così rispondono i ragazzi e gli adulti nelle interviste che aprono il documentario, così risponderanno dopo averlo visto. Veltroni, infatti, ha dato molto per scontato, sopravvalutando il suo pubblico e non adempiendo alla funzione educativa che il documentario, per definizione, è chiamato a svolgere. Si tratta di un film per pochi, creato per chi Berlinguer lo ha vissuto e per chi da sempre, come me, ha sentito parlare così tanto di lui sino a provare un sincero affetto. La ricostruzione storica risulta confusa e soggettiva, non ci si dimentica mai di Veltroni, appostato lì dietro con sguardo nostalgico.
Dal punto di vista cinematografico il documentario è fallimentare, intriso com’è di volgari i lirismi e di indulgi poetici. “Tutto quello che hai visto ricordalo, perché tutto quello che dimentichi torna a volare nel vento”, sussurra una voce roca nella scena iniziale, seguita da fogli di giornale che rotolano su un prato accompagnati dal suono di un pianoforte melenso. Buone le parti strettamente documentaristiche, i filmati d’archivio, i frammenti di vecchie interviste e dei dibattiti televisivi. È qui, e non nel meccanismo narrativo forzato, che viene in luce il personaggio carismatico, dal sarcasmo intelligente e dall’etica di ferro. “Siete stati coraggiosi soltanto quando vi nascondevate dietro le S.S.”, ribatte B. a un giornalista del Secolo d’Italia. Le sue parole sono composte, sentite, oneste. Parla con fermezza e ha gli occhi puliti e buoni. Era timido, ma come un martello che non fu mai incudine. Ingenuo, integerrimo, sobrio, un uomo eccezionale, questo dicono di lui.
L’impresa di Veltroni aveva un onere: quello di far comprendere cosa fu il comunismo in Italia, al di là dei luoghi comuni, e cioè un comunismo troppo filosovietico per gli americani e troppo filoamericano per i sovietici. Enrico Berlinguer, che incarnò l’esperienza italiana di comunismo, ai sessant’anni della rivoluzione d’ottobre era in Russia e, davanti all’intera assemblea parlò con il coraggio che lo contraddistingueva: “la democrazia è il valore storicamente universale sul quale fondare un’originale società socialista”. Non c’era, in lui, l’incoerenza tipica di chi deve mostrarsi a tutti i costi coerente con le idee del partito. Per lui esistevano i bisogni veri e le soluzioni reali. Dopo la morte di Allende e i fatti del Cile, Berlinguer capì di doversi affiancare alla DC e promosse il compromesso storico, ma perseverando, tuttavia, nel sostenere il no all’abrogazione del divorzio. “Perché bisogna permettere allo Stato italiano di legiferare autonomamente in materia matrimoniale?” Le sue frasi iniziavano sempre con un noi, mai con “io penso” o con “io farò”, come troppo spesso oggi succede.
Ne La mafia uccide solo d’estate il caro Pif è riuscito a commuovere gli spettatori senza particolare fatica o ingegno, con il semplice escamotage di portare la narrazione al suo apice ponendo in chiusura gli attentati di Falcone e Borsellino. Veltroni, invece, gioca immediatamente la carta del climax e utilizza le immagini del funerale nelle prime scene del film. Non mancano momenti di empatia, come la notte in cui l’Unità uscì con l’edizione speciale Un italiano su tre vota comunista, quando il PCI era al suo massimo storico. Poi il declino, fino al comizio di Padova del 1984, quando Enrico viene colpito da un ictus e continua a parlare, tra i grandi sforzi, tra i basta della piazza che teme l’inevitabile.
Un documentario che resta, tuttavia, da vedere, perché le sue non poche fallacie non sono tali da nasconderne i pregi.