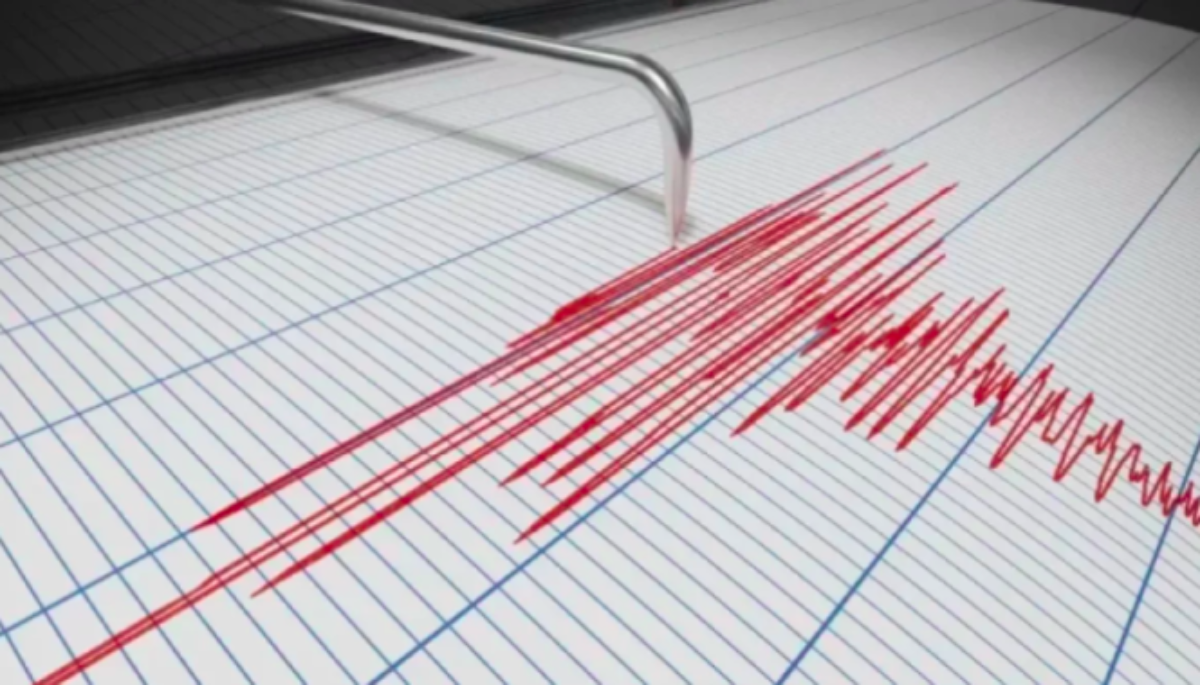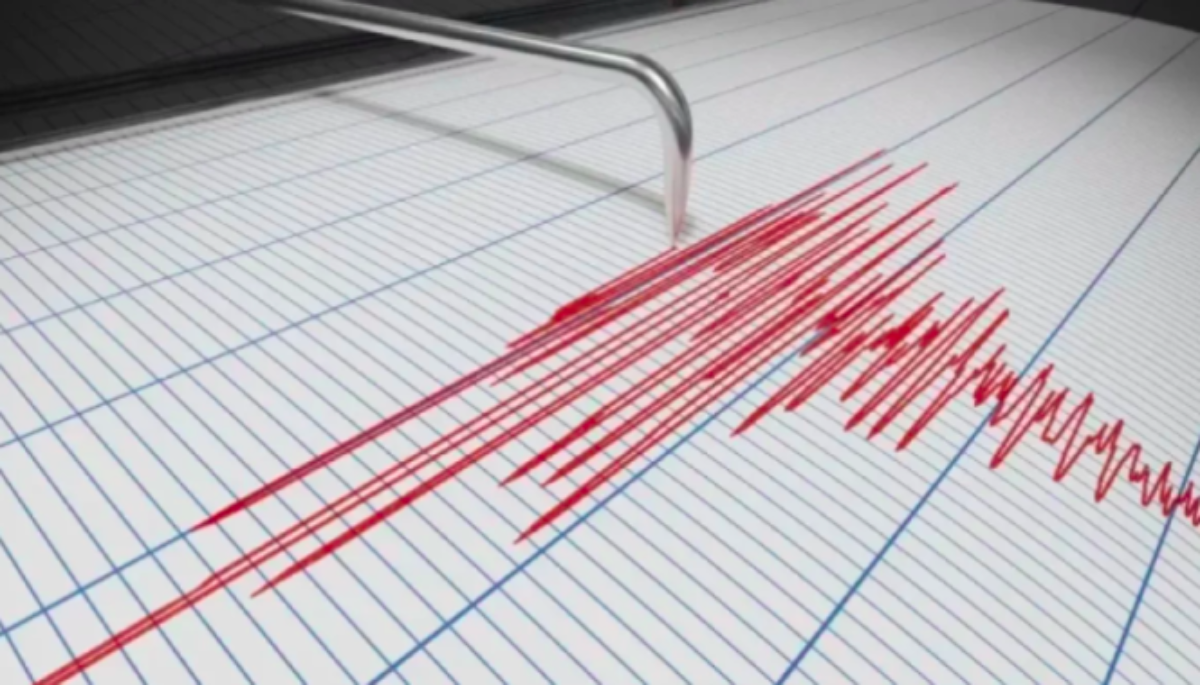Populismi confessionali

Il contagio libanese della crisi siriana
Mai come nelle ultime settimane un potenziale contagio libanese della crisi siriana è stato percepito tanto prossimo alla soglia di un’ineluttabile degenerazione violenta.
L’eco internazionale è amplificata anche dal pesante coinvolgimento degli Hezbollah libanesi accanto alle truppe del regime di Asad nella battaglia di Qusayr, cominciata il 19 maggio scorso e tuttora in corso. In questi giorni dalla Siria oltre un centinaio di “martiri” – combattenti di Hezbollah morti sul campo – sono tornati nei loro villaggi d’origine, nella valle della Bekka e nel sud del Libano, avvolti nelle bandiere gialle e verdi del Partito di Dio, “legati stretti perché sembrassero interi”, per citare un grande cantautore genovese. Ieri, tornando da Sour (Tiro), nel sud, ho per caso incrociato uno dei tanti cortei di dolore, mentre contemplavo, imboccando l’autostrada verso Beirut, le gigantografie su sfondo giallo dei giovanissimi andati a morire per difendere il regime di Asad.
Mi sono chiesta tante volte in questi ultimi due anni se fossimo giunti ad un tornante in cui la maturazione storica dello stato libanese potesse infine liberarlo dalla maledizione del “buffer state” (‘stato cuscinetto’, alla mercé degli interessi delle potenze regionali) e, soprattutto, dalla sua congenita dipendenza dalla Siria – impossibile da comprendere senza considerare che i confini del Libano sono stati ritagliati dalla grande Siria neppure un secolo fa, dividendo de jure in due una società che si sentiva de facto “una”.
E’ la tensione tutta interna alla società libanese che mi ha fatto porre tante volte questa domanda: la volontà di un Libano sovrano, figlio della “Primavera dei Cedri” (la rivoluzione che nel 2005 pose un termine a 29 anni di occupazione militare siriana), è fortemente presente nella società libanese e si oppone a quella che sente le sorti del Libano inevitabilmente dipendenti da quelle di Bashar al-Asad. I primi sono spesso gli stessi che chiedono di de-confessionalizzare il sistema politico, rimpiangendo una “modernizzazione mancata”, in cui la tradizione stride con le macchine, i vestiti sgargianti e il lusso dei grattacieli di Beirut. Li ho ascoltati tante volte questi libanesi deprecare i politiciens chiusi nel palazzo di Baabda, senza distinzioni confessionali o partitiche (che, tral’altro, quasi sempre coincidono), che prendono ordini indistintamente dalla invadente Damasco, per poi rendermi conto che, in un modo o nell’altro, nessuno in Libano riesce sinceramente a non parteggiare, a non sentirsi emozionalmente coinvolto in un conflitto troppo vincolante per il destino politico di questo paese perché ce ne si possa disinteressare o, semplicemente, lo si possa guardare con distacco intellettuale. I razzi caduti la settimana scorsa su Dahye (la periferia di Beirut abitata prevalentemente da sciiti) e Hermel, due roccaforti di Hezbollah, hanno pericolosamente avvicinato il Libano a quella linea rossa oltre la quale diventerebbe assai difficile tornare indietro. Pochi giorni fa, percorrendo la strada centrale di Tarik Jdideh, il quartiere di Beirut fedelissimo all’ex primo ministro Saad Hariri – il pupillo del re saudita e anche dei nostri governi occidentali – ho visto sventolare bandiere di al-Qaeda. E’ una immagine concettualmente inscindibile da quello che, ancora una volta, succede oltreconfine: il coinvolgimento sempre più evidente nel conflitto siriano di gruppi sunniti, come la Jabhat al-Nousra, affiliati al grande gruppo terrorista. E’ proprio questa confessionalizzazione del conflitto che sta ora coinvolgendo il Libano, le sue istituzioni e, soprattutto, la sua società.
C’è una perversa dinamica – tutta esogena – che ha così velocemente trasformato la thawra (‘rivoluzione’) siriana da non lasciarci neppure il tempo di accorgerci che i giovani di quel paese, ispirati dai giovani tunisini, egiziani, libici, avevano iniziato una lotta “nazionale” contro la corruzione, la diseguaglianza socio-economica e la coercizione opprimente delle mukhabaràt (i pervasivi “servizi di intelligence”), di cui il regime di Asad è unico responsabile. Ma il conflitto siriano è diventato assai presto fitna, una guerra tra sunniti e sciiti, catalizzata dai ricchi emiri del Golfo che finanziano una resistenza “sunnita” contro un regime alawita (una declinazione minoritaria della Shi’a), alleato del regime di Teheran, il quale per parte sua, difendendo Asad, non sta facendo altro che difendere i propri interessi geopolitici. La penetrazione di stranieri nelle fila della resistenza, provenienti dal mondo arabo, Libano incluso, e dal resto del mondo (pochi giorni fa abbiamo scoperto che c’era anche una donna americana convertita all’Islam a combattere contro Asad) così come il coinvolgimento degli Hezbollah, ha alterato il senso della rivoluzione siriana, rendendola un affare regionale e, pericolosamente, confessionale.
E mentre l’ennesimo sheikh del Qatar incita a difendere Qusayr dalle forze di “questi sciiti, più infedeli dei cristiani e degli ebrei” (cit. Sheikh Yusef al-Qaradawi), il Libano si trova inevitabilmente trascinato non soltanto nelle sorti incerte della Siria madre, ma in una dinamica assai più vasta, i cui la realpolitik di regimi tra loro nemici fa del populismo a base confessionale la sua principale arma di mobilitazione delle masse e di politica internazionale.
Ed è proprio da questa manipolazione che si sta lasciando travolgere il Libano – un paese in cui il sistema partitico, basato sulle quote confessionali, rende la religione visceralmente legata alla politica – auto-condannandosi, per l’ennesima volta, a far da cassa di risonanza di tensioni e interessi ben più grandi dei suoi confini.