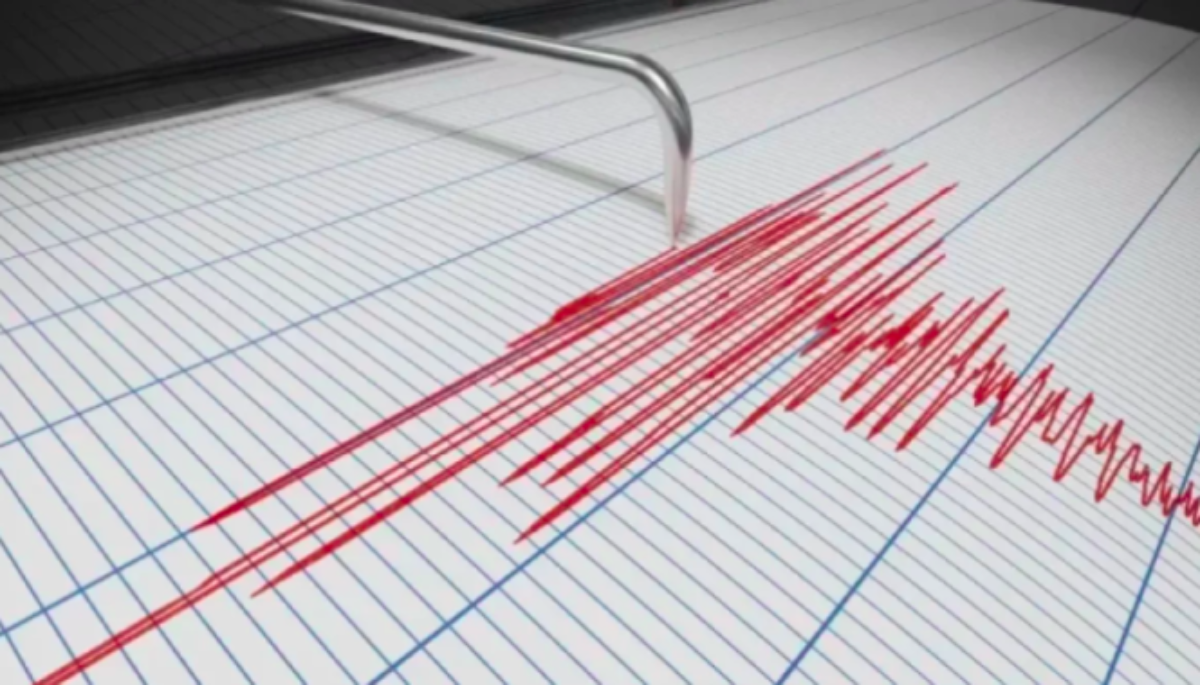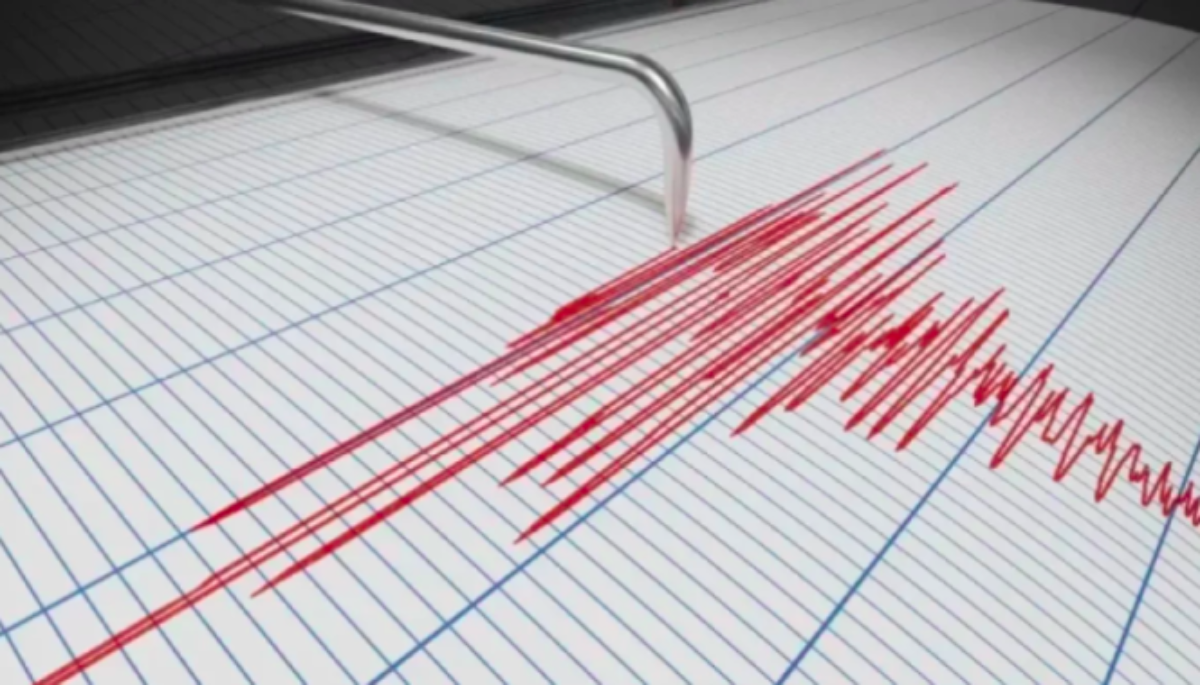La solitudine fuori del ring

"Un pugile al tappeto è l’uomo più solo al mondo”
La solitudine fuori del ring
“Stick, stick, stick” .
Angelo Dundee, il coach di Mohammed Ali, ripeteva queste tre parole fino allo sfinimento.
Nella boxe il miglior allenatore non è quello che ti fa da sparring, ma quello che ti parla, che ti urla in faccia, che commenta ogni tuo gesto sbagliato.
“Pick him off, pick him off” .
La prima distinzione che impari quando ti innamori di questo sport è che esistono i fighters e i boxers.
I primi sono quelli che avanzano, che fanno male.
I secondi sono quelli che schivano i colpi, agili e veloci, ma che non hanno un pugno in grado di stenderti.
Carlos Monzón è stato un fighter così come Giovanni Parisi.
Due destini che hanno moltissimo in comune, come raccontano due recenti biografie (“Monzón: il professionista della violenza” e “Il pugno invisibile. Essere Giovanni Parisi”).
L’infanzia povera, gli anni di fatica in palestra, i grandi combattimenti, il titolo mondiale, il denaro, la fama.
E soprattutto la solitudine che li aspetta al varco quando capiscono che è ora di appendere i guantoni al chiodo.
Diceva George Foreman che “un pugile al tappeto è l’uomo più solo al mondo”, ma è sempre meglio la solitudine nel ring che fuori.
Oltre la boxe per Monzón c’è solo la noia di Belgrano, il tentativo di reinventarsi importatore di auto di lusso, il ritorno nella Santa Fe degli origini, l’omicidio della moglie per cui viene condannato a undici anni di carcere.
Per Parisi i vecchi filmati degli incontri da rivedersi nella casa di Voghera, in attesa di rilanciarsi come organizzatore.
Uno scontro frontale in macchina segna la fine prematura di due straordinari campioni a cui è mancato il riflesso nell’ultima schivata, la più importante, quella in cui ti giochi la vita.