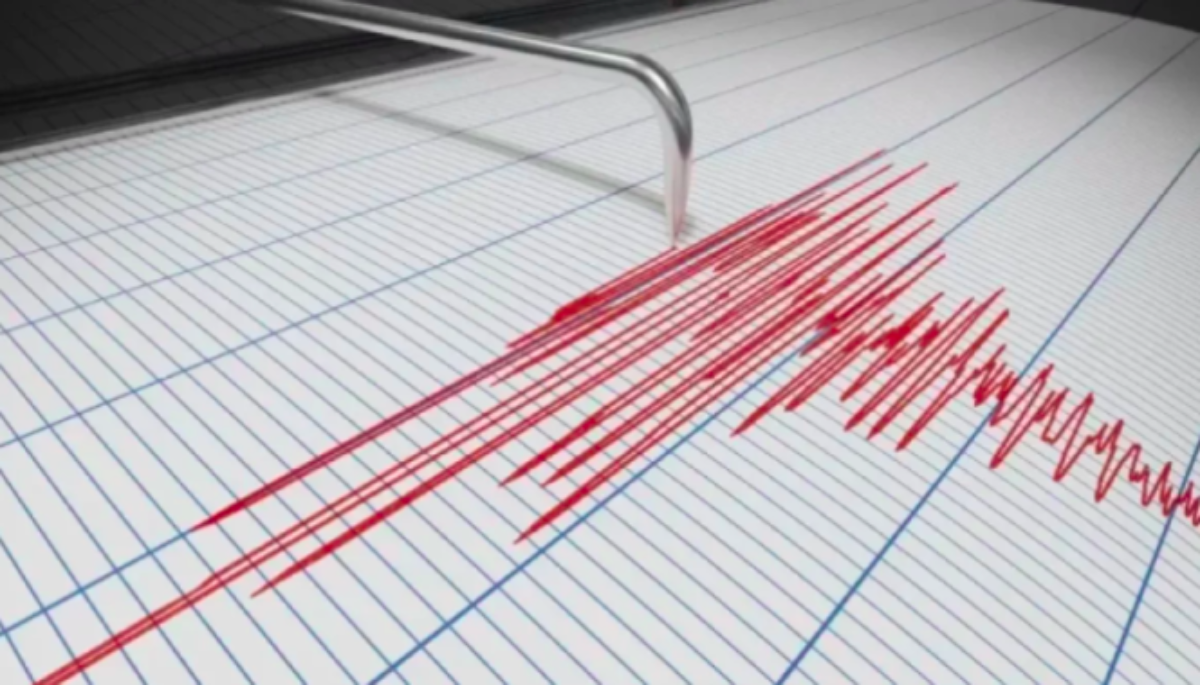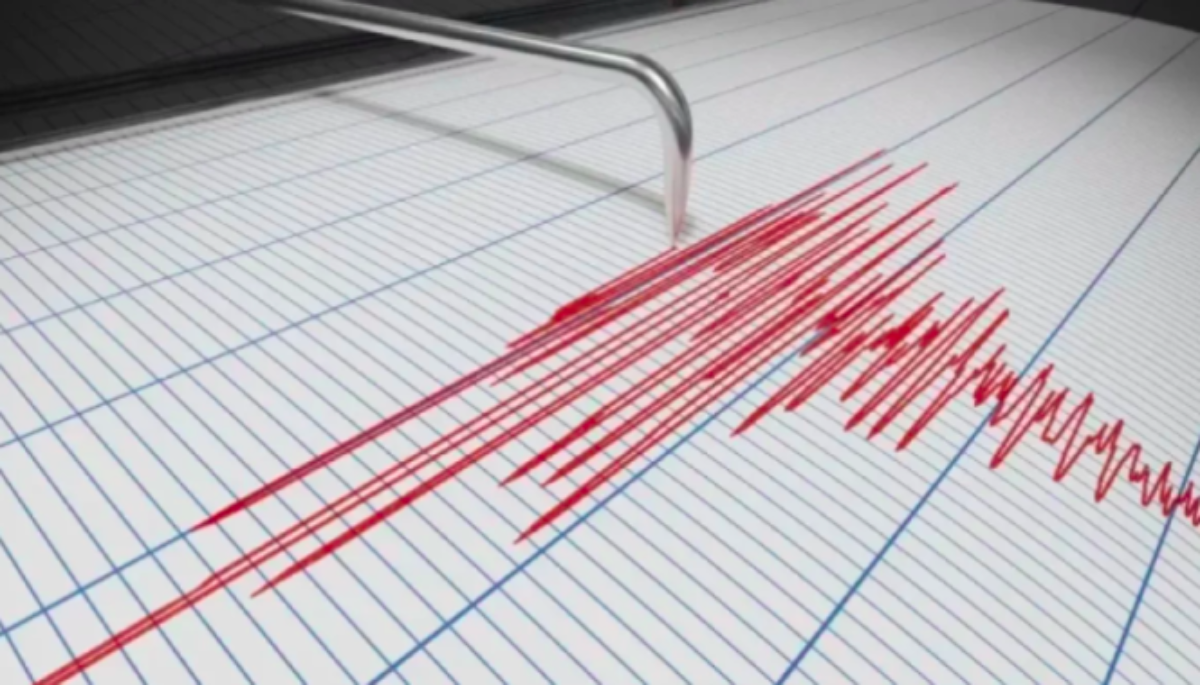La mia classe

Una classe di immigrati, un film impegnato tra fiction e realtà
La mia classe di Daniele Gaglianone è un film dal sapore aspro, a metà strada tra fiction e documentario. Con l’irruzione all’interno della vicenda di un elemento tragico e non previsto, si interroga sul significato stesso del cinema e più in generale dell’arte a confronto con la vita vera, precaria, ingiusta di chi lascia la propria terra per tentare di salvarsi.
A parte l’insegnante (interpretato da Valerio Mastandrea), tutti gli altri sono extracomunitari cui è stato chiesto semplicemente di interpretare se stessi (Bassirou Ballde, Mamon Bhuiyan, Gregorio Cabral, Jessica Canahuire Laura).
Una classe composta da persone che provengono dal Brasile, dall’Iran, dall’Egitto, dall’Africa, dalle Filippine, dall’Ucraina, dal Bangladesh, a cui l’insegnante impartisce lezioni di italiano partendo da quelli che sono i loro bisogni: come cercare lavoro, come chiederlo, fino a che punto sottostare all’indubbio sfruttamento che troveranno come unica alternativa alla fame e al rimpatrio. Nella prima parte del film vediamo solo la superficie, le frasi alla lavagna, il balbettio, le risate di fronte agli errori in italiano, le correzioni del professore. Man mano la scena si fa più perturbante, attraverso le note del brano L’autostrada di Daniele Silvestri vengono fuori i ricordi, il detto e soprattutto il non detto, il distacco, gli affetti abbandonati, le ferite profonde, talvolta insanabili. Poi la realtà irrompe sul set e spinge il film in una dimensione meta-narrativa. Uno di loro riceve un decreto di espulsione, ha il terrore negli occhi. A questo punto il regista stesso si interroga su quale sia l’utilità del proprio film di fronte all’evento. La troupe cinematografica entra quindi a far parte del set e racconta la pura verità.
In un’intervista, durante il Festival del Cinema di Venezia, il regista dichiara di non sentirsi un militante di nessun tipo, ma di indagare su quelle sfere dell’esistenza che hanno per oggetto il rapporto con il mondo, un rapporto che lui stesso avverte come conflittuale. Il conflitto s’innalza per la brutalità con cui i fatti si scaraventano sulle inessenziali progettualità. Questo film si sarebbe dovuto concludere in altro modo ma il reale ha superato la fiction. Il finale non può non essere condizionato da quel decreto, da quel pezzo di carta, così piccolo eppure così pesante. Un pezzo di carta capace di relegare un essere umano, senza che nulla abbia compiuto, nella sfera dell’illegalità. E sembra di essere in un romanzo di Orwell o Kafka, dove invisibili organi istituzionali condannano impietosamente persone in carne e ossa, la cui unica colpa è quella di esistere.
Un meta-film con un linguaggio completamente nuovo, non pretenzioso, vero, impegnato. Non può che lasciare con un senso di amaro in gola, e la metafora finale sul tradimento mette lo spettatore nella condizione di sentirsi parte di quel tradimento. “Anche se voi vi credete assolti siete lo stesso coinvolti”, cantava De André.
di Ilaria Palomba