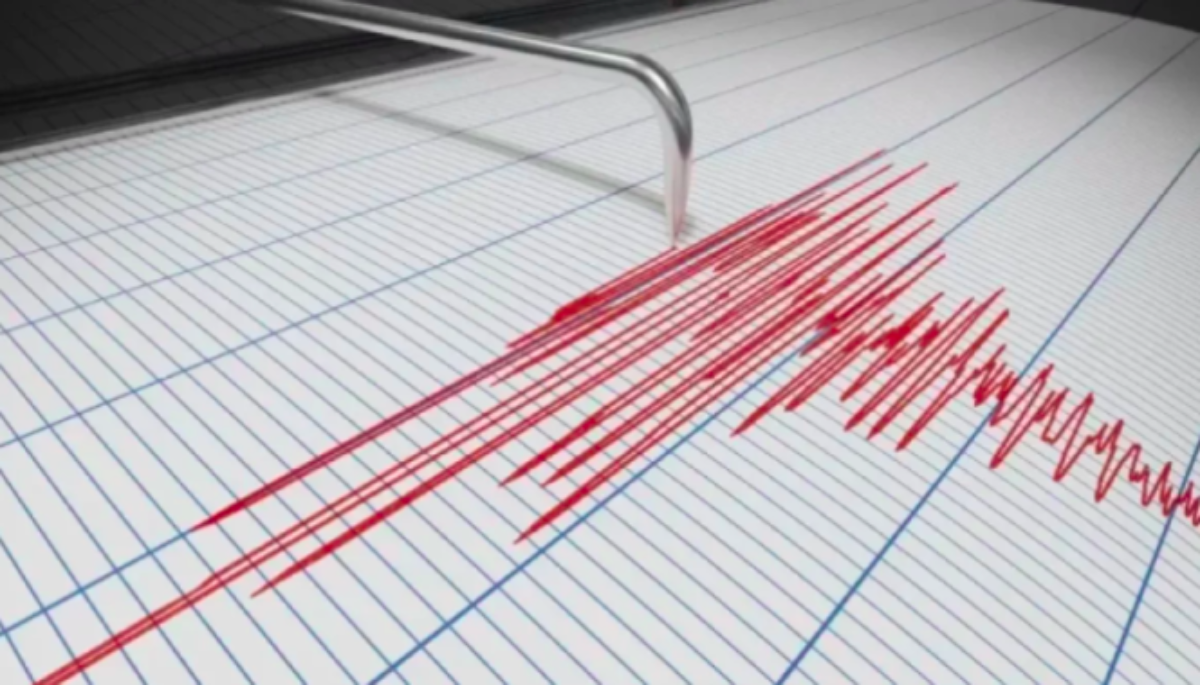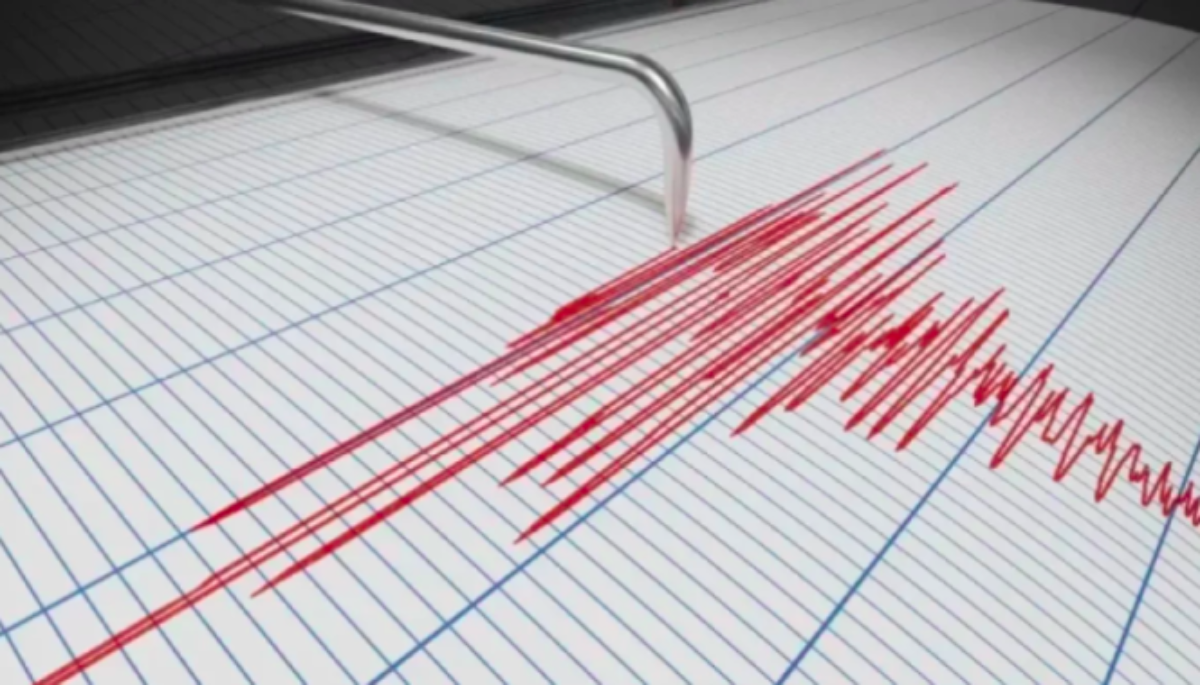Cronaca di una sconfitta annunciata

Al ballottaggio olimpico di Buenos Aires, Istanbul ha perso a Gezi
Mentre ieri ‘Istanbul 2020’ si giocava a Buenos Aires le ultime, disperate chances di non gettare al vento la sua occasione storica, a Istanbul la polizia cingeva ancora una volta d’assedio la zona del parco Gezi per tenerlo chiuso agli istanbulioti. Stanno qui, in questa immagine parallela, le radici profonde della sconfitta turca. Al ballottaggio del sogno olimpico, Istanbul aveva perso più di tre mesi fa, con la gestione repressiva e sciagurata delle proteste popolari da parte del premier Tayyip Erdoğan. Lui che con decisivo ritardo l’ha forse capito – ma non sembra per questo intenzionato a una marcia indietro rispetto alle agitazioni che sono sul punto di riesplodere – già prima del voto aveva definito il raggiungimento della finale “un importante successo”.
La vittoria senza partita di Tokyo (60-36 nel testa a testa decisivo) sembrava certo più difficile fino a fine maggio, quando Erdoğan inaugurava in pompa magna i lavori per il terzo ponte sul Bosforo e prometteva un fiume di investimenti per rivoltare la sua Istanbul in vista del traguardo olimpico: 2,9 miliardi di dollari solo per impianti e nuove strutture, e quasi una ventina per le infrastrutture da realizzare nel prossimo decennio, quello che conduce al fatidico 2023, centenario della Repubblica. I soldi – biglietto da visita graditissimo ai membri del Comitato olimpico internazionale – non erano insomma il problema del quinto tentativo consecutivo della metropoli sul Bosforo, il primo con vere possibilità di successo.
Anzi, con un occhio alla geopolitica, Istanbul era forse la favorita. Equilibri regionali ed economie emergenti, Siria ed entusiasmo dei giovani turchi. La mano da giocare al tavolo di Baires pareva vincente. Con l’asso, già svelato un anno fa da Erdoğan all’inaugurazione dei Giochi di Londra: “Il primo Paese musulmano a ospitare le Olimpiadi”. Una candidatura che certo suonava più suggestiva – se non più autorevole – rispetto a quelle della derelitta economia madrilena e delle nuove fragilità giapponesi.
Pareva non pesare troppo neppure la competitività periferica dello sport turco a cinque cerchi, che nel medagliere di Londra 2012 si è fermato al 32esimo posto (meglio comunque del 2008). Non a caso, la testimonial di Istanbul è stata la tennista Çağla Büyükakçay, numero 138 del ranking Wta: non proprio Maria Sharapova. Eppure, la prima selezione nella shortlist del Cio dopo quattro tentativi andati a vuoto tra il 2000 e il 2012 è arrivata sull’onda lunga di una popolarità crescente nei media – e nella finanza – internazionali. Un’atmosfera che suggeriva la retrocessione dei problemi più evidenti, dai trasporti infernali alle lobby deboli.
Insomma, Istanbul avrebbe davvero potuto farcela, contando anche sulla spinta del policentrismo che già aveva premiato Rio per il 2016: tra le candidate, era l’unica a non aver mai ospitato i Giochi. Insieme allo slogan, “Bridge together”, c’era il quid che il ministro dello Sport, Suat Kılıç, descriveva così: “Istanbul offre alle Olimpiadi ciò che nessuna altra città può offrire: organizzare i Giochi su due continenti”. Poi, è arrivato l’autogol di Erdoğan a Gezi. E Istanbul, che non è Pechino, ha perso.