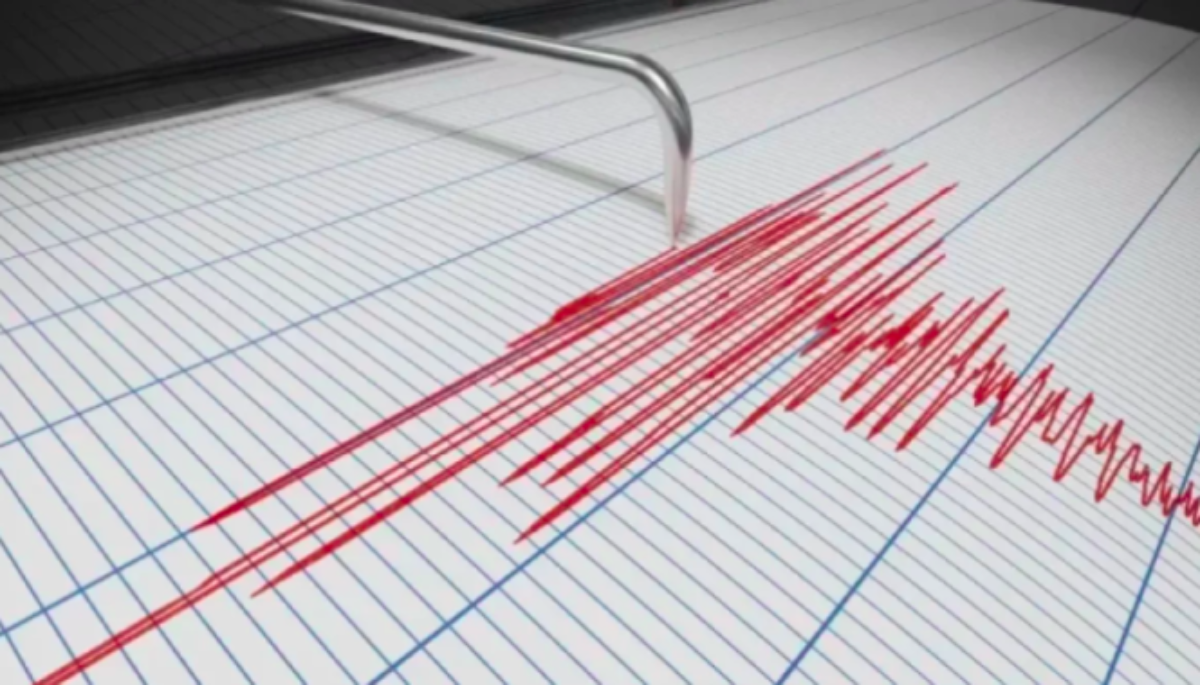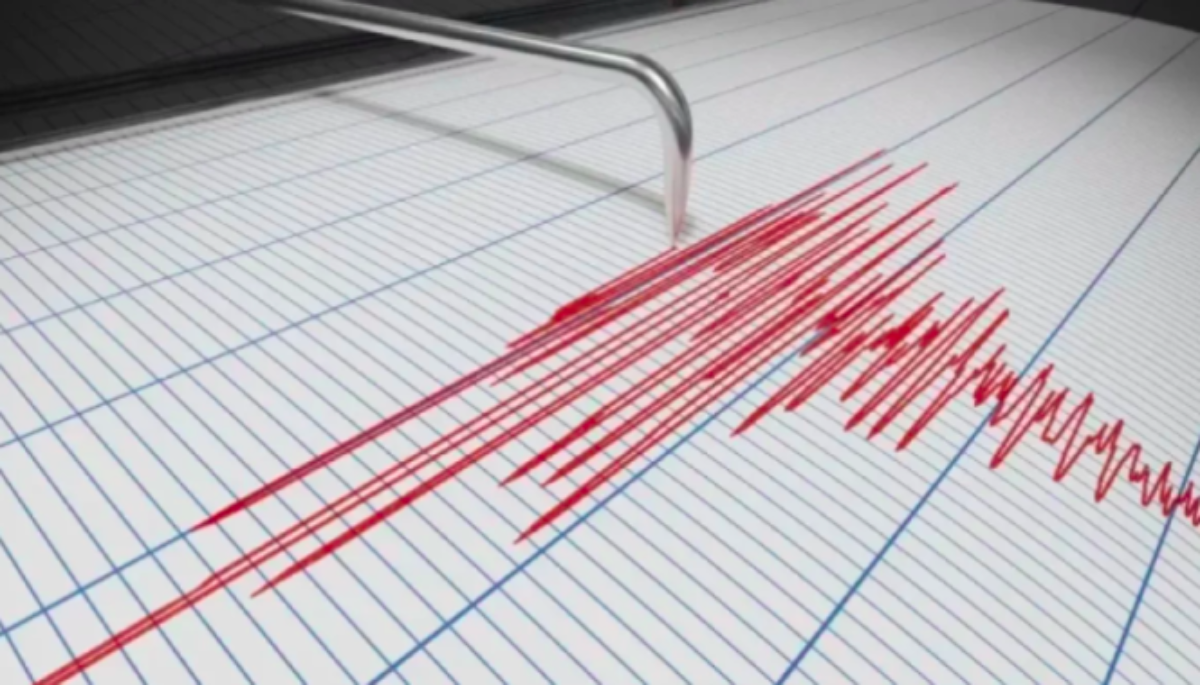A proposito di Davis

Un’Odissea dal retrogusto amaro che rapisce
Un fatato gatto rosso che si aggira per la casa e fa perdere le sue tracce è il motore narrativo di Inside Llewyn Davis (A proposito di Davis), il nuovo film ispirato alla storia vera del cantante folk Dave Van Ronk dei fratelli Joel ed Ethan Coen.
New York, anno 1961. È il periodo immediatamente precedente all’ascesa di Bob Dylan, quando il folk era ancora una galassia semisconosciuta e gli Stati Uniti il luogo d’incubazione di una rivoluzione culturale senza precedenti, latente e inarrestabile. A proposito di Davis narra la storia di Llewyn Davis, malinconico musicista folk del Greenwich Village con pochi quattrini e tanta passione che tenta la fortuna invano con copiose porte sbattute in faccia, respingenti grugniti tra lo sfottò e il discredito, insulti a gogò da un mondo incavolato – e non a torto – e ingenti metafore scatologiche. L’amico con il quale suonava è morto suicida e il suo album da solista stenta ad affermarsi. Quella di Llewyn Davis è un’esistenza condotta dove capita e senza altro scopo se non quello di emozionare con la propria musica.
Llewyn si esibisce spesso al Gaslight Café, locale dalle tinte fosche e pieno di fumo, girando continuamente da una casa all’altra e dormendo su divani polverosi e malmessi. Un bel giorno capita a bordo di un’auto alla volta di Chicago per un’audizione con il barone del folk Bud Grossman, condividendo il viaggio – e tutti i suoi innumerevoli inconvenienti – con due tipi strani, un giovane scontroso che non proferisce parola e un musicista di jazz grottesco e viscido armato di bastone. Lo schietto commento di Grossman, dopo un’intensa performance, “non vedo soldi in quella roba lì” corona il totale fallimento del protagonista, che torna alla sua vita di sempre, tra facce torve e locali infognati.
Il bravissimo attore e cantante Oscar Isaac interpreta un personaggio pallido e indifferente che non ispira pietà o simpatia, salvo poi incantare il pubblico non appena sfiora le corde della chitarra e accosta le labbra al microfono. Ecco che l’incantesimo si compie e nel silenzio del Cafè (e in sala) irrompe una melodia dolce, malata, autodistruttiva, fatta di taglienti bagliori di poesia e ipnotici giri di accordi. A occhi chiusi, una luce visionaria sembra rischiarare le tenebre di un’esistenza precaria da outsider senza rimedio. Basta una voce profonda, la musica giusta e il gioco è fatto. Le carte delle emozioni si scombinano e il potere della musica – durante la breve catarsi di un concerto dal vivo – capovolge l’apatia in sogno, il vuoto in pieno, il buio in luce folgorante, struggente. Onnipresente il gatto rosso, salvo poi scoprire che non si tratta affatto di “Ulisse” (il gatto scomparso), ma di un altro gatto, un gatto “qualsiasi”. I Coen si divertono a mescolare scambi d’identità e caso. Tutto è casuale e aleatorio in questa vita e definire è irrilevante e arbitrario, sembrano suggerire i due fratelli del Minnesota. La chitarra è lo scoglio cui aggrapparsi in un insensato “mare-vita” che tutto e tutti travolge e che procura un sussulto, quel brivido folgorante che solo l’arte autentica è in grado di trasmettere. Come se le barriere tra gli individui crollassero d’improvviso in quei brevi, luminosi sprazzi d’intensità musicale e avvenisse una prodigiosa fusione fra anime.
A proposito di Davis fotografa la fibrillante scena musicale newyorkese d’inizio anni Sessanta ed è il ritratto ruvido e disastrato di un artista condannato a una sepoltura da vivo, un perdente disilluso arrivato troppo presto che si esprime dove e come può per amore dell’arte per l’arte, e forse veramente coerente con il vero spirito del folk. È un’antistoria circolare che non porta da nessuna parte né produce alcun cambiamento nella vita del protagonista, in un vacuo girare a vuoto – in perfetto stile coeniano – dove fine e inizio perfettamente coincidono. Un cerchio magico sulle tracce di una creatura sfuggente, un sogno come in Alice o un flashback nel quale l’unica vera protagonista è la musica – bellissima l’interpretazione live di Oscar Isaac di Hang Me, Oh Hang Me. D’altronde, “Se non è nuova e se non invecchia mai, allora è una canzone folk”.
I Coen si riconfermano grandi osservatori della società e cantori della bellezza e dell’arte, attingendo com’è nel loro stile al grottesco e all’onirico per delineare atmosfere cupe e un’ “Odissea” antiretorica dal retrogusto amaro che rapisce. All’inizio e alla fine lo stesso oscuro figuro gonfia di botte Llewyn. Forse è la vita stessa che, fuggendo su un taxi, egli saluterà con un sorriso definitivo, un beffardo inchino, un surreale commiato.
di Rosalinda Occhipinti