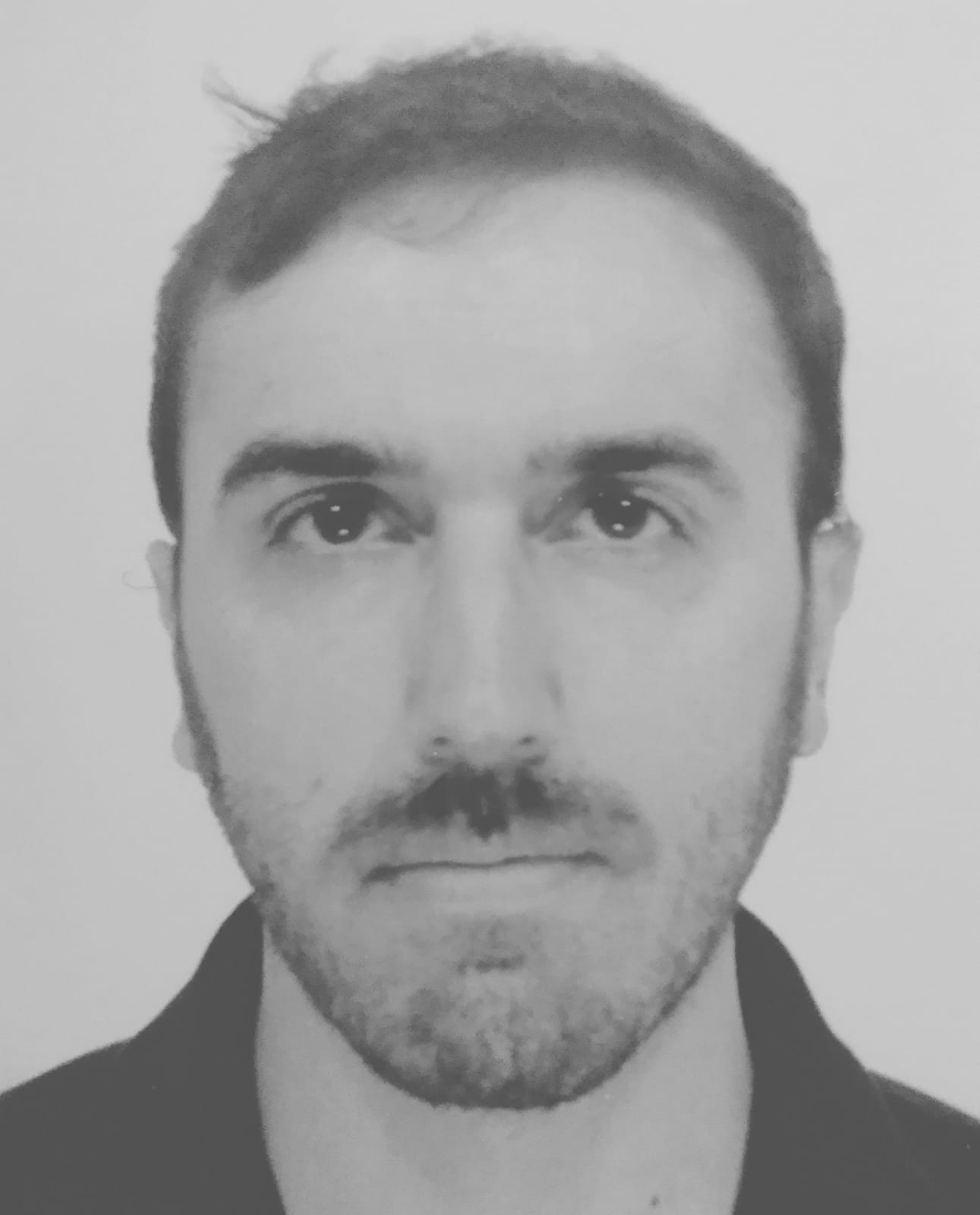Privatizzazione Poste Italiane: Governo a caccia di soldi, sindacati in allarme

Il Governo a caccia di soldi freschi si prepara a fare cassa cedendo una quota della più grande azienda di servizi d’Italia. Ma fa confusione sulle percentuali. E i sindacati temono licenziamenti
«No alla privatizzazione di Poste Italiane: è un gioiello che deve rimanere in mano pubblica. Ci batteremo in tutti i modi possibili per evitarne la svendita». Firmato: Giorgia Meloni, con tanto di hashtag di autenticità #patriotiditalia.
Era il 23 gennaio 2018 e la leader di Fratelli d’Italia proclamava su Facebook la propria contrarietà all’idea del Governo Gentiloni di mettere sul mercato una quota di Poste. Alla fine non se ne fece niente: il piano del Pd renziano, portato avanti dal ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan, naufragò, con grande sollievo per i «patrioti» della destra.
Ma la vita riserva sempre sorprese. Soprattutto quando si parla della politica italiana. Sei anni dopo quel post su Facebook, a realizzare il vecchio progetto del centrosinistra sarà proprio Giorgia Meloni, nel frattempo ascesa alla presidenza del Consiglio. Lo scorso 25 gennaio il Consiglio dei ministri ha dato il via libera a vendere una quota della partecipazione pubblica in Poste Italiane. E a gridare allo scandalo, stavolta, è il Pd nel frattempo passato all’opposizione.
Diamo i numeri
L’inversione a U meloniana risponde al bisogno del Governo di fare cassa in vista del ripristino del Patto di Stabilità europeo. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, punta a racimolare una ventina di miliardi di euro in tre anni attraverso operazioni di privatizzazione.
Lo scorso novembre il Tesoro ha incassato circa 900 milioni di euro collocando sul mercato il 25% del Montepaschi di Siena, ma nei prossimi mesi saranno messi in vendita anche parte dei “gioielli di famiglia”, ossia delle partecipate di Stato più virtuose: si comincia con Poste Italiane, poi potrebbe toccare a Eni e Ferrovie.
Non è ancora dato sapere con quali modalità sarà venduto il pacchetto di Poste. Quel che il Governo ha assicurato è che il controllo della società rimarrà in mani pubbliche, anche se sulle percentuali si è creata una certa confusione. Prima il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, per bocca della sottosegretaria Fausta Bergamotto (Fdi), ha dichiarato che lo Stato manterrà la maggioranza assoluta del 51%. Poi il ministro dell’Economia Giorgetti (Lega) ha spiegato che non si scenderà sotto il 35%. Fra le due ipotesi c’è una differenza che vale circa 2 miliardi di euro.
Oggi lo Stato detiene circa il 64% di Poste, di cui il 29% fa capo direttamente al Ministero dell’Economia mentre il restante 35% è gestito da Cassa Depositi e Prestiti, che a sua volta è controllata dal Mef. Per statuto nessun soggetto privato può detenere una quota superiore al 5%.
Nell’ipotesi fatta da Bergamotto, entrambi gli azionisti pubblici diluirebbero le rispettive quote complessivamente del 13%, per un valore intorno agli 1,7 miliardi di euro. Se invece – come ha lasciato intendere Giorgetti – lo Stato rimanesse con il 35%, allora ad essere dismesso sarebbe verosimilmente l’intero pacchetto del 29% oggi in mano al Tesoro, per un incasso che si aggirerebbe sui 3,5 miliardi.
«Le percentuali non tornano. Evidentemente anche tra ministri sono d’accordo solo sul fare cassa», attacca il deputato del Pd Andrea Casu, che sulla vicenda ha presentato un’interrogazione parlamentare. «Poste Italiane non rappresenta solo 162 anni di storia italiana, ma anche il nostro futuro: 120mila dipendenti, 12.800 sportelli aperti sul territorio, 580 miliardi di euro di risparmi degli italiani, 35 milioni di clienti. È un gioiello che non potete e non dovete svendere», ha scandito il deputato dem in aula, rivolgendosi ai banchi del Governo.
Il gioiellino
Su questo punto, almeno, sono tutti d’accordo: Poste è un colosso italiano che gode di ottima salute. Nei primi nove mesi del 2023 ha registrato un utile netto di 1,5 miliardi di euro (+5,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente) e ricavi per quasi 9 miliardi (+6,8%) trainati in particolare dai servizi finanziari. La previsione sul risultato operativo annuo è stata rivista al rialzo da 2,5 a 2,6 miliardi.
La capitalizzazione di borsa è pari a 13,4 miliardi di euro, valore che ne fa la tredicesima società più preziosa sul listino di Piazza Affari. Nel 2022 la partecipata guidata dall’amministratore delegato Matteo Del Fante ha staccato un dividendo da 250 milioni di euro in favore dell’azionista Mef: un piccolo tesoretto annuo garantito che verrebbe meno, in caso di privatizzazione.
Ma Giorgetti è determinato a procedere con la vendita. «Poste è un valore, un asset e anche questo governo lo ha ben presente», sottolinea il ministro: «Le sue potenzialità di sviluppo vanno però oltre rispetto alla presenza dell’ufficio postale, il nome è rimasto Poste, ma di posta ce n’è molto poca. Le dinamiche di sviluppo dipendono dal perimetro di attività e dalla visione moderna» apportata dal management. «La cessione – secondo il titolare del Mef – sarà volta ad accrescere il valore del Gruppo, garantendo nel contempo la qualità dei servizi e il mantenimento dei livelli occupazionali».
In sostanza Giorgetti nega che l’intera operazione abbia come unica finalità quella di incassare denaro fresco e motiva la privatizzazione con la volontà di dare a Poste uno slancio ulteriore sul mercato. Tuttavia, se – come assicurato dallo stesso ministro – il controllo rimarrà saldamente in mani pubbliche, allora non si vede quale cambiamento ci si debba aspettare sul fronte del management (e peraltro nessun cambiamento appare oggi necessario).
Il ministro ha spiegato che nella vendita sarà agevolato il collocamento presso dipendenti e piccoli risparmiatori, così da garantire «maggiore democrazia economica». E ha chiarito che il modello che il Governo ha in mente di seguire è quello delle dismissioni fatte in passato su Eni, Enel e Leonardo. «Nessuno svende niente a nessuno. Non faremo come è stato fatto con Tim, possiamo garantirvelo», ha chiosato Giorgetti in aula evocando la sciagurata privatizzazione di Telecom operata a fine anni Novanta dal centrosinistra.
Lavoratori traditi
Intanto i sindacati si preparano ad alzare le barricate. «La strada tracciata dal Governo desta enorme preoccupazione e incontra la nostra assoluta contrarietà», avverte Raffaele Rosciglio, segretario generale della Slp-Cisl, la sigla maggioritaria tra i lavoratori di Poste.
Riferendosi chiaramente alla premier Meloni, Rosciglio parla di «tradimento» da parte «di chi in passato aveva promesso tutt’altro»: «Chiediamo coerenza a tutela di una delle maggiori e più proficue aziende del Paese. Poste Italiane assicura importanti utili allo Stato e sarebbe inaccettabile mettere in discussione migliaia di posti di lavoro, rischiando di compromettere la qualità dei servizi offerti a milioni di cittadini».
La Slp-Cisl si dice pronta a mobilitare «120mila lavoratori e le loro famiglie, organizzando presidi in tutta Italia durante il periodo di campagna elettorale delle elezioni europee per sensibilizzare i partiti politici ed impedire la svendita della più grande azienda di servizi del Paese».
L’amministratore delegato di Poste, Del Fante, ha convocato i sindacati per il prossimo 15 febbraio, ma le sigle chiedono a gran voce anche un incontro con le Commissioni parlamentari che dovranno esprimersi sul progetto del Governo.
Il tempo, però, stringe. Secondo gli analisti, se tutto andrà secondo i piani dell’esecutivo, la privatizzazione potrebbe consumarsi tra aprile e maggio, sicuramente dopo la presentazione del nuovo Piano strategico di Poste, prevista per il 20 marzo.