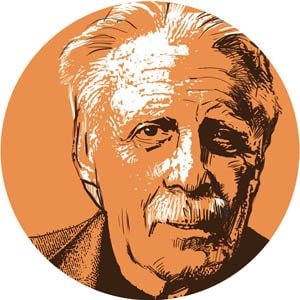Ecco chi lavora per il re di Prussia: come la sinistra italiana favorisce il Capitano e prepara la sua incoronazione (di Marco Revelli)

Stanno tutti sulla parte illuminata del palcoscenico, questi uomini del Capitano, a loro insaputa. A cominciare dal Governo. Poi ci sono i media, quelli che non ti aspetteresti. Sembrano aver incominciato a condividere la carta principale del “gioco” di Salvini, le elezioni subito, sparando a palle incatenate scetticismo e diffidenza sulla ipotesi di convergenza tra M5S e Pd
Erano circa le due e mezza del pomeriggio, quando il principe di Soubise diede l’ordine alla propria cavalleria di portarsi in prima linea lasciando l’originaria posizione a difesa dello schieramento di fronte alla piccola città sassone di Rossbach: non sapeva allora che con quel semplice gesto avrebbe firmato una delle più umilianti sconfitte dell’esercito francese e soprattutto che sarebbe passato alla storia come colui da cui trae origine il celebre modo di dire “lavorare per il Re di Prussia”.
Lo sventurato (al cui nome è legata anche una celebre salsa a base di cipolle) era al comando di un esercito forte almeno il doppio di quello guidato personalmente da Federico II di Prussia.
Avrebbe avuto in mano tutte le carte per vincere, forse stravincere, quella battaglia all’inizio di novembre del 1757, nel pieno della Guerra dei sette anni, senonché scambiò i movimenti con cui i prussiani si preparavano all’attacco per manovre preliminari alla ritirata. E quella che nei suoi piani avrebbe dovuto essere una semplice scaramuccia d’assaggio, vista anche l’ora tarda, si trasformò in una disfatta definitiva, consumatasi in appena un’ora e mezza di combattimento fulmineo e sanguinosissimo.
Da allora chiunque prepari la propria sconfitta, e faccia il gioco dell’avversario credendo (o anche fingendo) di combatterlo, finisce per essere accomunato a quel dignitario di corte di Luigi XV, gran seduttore di donne (anche giovanissime), gran estimatore di cavalli, ma pessimo comandante in capo (o “capo politico” che dir si voglia).
Oggi, a più di due secoli e mezzo di distanza, in un’Italia sfarinata e disillusa, si direbbe che i de Soubise abbiano proliferato oltre misura. E che coloro che lavorano per il Re di Prussia (o, se si preferisce, dopo la lettura del Rapporto Censis, per l’”uomo forte” alle porte) allignino sui più diversi campi in cui si combatte la battaglia contro un turbopopulismo aggressivo, rozzo e arrembante (più degno del re di Prussia padre, quel Federico Guglielmo che trascorreva le giornate a passare in rassegna manipoli di granatieri e a schiaffeggiare le ragazze in strada per ricacciarle in cucina, che non dell’ ingentilito figlio Federico II).
Detto in altre parole, come sintesi dopo aver letto cronache e editoriali di giornali, visto sfilze di talk show, teso l’orecchio al gossip strabordante dalle stanze dei palazzi, interpretato sguardi e fisiognomica dei leader, auscultato direttori di giornali e telegiornali, verrebbe spontanea la domanda: “Tutti pazzi per Salvini?”.
L’esercito di Matteo Salvini – un po’ come quello a suo tempo di Federico II – non è in una posizione netta di supremazia, anzi: in Parlamento le sue truppe – mettendoci insieme anche quelle della alleata (?) Meloni – sono all’incirca la metà di quelle giallo-rosa (157 contro 333). Nel Paese i sondaggi ne gonfiano il consenso, ma sono voti virtuali e, come si sa, volatilissimi in tempo di velocità e di volubilità nell’orientamento di quelle che non sono più vere e proprie “culture politiche” ma mood, sentimenti e stati d’animo, tanto che già le ultime rilevazioni segnalano il superamento verso il basso della soglia psicologica del 30 per cento.
Lui stesso non sta molto bene: infila una gaffe dietro l’altra, non perde occasione per dimostrare vera l’accusa di Conte secondo cui “non studia i dossier”, cade come uno scolaretto alla prima domanda nozionistica (clamorosa la scena muta sulle CACs), la sua candidata in Emilia appare ogni giorno di più impresentabile, insomma, scopre sempre più pericolosamente il fianco a un’ipotetica controffensiva avversaria. Tanto più ora che gli si è materializzato, nelle piazze di tutta Italia, un popolo che muove in direzione ostinata e contraria. Che offre plasticamente, in forma corporea, l’esistenza di un’Altra Italia, specularmente rovesciata rispetto alle sue passioni tristi.
E tuttavia, proprio ora, nel momento stesso in cui l’alternativa a quell’arruolamento di massa del paese sotto le bandiere nere del rancore e risentimento pare prender forma e quota, sembra che un esercito di gnomi si sia messo al lavoro per facilitargli il compito. O, appunto, “fare il suo gioco”. Persino per “dargli ragione”.
Stanno tutti sulla parte illuminata del palcoscenico, questi uomini del Capitano a loro insaputa. A cominciare da quelli del proscenio: il Governo, intendo. I miracolati dall’ormai quasi dimenticato suicidio d’agosto del Capitano, che buon senso e prudenza avrebbero dovuto consigliare di porre quella maggioranza faticosamente messa insieme alla luce della salus rei publicae sotto una campana di vetro, per fare poche, possibilmente popolari, e necessarie cose (una legge elettorale proporzionale per evitare colpi di mano maggioritari su Costituzione e democrazia, una manovra minimamente equa nei limiti delle strette maglie europee, qualche segnale di attenzione per i disagi sociali, uno stile di collaborazione civile).
E che invece fanno di tutto per offrire l’immagine quotidiana della precarietà, della fragilità e della litigiosità persino al di là delle dimensioni reali dei dissensi (che pur ci sono), imbastendo pantomime e duelli da operetta, ostentando diffidenze e dissapori in vertici notturni su dettagli e codicilli. Insomma, per auto-adempiere le profezie che lo sconfitto di agosto aveva incominciato fin da subito a proclamare per fingersi vincitore.
Lavorando alacremente per togliere quel “re senza corona” (e con brutta scorta) dall’angolo in cui si era cacciato.
Lavora per il Re di Prussia, in modo persino spudorato, Matteo da Firenze – professionista dell’intrigo e della destabilizzazione di tutto ciò che tocca – il quale a quanto sembra e si dice, si sarebbe addirittura accordato con il suo omonimo lombardo per spartirsi, come due machiavellici principi di antiche signorie, Paese e Toscana, e che inventa ogni giorno nuovi casus belli, non importa se su questioni marginali e su cavilli, solo per ricordare che sotto il trono di cartapesta la terra trema.
Lavora per il Re di Prussia Luigi il Piccolo, il fragile Di Maio che non perde occasione per rivelare, persino dalla mimica facciale, il proprio rimpianto per la rottura di quella coppia vestita del “capo politico” pentastellato col “Capitano” verde-bruno che doveva avergli dato l’ebbrezza di un potere finalmente muscolare: un caso pressoché esemplare di “sindrome di Stoccolma”, perché mentre gli strizzava l’occhio e gli sorrideva in tralice, l’altro gli sfilava di sotto il naso metà del suo elettorato, ma appunto, in questo scorcio di crepuscolo repubblicano anche le psicopatie e le sindromi post-traumatiche giocano la loro parte.
Ma lavora per il Re di Prussia anche, nel suo piccolo, Nicola Zingaretti, che pur si sforza di essere razionale e pacato, ma che, lui pure, non evita di disseminare pietre d’inciampo (ogni tanto un auspicio per lo scudo penale all’Ilva, un endorsement per il maggioritario, un siluro alla limitazione della prescrizione), con esternazioni poi riassorbite, dico e non dico mai chiariti, così, tanto per marcare una differenza, e una fessura nel muro della maggioranza.
D’altra parte fin dai giorni immediatamente successivi all’apertura della crisi del governo “Conte Uno” per opera di Salvini, non aveva mai dissimulato la voglia matta di andare “dritti al voto”: un evidente suicidio per lui, data la situazione di allora, una mossa paragonabile a quella dell’ineffabile Soubise quasi tre secoli fa, ma spiegabile con l’incomprimibile desiderio di levarsi dai piedi Renzi e i renziani, costi quel che costi (e visto all’opera l’enfant prodige di Rignano ancora in questi giorni, come dargli torto? Se anziché il Segretario generale di un partito fosse un privato cittadino come noi sarebbe difficile negargli tutta la solidarietà umana che l’esasperazione merita).
Il fatto è che pressoché tutti i protagonisti di questa fase di fibrillazione politica e istituzionale, in cui sembra giocarsi un bel pezzo della nostra democrazia, sono in realtà dei “singles”. Degli individui in qualche modo solitari anche se si fregiano di titoli (Capo politico, Segretario Generale, Coordinatore nazionale, ecc.) allusivi a un corpo collettivo organico che in realtà non c’è, perché galleggiano, ognuno, su un magma fluido, liquido, in qualche caso gassoso, forti (anzi, deboli) di una legittimazione effimera e provvisoria che devono tentare di confermare in tempo reale attraverso forme di attivismo mediatico in cui la microconflittualità quotidiana è l’ingrediente principe.
A guardarli con un po’ di distacco si coglie come siano pressoché costretti a marcarsi a vista sempre, non solo tra avversari ma anche (e forse soprattutto) tra alleati, spesso tra “compagni” o “colleghi” appartenenti alla stessa formazione, senza poter quasi mai riprendere fiato, consapevoli che il piedistallo su cui stanno e da cui credono di comandare è in stato di perenne sfaldamento, e richiede per star su iniezioni costanti di adrenalina, dosi sempre più massicce di competitività, soprattutto quantitativi industriali di “visibilità”. E’ l’effetto perverso della cosiddetta “personalizzazione” della politica, sottoprodotto tossico della epocale crisi della forma-partito e della tanto celebrata fine delle ideologie. Forma ormai tanto pervasiva e totalizzante, che come accade da tempo negli sport individuali (tennis) e nel gioco degli scacchi, oggi si formalizza il rating dei politici e si stilano graduatorie.
Poi ci sono gli altri grandi “lavoratori per il Re di Prussia”. I media. Non tanto quelli schierati a priori (Libero, il Giornale, La Verità), fogli che è difficile definire “mezzo d’informazione”, ma gli altri, quelli che non ti aspetteresti, i grandi giornali “di sistema”, il Gruppo Repubblica-L’Espresso in primis, da sempre militanti sul fronte del “politicamente corretto”, cultori della buona estetica e delle buone maniere e che per questo immagineresti in prima linea a contrastare senza se e senza ma le mosse dal Capitano. A contenerne lo straripamento dell’immagine. E invece no. Sembrano aver incominciato a condividere sornionamente – quasi subliminarmente – la carta principale del suo “gioco”, le elezioni subito, praticamente in tempo reale, a Camere ancora in ferie, sparando a palle incatenate scetticismo e diffidenza sulla ipotesi di convergenza tra 5Stelle e Pd (l’unica possibile per evitare il peggio).
E, insieme, sul governo “Conte due” prima ancora che questo nascesse, nonostante fosse evidente anche ai bambini che l’aborto di quella maggioranza (certo raccogliticcia, riottosa e fragile) avrebbe aperto un’autostrada alla voglia di “pieni poteri” del perdente d’agosto, rivalutandone a posteriori quella che era stata una castroneria storica. Ne hanno denunciato contraddizioni e fratture prima ancora che si potessero manifestare, con il piglio del profeta ben determinato ad auto adempiere il proprio vaticinio, spargendo a piene mani ironia e disistima per quell’ex “populista gentile” (Giuseppe Conte, intendo) che di fronte all’insorgenza del truce “turbo-populismo verdebruno” aveva avuto l’energia di contrapporsi su posizioni d’indubbia dignità democratica, indifferenti ai pur alti toni della sua denuncia.
Anzi, arricciando un po’ il naso, per rinfacciargli le cattive compagnie del precedente percorso governativo (che pure c’erano state), mentre le andavano perdonando quasi tutte all’uomo senza qualità orfano del Viminale: gli immensi vuoti di conoscenza, l’ignoranza dei problemi che va agitando demagogicamente, le blasfeme evocazioni delle Madonne miracolose come in una saga medievale, i tanti collaboratori incriminati, i sindaci imbecilli e mercuriali, moltiplicandone per converso le immagini “in stato di quiete” oltre ogni necessità.
Accompagnandone (di certo non per cattiva volontà politica, piuttosto per deformazione professionale) la dilatazione dell’Io con l’espansione, in parallelo, della presenza in video, come se fosse davvero un Gulliver nel paese di Lilliput.
Secondo i dati rilasciati da AgCom nel mese di ottobre, a spogliazione da tutte le cariche istituzionali avvenuta e a riduzione a uomo qualunque della politica compiuta, Matteo Salvini svettava ancora per volume di “tempo di parola” (“il tempo in cui il soggetto politico/istituzionale parla direttamente in voce”) su tutti i canali Rai: 12,48 per cento contro il 12,41 per cento dei 5Stelle, 10,5 per cento del Pd, 8,5 per cento di Forza Italia, 4 punti percentuali in più del Presidente della Repubblica, un volume di fuoco, da solo, quasi pari a quello di tutti i Ministri, Sottosegretari e Governo nel suo complesso messi insieme.
Peggio ancora su La7: Salvini vi ha avuto un “tempo di parola” quasi doppio rispetto sia ai 5Stelle che al Pd (23,65 per cento contro 13,50 per cento e 12,63 per cento), quasi venti volte quello del Presidente della Repubblica, più del doppio rispetto al Governo, ai suoi Ministri e Sottosegretari. Per non parlare di “Carta Bianca” che il 27 novembre gli ha dedicato addirittura un’ora (UN’ ORA!) di intervista. O di Massimo Giletti, che in prima serata lo tratta come uno di famiglia inviando alla “bimba” del Capitano che li “guarda prima di andare a nanna” i “saluti dallo zio”.
O, naturalmente, di Bruno Vespa (ma sul suo “Porta a porta” torneremo in seguito). È come se gli addetti alla stesura del racconto pubblico subissero contro il loro stesso credo politico cosciente un segreto fascino: il fascino dell’orrido, quello che attira verso il burrone che si sa mortale, che fa innamorare della malafemmina sapendo che lo è, che attira la falena verso il lampione che le brucerà le ali.
Certo, le motivazioni di copertura non mancano. Si dice che il rinvio delle elezioni dopo la fine del governo giallo-verde sarebbe stata impopolare. Che avrebbe fatto il gioco di Salvini. Che un governicchio che vivacchiasse qualche mese avrebbe preparato un boom di voti leghisti superiore a quello del voto subito. Si denunciano i vizi del “trasformismo”, la piaga del “ministerialismo” di salveminiana memoria. Si ripete a nastro che piuttosto di una lenta agonia, meglio le prova del fuoco subito mettendo in conto anche una vittoria dei barbari (che comunque durerebbero a loro volta poco).
E a me questo grave argomentare da medici d’un tempo al capezzale del moribondo ricorda tanto il clima di desistenza politica degli ultimi mesi del 1922, quando l’intero notabilato liberale si arrese ai manipoli in marcia con il più o meno inconscio auspicio di “metter fine alla lunga agonia”. E magari rinsanguare un po’ l’esangue Stato unitario con le energie della “rozza materia”. Mi sono riletto quello straordinario resoconto che è Marcia su Roma e dintorni di Emilio Lussu, e mi sono inquietato non poco nel rincontrare, come se non fosse passato un secolo, la medesima Italia, gli stessi ambigui sentimenti.
Non nego che ognuno di questi argomenti abbia una sua interna logica (formale). Ma si tratta di – a volte intelligenti, a volte meno – coperture. Quelle che Vilfredo Pareto chiamava “derivazioni”, cioè razionalizzazioni a posteriori di motivazioni altre, pulsionali, forse inconsce, comunque radicate negli strati profondi degli individui, istinti potremmo chiamarli, riflessi pavloviani di chi avverte, a naso, l’odore dell’audience.
E il corpo espanso di Matteo Salvini, ne emana parecchio di quell’odore, se non altro per la rottura dell’ordine dell’immagine che produce nella stessa forma dello splatter. È un vizio genetico del sistema dei media (del “sistema”, voglio sottolinearlo, non delle singole persone che vi agiscono), questo tipo di reattività. Non tanto un accidente, una patologia estemporanea. Fa parte della fisiologia dell’universo mediatico questo gioco compulsivo sulle icone performanti e, per essere tali, sconcertanti. E non è una pratica “innocente”. Ha prodotto, e va producendo sempre più, un’infinità di guai, non solo per i sentimenti morali della Nazione ma anche, e soprattutto, per i suoi ordinamenti politici.
A cominciare da quella personalizzazione della politica da cui proviene, come si è detto, la fibrillazione permanente dell’ultimo governo ma non solo, un po’ tutte le perturbanti avventure della leadership nell’ultimo quarto di secolo. Personalizzare è infatti un must insuperabile dei media. Ridurre alla vicenda individuale di un protagonista quello che, per sua natura, è fenomeno collettivo, diventa operazione indispensabile per realizzare quello storytelling di cui vivono i media. Per, appunto, “fare racconto” secondo la regola aurea per cui ogni narrazione presuppone, per esistere, non solo un’unità di spazio e di tempo, ma un protagonista (o di alcuni, non troppi, protagonisti).
Cosa naturale, finché la sfera della fiction rimaneva una tra le altre, nel mosaico della vita sociale. Fatto esiziale (per chi auspichi la “buona politica”) quando il sistema mediatico si totalizza, e assorbe, surdeterminandoli, tutti gli altri sottosistemi, a cominciare da quello politico. Nella “società dello spettacolo”, per dirla con Guy Débord, vendere la propria merce-notizia è l’unico imperativo ammissibile, e per venderla essa deve sottostare alle regole stesse dello spettacolo, più vincolanti di ogni fine e di ogni credo. Mezzo che divora tutti gli altri fini. Che costringe “il mentitore a mentire a se stesso”.
Così il feticcio “Salvini” tiene il campo nonostante tutto, anche in partibus infidelium, perché nel suo strabordare, incarna perfettamente il falso che divora il vero e nella sua natura di avatar spettacolare sopravvive a se stesso. Per questo resta al centro della scena anche dopo che da sé se ne è messo al margine (e contro i sentimenti stessi di coloro che pur stanno in cabina di regia). Perché, seguendo i canoni della Commedia dell’arte, il cattivo, il negativo, non può abbandonare il palcoscenico prima della fine della rappresentazione (val la pena ricordare che un personaggio tipico della Commedia dell’arte era il Capitano, “vanaglorioso spaccone” costruito sul cliché del Miles gloriosus plautiano, destinato a rimanere in scena fino alla bastonatura finale).
Si pensi al surreale “duello” a “Porta a porta” tra i due Matteo accomunati solo dal fatto di essere entrambi autori di un autogol, ma non giustificato da null’altro se non dall’audience che quei due Capitan Fracassa suonati ancora alimentano nel mondo ridotto a spettacolo (come scrive, ancora, Débord “i personaggi ammirevoli in cui il sistema si personifica sono ben noti per non essere ciò che sono: sono divenuti grandi uomini scendendo al di sotto della realtà della minima vita individuale, e tutti lo sanno”).
Per questo è lecito chiedersi – polemicamente, paradossalmente, sperando di vedersi subito smentiti -, o constatare, oggi: “Tutti pazzi per Salvini?”.
Oggi, quando nemmeno il “Fatto quotidiano” si trattiene più, e si lascia scappare uno schizzetto di veleno in preparazione della piazza romana delle Sardine, giusto per fare uno pseudo scoop su un presunto invito a Casa Pound, gonfiato nel titolo e sparato in prima tanto così, per partecipare allo spettacolo. Presunto scoop che, c’era da scommetterci, è stato subito raccolto e rilanciato dal gran circo mediatico, e anche – prevedibile pure questo – dai non numerosi ma assai rumorosi “barbottoni” di sinistra pura e dura, pronti a fare l’analisi semiologica di ogni frase e di ogni discorso proveniente da quelle piazze che, voglio ripeterlo, sono l’unico, vero antidoto all’impazzimento generale della politica virtuale, con la loro materialità di volti, corpi, vite aggregate nello spazio pubblico per eccellenza: la piazza non mediatica della Città.