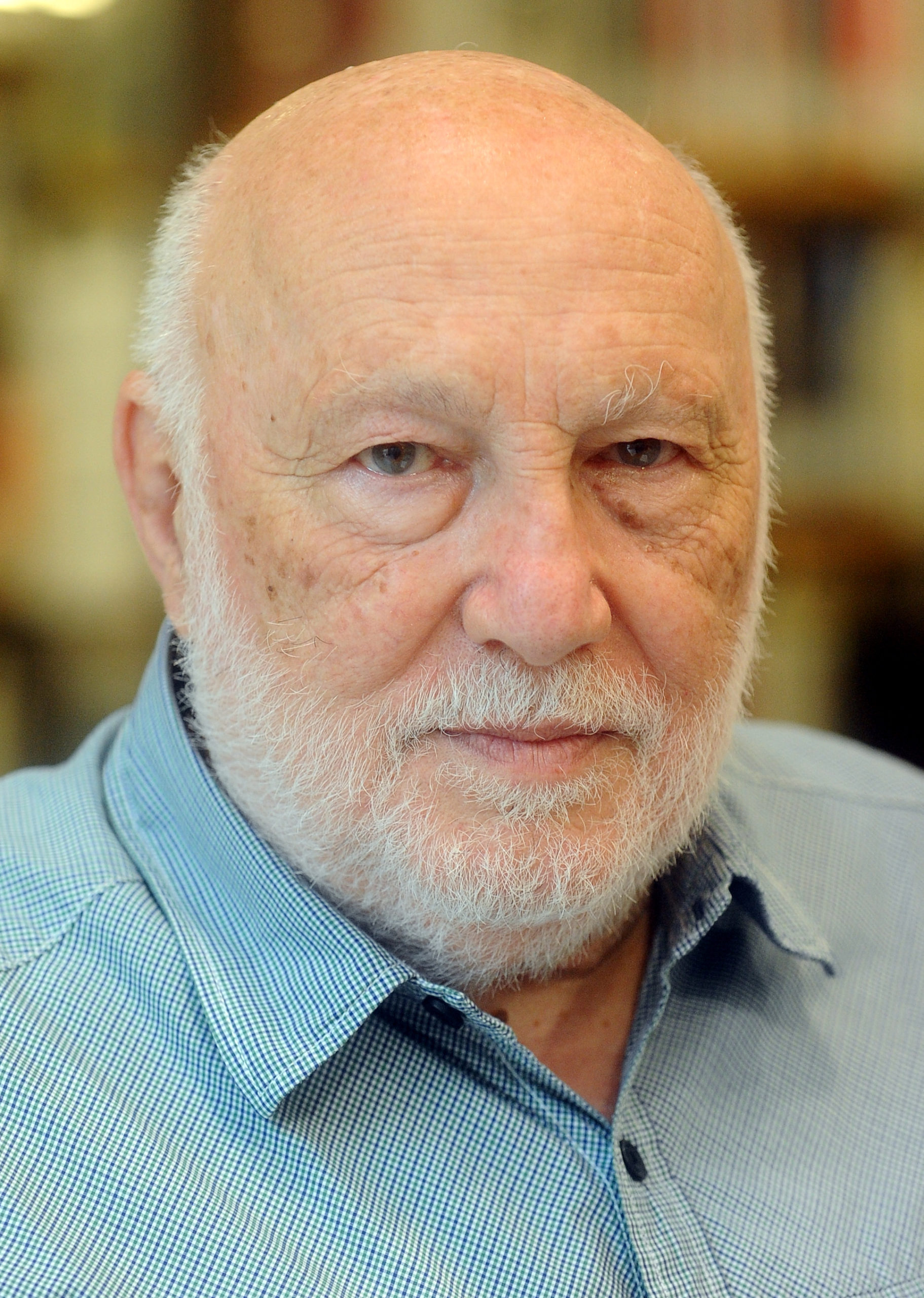Il paradosso delle privatizzazioni italiane: ispirate dal neoliberismo, realizzate dalla sinistra (di D. De Masi)

Le grandi dismissioni degli anni ‘90 sono state ispirate dal neoliberismo. Ma in Italia la spinta è arrivata spesso da governi socialisti, riformisti e post-comunisti. Con la regia di Mario Draghi, trasformatosi da privatizzatore a neo-statalista per necessità
Giusto trenta anni fa, il 2 giugno 1992, avvenne un fatto rilevante nella complessa operazione politico-economica varata per privatizzare il settore pubblico italiano. Nato con l’Iri nel 1933, in sessant’anni il settore aveva aggregato centinaia di aziende nelle holding dell’Iri, dell’Eni e dell’Efim. Dopo la guerra, per trent’anni consecutivi (“Trente glorieuses”, come li chiamò Jean Fourastié) questa flotta possente di beni e servizi aveva navigato con il vento in poppa perché le politiche keynesiane avevano incoraggiato l’intervento statale nell’economia e il Pil era cresciuto al ritmo del 5 per cento. Intanto, però, altrove le cose andavano in senso opposto e si imponeva a tutto campo la teoria neoliberista secondo cui, nell’economia, lo Stato deve adottare il criterio del “laissez faire” dando il massimo spazio al libero mercato, ai privati e alla concorrenza. Durante tutti gli anni Ottanta «Starve the beast», affamare la bestia, cioè lo Stato, fu il principio adottato dal governo Reagan in America mentre Margaret Thatcher gli faceva eco in Inghilterra sostenendo che «There is no alternative».
Da noi questo spirito neoliberista arrivò con i governi Andreotti e Amato. Poi, nel 1991 si aggiunse Mario Draghi alla Direzione Generale del Tesoro e alla presidenza del Comitato per le Privatizzazioni, due cariche che egli manterrà fino al 2001. Il 2 giugno 1992, il fior fiore della finanza internazionale, insieme ai nostri imprenditori preminenti e a ben cinque presidenti del Consiglio, si incontrarono a Civitavecchia, sul panfilo HMY Britannia della famiglia reale inglese, ospiti dell’ambasciata britannica e dei “British Invisibles”, per varare ufficialmente la privatizzazione in Italia, unica per dimensioni nel panorama europeo. Fu proprio Draghi a introdurre i lavori di quel meeting esponendo, con un autorevole discorso tecnico, i criteri di tutta l’operazione (il testo integrale è stato pubblicato solo molto più tardi da Il Fatto Quotidiano). La Stampa della famiglia Agnelli elogiò Draghi come «il regista delle grandi privatizzazioni… quasi un’ombra accanto al ministro di turno».
E chi furono i ministri di turno? Nel decennio 1991-2001 si succedettero i governi Andreotti VI, Amato I, Ciampi, Berlusconi I, Dini, Prodi I, D’Alema I e II, Amato II e Berlusconi II. Su 3.884 giorni di permanenza di Draghi alla Direzione generale del Tesoro e del Comitato delle privatizzazioni, ben 2.155 (pari al 55 per cento del totale) hanno visto al Governo Presidenti del Consiglio socialisti, comunisti o ulivisti. Ma la politica economica, con privatizzazioni a ritmo serrato, rimase sempre e inequivocabilmente neoliberista: cioè figlia legittima di quelle Scuole di Vienna e Chicago che si erano posto come obiettivo primario la sconfitta del socialismo. Perciò risulta paradossale che in Italia le privatizzazioni, intenzionalmente antisocialiste, anti-socialdemocratiche e anticomuniste, furono in buona parte firmate da governi a guida socialista, socialdemocratica e comunista. Massimo D’Alema, intervenendo a “Porta a Porta” il 6 aprile 2013, addirittura se ne vantò: «È stato il centrosinistra a smontare l’Iri, non la destra che si definisce liberale… Noi abbiamo compresso la spesa pubblica portandola al 46 per cento del Pil mentre la destra l’ha portata al 53 per cento: sette punti maggiore del centrosinistra». Fu il ministro Bersani a introdurre nel 1998 la nuova normativa del mercato e nel 1999 la liberalizzazione del settore elettrico.
Sembrerebbe quasi che questi governanti siano stati scaltramente usati dai poteri neoliberisti come comoda scorciatoia per introdurre, tramite uomini di sinistra, le riforme care alla destra. Escludendo tassativamente dalle possibili spiegazioni quella di dolosi tornaconti personali, restano un paio di ipotesi circa i motivi per cui questi premier trovarono la forza sufficiente per privatizzare il settore pubblico ma non quella necessaria per bonificarlo e lasciarlo nelle mani dello Stato. Una prima ipotesi è che le aziende pubbliche fossero così decotte da essere irrecuperabili; ma allora non si capisce perché mai i privati se le sono comprate. Una seconda ipotesi è che questi governanti, disorientati da una cultura composita, fatta di spezzoni marxisti, cattolici, proudhoniani, keynesiani, schumpeteriani, non avessero né la solidità teorica, né la tensione ideologica, né il coraggio decisionale per imprimere un’accelerazione socialdemocratica alla macchina statale, costringendola a rigenerare la sua efficienza, emendare i suoi difetti e punire i suoi corrotti. La terza ipotesi è che, in assenza di un compiuto modello neo-socialista o neo-marxista di società, essi vedevano nel sistema americano e inglese, compiutamente neoliberista, l’unico archetipo cui conformare la modernizzazione dell’Italia. Fossero stati realmente socialisti o almeno socialdemocratici, quei governanti avrebbero considerato la presenza massiccia dello Stato nell’economia non come una mostruosità da estirpare ma come un fortunato strumento di politica industriale da perfezionare fino a fare del nostro Paese, orgogliosamente, la prima socialdemocrazia del Mediterraneo. Dopo pochi anni, la crisi del 2008-2018 ha reso innegabili i difetti del neo-liberismo in termini di aumento delle disuguaglianze, maggiore precarietà e rischi per tutti. La pandemia ha fatto il resto, rendendo evidente il bisogno di una regia centralizzata del sistema socio-economico e di un welfare equilibratore.
Il risultato complessivo è che in tutto il mondo la politica economica sta facendo un giro di boa in favore di strategie se non socialdemocratiche, almeno keynesiane. Ora in Italia, per ironia della sorte, questa torsione keynesiana è affidata allo stesso Draghi che a suo tempo la impedì. Per tutto questo sono di grande interesse le dense cento pagine di un saggio (“Ben tornato Stato, ma”, ed. il Mulino) con cui Giuliano Amato, uno dei massimi artefici delle privatizzazioni, ora torna sul luogo del delitto e, con grande stile, dribbla le obiezioni per quanto riguarda il passato e consiglia cautele per quanto riguarda il futuro. Bisogna ricordare che Amato, durante il suo governo, con una legge del 30 luglio 1990 trasformò le banche di diritto pubblico in società per azioni e con un decreto del 1992 trasformò, dalla sera alla mattina, gli enti di gestione delle partecipazioni statali (quindi non vendibili) in società per azioni (quindi vendibili). Poi egli stesso, e con la stessa celerità, impose una tassa del 27 per cento sugli interessi dei conti correnti, a fronte di una tassa del 12,5 per cento sui guadagni da investimenti borsistici, dirottando così il risparmio privato dal debito pubblico al mercato azionario.
Amato dice che questo avvio garibaldino delle privatizzazioni «ebbe una motivazione tutta endogena» e «a prescindere dai dettami del neoliberismo». Dunque cade la mia terza ipotesi e si rafforzano le altre due. Nella prima parte del suo libro Amato sintetizza i problemi connessi al rapporto Stato-mercato; nella seconda parte descrive l’esperienza terminata alla fine del Novecento e l’attuale ritorno dello Stato; nella terza parte elenca i possibili antidoti contro le devianze e gli eccessi di intrusione negli interessi pubblici. Tra Stato e mercato Amato sceglie per sé una posizione equidistante e asettica sostenendo che, a prescindere dai rispettivi difetti, non si può «giungere a rivendicare il primato dell’uno o dell’altro, a pretendere che sia quindi affermata e accettata la guida dell’uno o dell’altro». Ma poiché il nocciolo del pensiero socialista sta proprio nel primato della società e dello Stato, dunque Amato, nell’imprimere una sterzata in senso privatista alla politica economica del Paese, mise in pausa il suo essere socialista per compiere un’azione di squisito neoliberismo, che egli stesso definisce «insieme una dottrina vincente e un ben articolato concerto di indirizzi di politica economica». Oggi Amato ritiene che i tempi siano profondamente cambiati rispetto all’ultima decade del Novecento. Trent’anni fa alla crisi fiscale dello Stato si sommavano le devianze, l’intrusività, gli inquinamenti e le patologie delle aziende pubbliche. Oggi tornano le regolazioni di settore, la proprietà pubblica delle imprese ritenute strategiche, l’intervento pubblico per le imprese in difficoltà, lo Stato investitore e lo “Stato provvidenza”. Dopo il ritiro, ecco il ritorno della “marea pubblica”. C’è un nuovo, gran bisogno di Stato – conclude Amato – ma occorre vigilare affinché esso sappia mendarsi dei vecchi vizi e dalla tentazione di un accentramento autoritario. C’è dunque da chiedersi: se ieri i governanti che si dicevano socialcomunisti svendettero la socialdemocrazia al neoliberismo, cosa sapranno fare i governanti attuali, quasi tutti consapevolmente o inconsapevolmente neoliberisti?