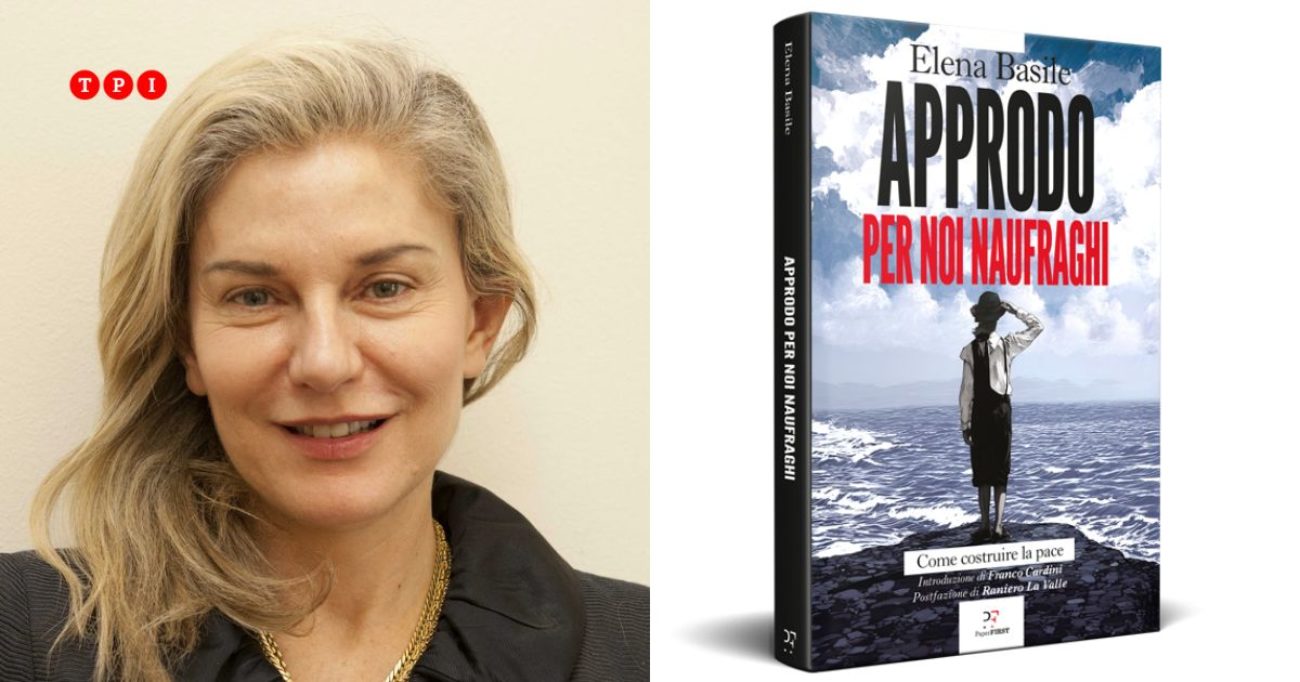Il nuovo sultano che ha reso la Turchia sempre meno europea

Il risultato del referendum ha finito per allontanare le due sponde del continente e ha rivelato una spaccatura verticale nel paese
La risicata e pur contestabile vittoria di Recep Tayyip Erdogan nel referendum che consente di modificare la Costituzione, introducendo a partire dal novembre 2019 un sistema presidenziale privo di controlli democratici che gli garantirà – in linea teorica – di restare al potere fino al 2034, ha se non altro il pregio di avere definito una volta per tutte i lineamenti di quella Yeni Turkiye, la Nuova Turchia, che si appresta a guidare con il piglio del satrapo ma al tempo stesso con l’aura del riformatore.
— Questa notizia puoi leggerla direttamente sul tuo Messenger di Facebook. Ecco come.
E poco importa se il responso delle urne (i risultati definitivi si avranno fra una dozzina di giorni) sembri riservare all’Akp – il partito islamico che da quattro turni vinceva a man bassa ogni elezione – un vistoso arretramento con almeno il 10 per cento dei suffragi in meno, perché quei 25 milioni di cittadini che hanno detto sì alla riforma voluta da Erdogan hanno verosimilmente votato perché convinti del suo messaggio di stabilità e non perché intimiditi e impauriti dall’irrequietezza dell’Anatolia, stretta fra la morsa di due terrorismi, quello jihadista e quello curdo del Pkk.
Per metà dei turchi Erdogan è davvero il nuovo grande padre della patria, secondo solo all’ormai sbiadita figura di Kemal Atatürk. Così evanescente e spogliata dei suoi pilastri portanti (il laicismo di Stato su tutti) su cui eresse ormai un secolo fa la Turchia uscita dalla dissoluzione dell’impero ottomano, che l’icona e il modello di riferimento di Erdogan è da tempo il sultano Abdul Hamid II, grande (e sanguinario) riformatore dell’impero, dotato per l’epoca – l’ultima decade dell’Ottocento – di una visione moderna dello Stato e della macchina burocratica che deve servirlo.
E non è un caso, perché è proprio la visione imperiale a dominare le scelte di Erdogan, forte di quel connubio fra religione, liberismo economico e identità nazionale che è come un marchio di fabbrica per i turchi. Gli stessi che nelle comunità estere – dove peraltro un’Europa impaurita e indecisa sul da farsi ha commesso l’errore di vietare i comizi elettorali a favore del “Sì” – hanno massicciamente votato per la riforma voluta da Erdogan, confermando una volta di più la loro riluttanza ad integrarsi in società differenti da quella anatolica.
Gli stessi tuttavia che a Istanbul, Ankara e soprattutto a Smirne – città eternamente ribelle – hanno dato la vittoria al “No”, confermando la profonda spaccatura fra città e campagna e in definitiva il fossato che taglia in due il paese stesso.
Qual è dunque l’identikit della Nuova Turchia che verosimilmente uscirà dalle mani del suo unico e inamovibile demiurgo, una figura che accentrando tutti i poteri esecutivi (scompare anche la figura del premier) avrà titolo per nominare e far dimettere ministri, sciogliere il già depauperato Parlamento, nominare i giudici della Corte Suprema?
Sicuramente quello di una nazione sempre meno europea e sempre più mediorientale: mai come ora le due sponde si sono allontanate, mai come ora la Turchia cessa di essere la democrazia autoritaria (se pure formalmente parlamentare) che conoscevamo per celebrarsi in un’autocrazia di tipo egiziano, siriano, iracheno dell’era Saddam; mai come ora si profila la convocazione di altri due referendum che sancirebbero la rottura definitiva con le democrazie occidentali: quello per dire “no” ai negoziati di adesione con l’Unione Europea e quello sul ripristino della pena di morte.
Ma è inutile stupirsi, il sentiero in realtà era già ampiamente tracciato sia prima del fallito – e mai del tutto chiarito – tentativo di colpo di Stato del luglio 2016, sia dopo: 44mila fra poliziotti, magistrati, accademici, giornalisti e politici attendono tuttora in cella la formalizzazione di accuse che contemplano in buona parte dei casi la condanna all’ergastolo, altri 103 mila sono sotto inchiesta, almeno 135 mila funzionari pubblici hanno perduto il posto di lavoro, anche le immunità parlamentari sono state rimosse e l’opposizione rischia ogni giorno l’accusa di terrorismo o di alto tradimento.
Fra i mesti primati della Turchia c’è anche la massima concentrazione mondiale di giornalisti dietro le sbarre (per tutti, una men che vaga accusa di “terrorismo”) e almeno 170 testate scomode chiuse e decine di corrispondenti dichiarati “persona non grata”.
Presidente esecutivo de facto da almeno un paio d’anni, ora Erdogan lo diventerà anche de iure, e facciamo francamente fatica a immaginare che il pugno di ferro sulle minoranze politiche non finisca per abbattersi anche su quelle religiose, i cristiani soprattutto, già da anni anche in Turchia nel mirino dell’intolleranza e del fanatismo di matrice islamista.
Ma il voto di domenica, per quanto favorevole a Erdogan e alla sua riforma, rivela una nazione verticalmente spaccata. Ed è su quel lato in ombra del paese, dove ancora esiste un’opposizione politica significativa, che convergono le speranze di chi non ha ancora rinunciato a combattere.
Il problema della Turchia non è la sua anima asiatica né il suo miraggio neo-ottomano. Il problema è uno solo, come solo è l’uomo che si appresta a comandarla con pugno di ferro.
— Non restare fuori dal mondo. Iscriviti qui alla newsletter di TPI e ricevi ogni sera i fatti essenziali della giornata.