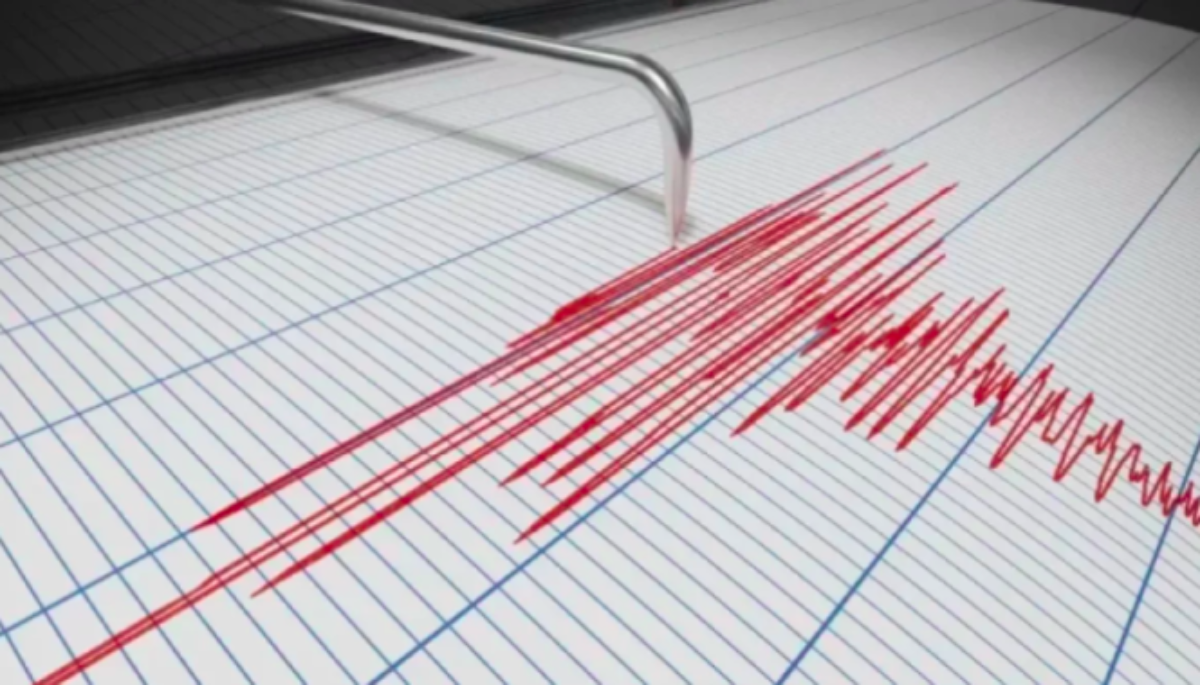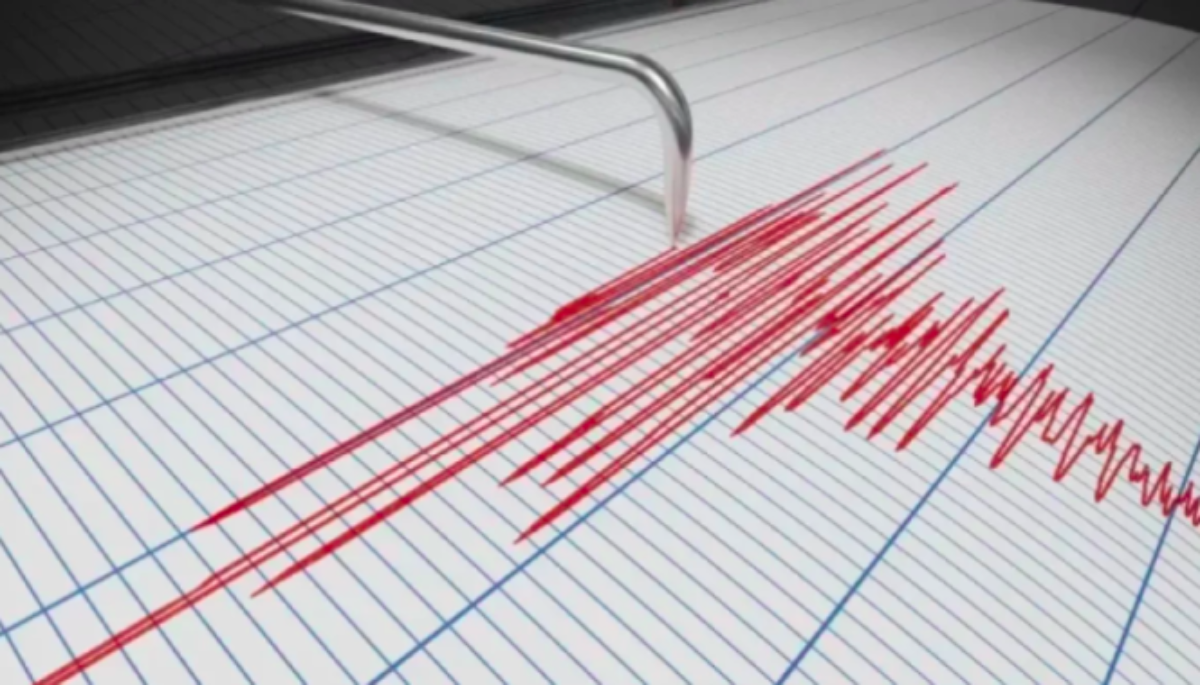Come funziona il terrorismo in Tunisia

La minaccia jihadista può essere spiegata con due motivazioni. L'analisi dell'analista italiano Fabio Merone
Mercoledì 18 marzo un attacco jihadista ha colpito il cuore di Tunisi. Nella zona dell’attacco sorge sia il museo Bardo che il parlamento tunisino.
Non è quindi chiaro se l’obiettivo degli attentatori fosse il Taghout (l’istituzione sovrana illegittima, o tiranno, nel linguaggio coranico) oppure i turisti occidentali kafir (infedeli).
Quale che fosse la ragione dell’attacco, alla fine sono morte 23 persone, per la maggior parte stranieri.
Il primo indizio per capire la vera motivazione dell’attacco viene proprio dai jihadisti, con la loro dichiarazione ufficiale apparsa sul sito Ifriqiia. Il secondo è una registrazione audio dell’Isis, che si congratula per l’attentato.
Lo stile del primo comunicato era singolare: usando un tono quasi scherzoso e familiare, i jihadisti si prendevano gioco delle autorità tunisine descrivendo la semplicità con cui si era svolta l’operazione. È bastato prendere il metrò, superare la stazione di polizia del Bardo ed entrare nel compound del parlamento.
Inutile, sottintendono jihadisti, che stiate troppo ad arrovellarvi sulle dinamiche dell’operazione. Il comunicato dell’Isis era invece una semplice professione di solidarietà con gli attentatori.
Ciò che si deduce da questi pochi dettagli è che l’operazione è stata probabilmente condotta dal gruppo Okba Ibn Nefaa, una katiba (brigata) di al-Qaeda nel Maghreb islamico (Aqim). Questa non sarebbe una sorpresa, dato che il gruppo è stato in guerra con lo stato tunisino (Taghout) da almeno il 2013.
La strategia di questo gruppo è perlopiù sconosciuta. Si sa solo ciò che emerge da comunicati, dichiarazioni e documenti delle forze di sicurezza. Si tratta di un gruppo jihadista, in origine molto piccolo, attivo in particolare alla frontiera fra Algeria e Tunisia.
Secondo alcune fonti la cellula si sarebbe sviluppata nel periodo in cui l’Azawad, una regione nel nord del Mali, si auto-proclamò indipendente ispirandosi alla sharia (prima dell’intervento francese, n.d.r.). In origine costituito perlopiù da algerini, Okba Ibn Nefaa ha poi accolto nelle proprie fila combattenti di altre nazionalità.
Il riorganizzarsi attorno a questo gruppo era un modo per “ricollocarsi” dopo il fallimento dell’esperienza maliana. Secondo le forze di sicurezza, infatti, già prima questo gruppo aveva funto da testa di ponte per il Mali, gestendo il trasporto di armi e guerriglieri.
In questo senso, la cellula aveva poco interesse per gli sviluppi politici in Tunisia, e guardava piuttosto al contrabbando di armi anche attraverso la Libia. Solo dal 2013 le attività del gruppo si sono a poco a poco spostate verso la Tunisia, tant’è che qualcuno sospettava un loro coinvolgimento negli assassini politici avvenuti nel dopo-Ben Ali.
La polizia era convinta che l’organizzazione avesse contatti con cellule jihadiste nelle zone più sottosviluppate del Paese. Si trattava di una possibilità plausibile, visto che la Tunisia stava attraversando una fase di rinnovamento politico che aveva portato nelle strade tanti giovani marginalizzati di quelle zone.
Proprio quelle dinamiche di transizione avevano creato un vuoto in cui si era imposto un nuovo gruppo salafita jihadista, Ansar al-Sharia Tunisia (Ast).
Il ministro dell’Interno è convinto che non ci sia differenza tra questa larga fetta di popolazione emarginata e la crescita di gruppi come Ansar al-Sharia e Okba Ibn Nefaa. Per lui, sono tutti terroristi.
Al contrario, la leadership di Ansar al- Sharia insiste che la Tunisia per loro deve essere terra di predicazione (dawa) e non di guerra (qital). Abu Ayadh, il capo carismatico del movimento, ha detto in diversi video che tra Ansar al-Sharia Tunisia e il movimento jihadista internazionale ci sono contatti ideologici ma non politici o operativi.
Gli osservatori, che non hanno la pazienza di stare a differenziare fra diversi gruppi jihadisti e tendenze salafite, non hanno tenuto conto di questo fatto. In realtà però queste distinzioni sono fondamentali, danno una chiave di lettura più approfondita dell’evoluzione interna al movimento jihadista internazionale.
La principale attività di Ansar Al Sharia Tunisia è stata quella di agire come movimento sociale, andando a raccogliere consensi nelle masse di emarginati. In origine si muoveva come un movimento islamico classico, facendo predicazione e carità.
Piuttosto che sposare una strategia apocalittica di stampo qaedista, il gruppo si proponeva di avanzare un’alternativa sociale per le fette di popolazione “escluse” dallo stato e abbandonate in sacche di malessere sociale e povertà (la medesima strategia sarà poi perseguita da Jabahat al-Nusra and Ansar al-Sharia Libia).
Questa strategia ha avuto un tale successo da rendere l’organizzazione intollerabile per molti all’interno della società tunisina: troppi giovani ne erano attratti.
Molto presto, il congresso annuale di Ansar Al Sharia divenne un’occasione per le forze di sicurezza di mostrare come la situazione fosse sotto controllo, con il sostegno dell’elite nazionalista anti-islamista e di una popolazione impaurita dal ritorno della violenza politica.
Durante il 2013, di conseguenza, fra gli islamisti si diffuse il timore che la nuova fase di messa in sicurezza dello stato stesse andando nella direzione di un ritorno all’ancien regime. Ci fu un tentativo di creare un fronte islamico contro lo “stato profondo”, vissuto come una reincarnazione del regime di Ben Ali.
Si sviluppò uno scontro di narrative nella sfera pubblica, con una chiamata alla “guerra al terrorismo” da una parte e lo spauracchio di un ritorno alla dittatura dall’altra. Nel vuoto creato da questa contrapposizione si sono inseriti Okba Ibn Nafaa e altri elementi del jihadismo internazionale.
Questo scenario è sotto alcuni aspetti simile a quello creatisi in altri paesi della Primavera, ma anche a suo modo diverso. In comune c’è un processo di polarizzazione. Di diverso c’è che, per esempio, in Egitto il campo nazionalista anti-islamista (lo “stato profondo”) si è riappropriato del potere.
In Libia lo scontro è precipitato in una guerra civile senza vinti e senza vincitori. In Tunisia nel frattempo si verificava un esperimento molto interessante: il partito islamista mainstream Ennhada ha resistito alla tentazione di creare un fronte islamista e si è unito ai nazionalisti in una sorta di grande coalizione governativa. L’alleanza si è rivelata solida, anche nelle difficili ore seguite all’attentato.
Tuttavia, chi fra gli islamisti non si è lasciato coinvolgere ed è rimasto ai margini, continua a riproporre la narrativa per cui il regime precedente è tornato ed usa metodi ancora più repressivi.
La prova, per loro, è la dichiarazione del governo Ennhada nell’agosto 2013 per cui Ansar Al Sharia sarebbe un’organizzazione terroristica, senza aver fatto un tentativo serio di coinvolgerli nel processo democratico. Una dura campagna per schiacciare il movimento ne è stata la logica conseguenza.
Secondo dati provenienti da delle organizzazioni per i diritti umani, sarebbero stati incarcerati non meno di 6.500 giovani, il doppio rispetto alla campagna repressiva lanciata da Ben Ali nel 2007.
Dopo il 2013 e l’inserimento di Ansar Al Sharia nella lista nera, il ministero dell’Interno ha cominciato a comportarsi come se la galassia islamista tunisina fosse un tutt’uno. Ansar Al Sharia è stata accusata di essere dietro una campagna terrorista, anche se questo non è mai stato provato. La repressione in ogni caso ha portato l’esperienza del movimento al capolinea.
Non è però scomparsa la variegata compagine salafita su cui il movimento si poggiava. Alcuni sono andati a combattere in Siria, Iraq o Libia. Alcuni, spaventati dalla repressione, sono divenuti inattivi. Altri ancora hanno spinto per una reazione anti-governativa, unendosi a fazioni come Okba Ibn Nafaa.
Quest’ultima è cresciuta in questa fase promuovendo lo scontro fra lo stato e i salafiti.
C’è anche un’altra ipotesi, e cioè che l’evoluzione dello scenario internazionale abbia favorito una convergenza fra Aqmi e l’Isis. L’apparato di sicurezza tunisino, praticamente lo stesso dell’era Ben Ali, non ha però gli strumenti per effettuare questo genere di analisi.
L’attacco ai turisti potrebbe rappresentare l’inizio di una nuova strategia per gli islamisti radicali tunisini di Okba Ibn Nafaa o altri gruppi. Fino ad adesso, infatti, in Tunisia come in Egitto gli attacchi si concentravano su esercito e forze di sicurezza, e cercavano l’approvazione della popolazione.
Tirando le somme, la minaccia jihadista in Tunisia può essere spiegata da due motivazioni. Una guarda a cause specificamente tunisine, non riconducibili a una generica e astratta “minaccia terroristica”. La seconda riguarda un incrocio fra “locale” e “internazionale”.
Il successo dell’Isis sta certamente cambiando la situazione politica.
Sfruttando il fallimento nella gestione della crisi in tutta la regione, il jihadismo cerca di chiamare a raccolta tutta la umma (i musulmani) dalla parte del califfato contro il nemico occidente.
Se da una parte una strategia anti-terrorista è necessaria, visto che questo scontro fa presagire altri attacchi in Paesi arabi o occidentali, è fondamentale tracciare una separazione fra il jihadismo internazionale e le crisi specificamente nazionali, per cui servirebbero soluzioni politiche.
Per la Tunisia, la strategia jihadista di attaccare i civili (anche stranieri) rischia di portare a una escalation del conflitto. Ancor di più siccome i jihadisti stanno divenendo sempre più distanti dalla popolazione (lo shock dell’attacco rende molti tunisini propensi a derive repressive e di sicurezza).
Sarebbe però sbagliato sostenere la strategia della guerra totale promossa dal ministero dell’Interno tunisino. Un altro giro di vite servirebbe a poco e metterebbe ancora più persone sotto chiave senza una ragione reale.
È necessaria una soluzione politica che comporti il riconoscimento e l’inclusione nel processo democratico della componente salafita tunisina, almeno in parte.
*Fabio Merone è dottorando a Ghent, in Belgio, e visiting lecturer all’Università di Laval, in Quebec, Canada. L’autore ci ha chiesto di riportare in italiano su The Post Internazionale il suo articolo, originariamente pubblicato su OpenDemocracy. La traduzione è a cura di Davide Lerner