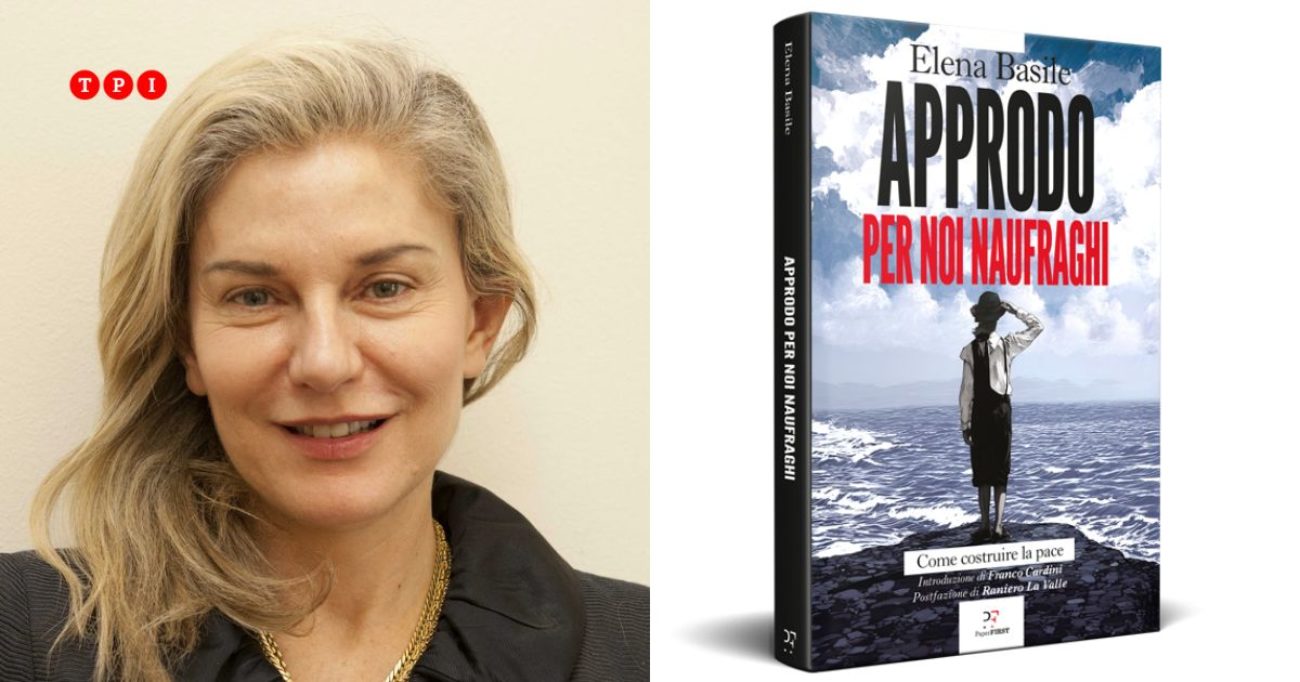“Abbiamo visto la morte in faccia, ma era nostro dovere raccontare l’orrore della guerra in Siria”: i reporter siriani a TPI dopo 8 anni di conflitto

Aver sconfitto l‘omertà e il muro della censura: è questa la conquista più grande che i reporter siriani hanno ottenuto con l’inizio della rivolta antigovernativa del 2011. Foto, video, reportage e vignette realizzati in Siria e condivisi in rete hanno raggiunto ogni angolo del mondo, raccontando come repressione, guerra e terrorismo abbiano cambiato la vita di un intero popolo.
Un racconto mai facile, che solo nel 2018 è costato la vita a 24 giornalisti siriani. Otto anni dopo, abbiamo incontrato alcuni dei protagonisti di questa rivoluzione mediatica, che oggi vivono in Turchia.
Il mio viaggio tra i reporter siriani che vivono in Turchia inizia con un fuori programma, mentre faccio visita ad alcune famiglie di profughi a Killis, a pochi chilometri da Aleppo.
“Lei è mia nipote Khawla, il papà era un giornalista”, mi racconta un’anziana donna che tiene in braccio una bimba di poco più di due anni. Mi mostra sul telefonino un’immagine del figlio che non c’è più. Il sorriso rassicurante, i lunghi capelli mossi… quella foto io la conosco. Ritrae Shamel Al Ahmad, un collega che per anni ha raccontato le stragi ad Aleppo.

Davanti a me ci sono sua madre e la sua piccola orfana, che né lui, né sua moglie hanno mai conosciuto. Non era un incontro programmato e forse per questo è ancora più toccante. Shamel e la moglie erano in auto quando sono stati colpiti da un bombardamento, i medici sono riusciti a salvare solo la piccola Khawla, che era ancora nel grembo materno.
La donna, incinta di nove mesi, è rimasta gravemente ferita, Shamel, invece, sembrava aver riportato solo ferite alla spalla. Sono stati trasferiti in un ospedale di frontiera in Turchia, dove la donna è morta durante l’intervento, che ha però permesso di salvare la figlia, mentre Shamel moriva per arresto cardiaco in una stanza vicina.

Era il 3 settembre del 2016. L’anziana si commuove quando capisce che conoscevo il figlio, che il lavoro di Shamel è arrivato anche in Italia e nel resto del mondo tramite le sue foto.
Mi piacerebbe vedere Khawla seguire le orme del padre, come vorrebbe sua nonna.
Per ora in Siria per i giornalisti che dal 2011 hanno denunciato i crimini del regime non c’è alcuno spiraglio.
Lo sanno bene Qusay Noor e Muhammed Nejem, due fratelli che hanno raccontato la tragedia della Ghouta orientale, che incontro a Istanbul. Oggi hanno rispettivamente ventiquattro e sedici anni. Come molti altri giovani siriani hanno entrambi preso parte ai cortei anti governativi.

“È iniziato tutto a Zamalka, durante un corteo funebre” racconta Qusay, “quando è stata fatta esplodere un’autobomba davanti ai nostri occhi. Era la prima volta che vedevo la morte in faccia. Ho preso il telefonino e ho cominciato a filmare quel massacro. All’inizio non avevo chiaro il percorso che avrei intrapreso, ma ero sicuro che era importante documentare”.
Qusay, nonostante la giovane età è professionale, serio e le immagini che carica in rete spingono diverse emittenti a contattarlo e rilanciare i suoi lavori, finché non diventa corrispondente per Anadolu Agency, The New Arab, Smart Agency, Zaman Al Wasl e altri network.
I suoi video da Ghouta vengono ripresi anche dai grandi network internazionali. “Non è stato facile raccontare la morte, non ero preparato, ma ero mosso dal bisogno di far vedere al mondo come stavano i fatti in Siria; dovevamo denunciare i crimini subiti dai civili e contrastare la propaganda del regime”.
Muhammad segue le orme del fratello. Si crea un account sui principali social network e comincia a raccontare la guerra ad altezza di bambino, parlando sia in arabo, sia in un inglese stentato, ma efficace. I suoi video amatoriali sono girati nel cuore della guerra e mostrano dal basso cosa stava succedendo a Erbin, nella Ghouta orientale, in uno dei momenti più tragici del conflitto in Siria. Del piccolo Muhammad si accorgono diverse emittenti estere, persino dal Portogallo e dalla Germania, tra cui Hournal 8 e German_DW_channel.
“Siamo stati costretti a lasciare la Ghouta orientale dopo anni di assedio e privazioni; non c’era più nulla, il 75% delle case erano state distrutte dai bombardamenti. Quando siamo arrivati a Idlib ci siamo pentiti di aver lasciato la nostra casa”, racconta Qusay.
“Lì non avevamo alcuna possibilità ed eravamo minacciati dai miliziani dell’HTS, così non ci restava che lasciare la Siria. Arrivati in Turchia mi sembrava strano non vedere macerie, cadaveri ovunque, ma strade illuminate e negozi pieni di cibo e di gente. Ora non possiamo tornare a Ghouta perché rischiamo la vita. Di fronte a tanti orrori e ingiustizie raccontare era diventata la missione di entrambi. Ancora oggi vado a dormire con la videocamera in braccio. È ormai parte di me”, conclude Qusay.
A Istanbul riesco a incontrare Khaled Khatib, ventitré anni, il fotografo ufficiale di Syria Civil Defence – The White Helmets che si trova per qualche giorno in città. Le sue foto hanno fatto il giro del mondo, mostrando i bombardamenti su Aleppo e il difficile lavoro dei soccorritori.

“Un giorno, proprio vicino a casa mia, c’è stata una strage. Nella zona c’erano diversi fotografi stranieri e poche ore dopo ho visto le loro immagini online. Lì ho compreso l’importanza di documentare e che quella era la strada che volevo perseguire per dare il mio contributo alla causa”.
Nel 2013 il regime ha cominciato a lanciare su Aleppo missili scud, armi dalla potenza devastante, che hanno avuto conseguenze terribili per la popolazione civile. Il primo scud è caduto a Jabal Badro, causando la morte di oltre cento persone. Poi è stata la volta di Kafar Humra e Hay Masaken.
“C’erano morti ovunque, una grande distruzione. Le scene che avevamo davanti agli occhi erano terribili. Corpi straziati, brandelli umani, sono rimasto traumatizzato da quelle immagini. Per un lungo periodo ho fatto incubi e mi chiedevo continuamente cosa mi spingesse a fotografare cadaveri e innocenti incastrati sotto le macerie delle loro stesse case. Ero tentato di lasciare. Qualche volta mi sono sentito dire che avrei dovuto lasciare la telecamera e prendere in mano una pala, ma io avevo capito che anche il mio lavoro di documentazione era importante”.
Agli inizi del 2014 il regime ha iniziato a usare le barrel bombs. Khaled racconta che riprendendo i bombardamenti era consapevole che avrebbe creato un archivio documentaristico che provava i crimini del regime e che avrebbe permesso al popolo siriano di denunciare il suo stesso governo.
Nel 2015 i bombardamenti sono all’ordine del giorno, molti White Helmets cadono mentre prestano la loro opera, ma al grande dolore per gli attacchi bellici, si aggiunge lo sgomento per l’inizio di una dura campagna diffamatoria.
“Un amico mi ha fatto leggere un articolo di Vanessa Beeley in cui si diceva che le mie foto erano false e che il nostro scopo era quello di spingere a un intervento straniero in Siria. Non si faceva un torto solo a me o ai miei colleghi, ma anche e soprattutto alle vittime. Ho capito che ci colpivano perché eravamo scomodi, perché il mondo ormai sapeva, perché eravamo i primi testimoni che documentavano e denunciavano i crimini del governo di al Assad, della Russia, di Daesh e delle altre fazioni”, continua.
“Ben 256 colleghi sono morti in servizio per salvare vite umane, eppure la macchina della propaganda non si è fermata, arrivando a definirci membri di al Qaeda, quando in realtà i terroristi ci hanno preso di mira piazzando contro le nostre sedi autobomba e uccidendo con esecuzioni mirate i nostri volontari, come successo a Sarmin”.
Il 10 aprile del 2017 il regime sferra un attacco con armi chimiche a Khan Sheykhun. “Sono morte più di sessanta persone e noi abbiamo documentato tutto e prelevato campioni dagli abiti delle persone, le abbiamo portate negli ospedali, aiutando a raccogliere prove per gli inquirenti internazionali”.
Con la ripresa del controllo di quasi tutto il territorio siriano da parte del regime e dei suoi alleati, per i volontari di Syrian Civil Defence, che dal 2013 hanno salvato almeno 115mila vite umane e che sono stati candidati al Nobel per la Pace, l’unica soluzione è l’esilio, ma molti, assicura Khaled, resteranno in Siria finché potranno.
“Tutti si ricordano di Khaled Harrah che a settembre del 2014 era stato invitato a parlare di fronte all’Assemblea delle Nazioni Unite. Sul suo impegno è stato realizzato anche un documentario ‘Last man in Aleppo’ candidato agli Oscar a marzo 2018. Khaled poteva rimanere all’estero, ma è voluto tornare in Siria ed è caduto a luglio del 2016 durante l’assedio di Aleppo”.
Raccontare dall’interno, ma anche aiutare i reporter stranieri a entrare in Siria. È l’impegno che si è assunto Mahmoud al Basha, 23 anni, una laurea in lettere, diventato giornalista, ma anche fixer, stringer e producer per molte testate internazionali, anche italiane. Originario del quartiere di Salah El Din, anche Mahmoud, che all’epoca aveva sedici anni, ha preso parte attivamente ai cortei antigovernativi di Aleppo ed è stato inserito nella lista dei matlubin, i ricercati.
Con altri giovani ha creato il network Aleppo Media Center e anni dopo la 4K Productions. Foto, video, articoli hanno iniziato a circolare in rete e a bucare il muro della censura e della propaganda governativa. Dal 2012 Mahmoud si è preso anche la responsabilità di aiutare i colleghi provenienti dall’estero a entrare in Siria nelle aree liberate. Fino al 2015 Mahmoud è rimasto in Siria, poi è dovuto andare in Turchia, a Gazientep, senza mai abbandonare il suo lavoro.

“Con l’evolversi della situazione e le sempre maggiori difficoltà di fare entrare giornalisti stranieri in Siria abbiamo dovuto cambiare approccio. I giornalisti in Siria hanno cominciato a produrre per TV e giornali esteri. Nel 2016 abbiamo preso le autorizzazioni necessarie per lavorare in Turchia. Con National Geographic abbiamo lavorato un anno e mezzo per produrre ‘Hell on the Earth’, un documentario che ricostruisce tutte le fasi della crisi in Siria. Sin dall’inizio della rivolta la nostra idea era di vivere da persone libere, ma dobbiamo ammettere che nel 2011 non eravamo pronti a questo cambiamento epocale. I media sono uno strumento di cambiamento sociale e culturale importante. Noi costruiremo la Siria di domani e soprattutto il mondo dell’informazione di domani”.