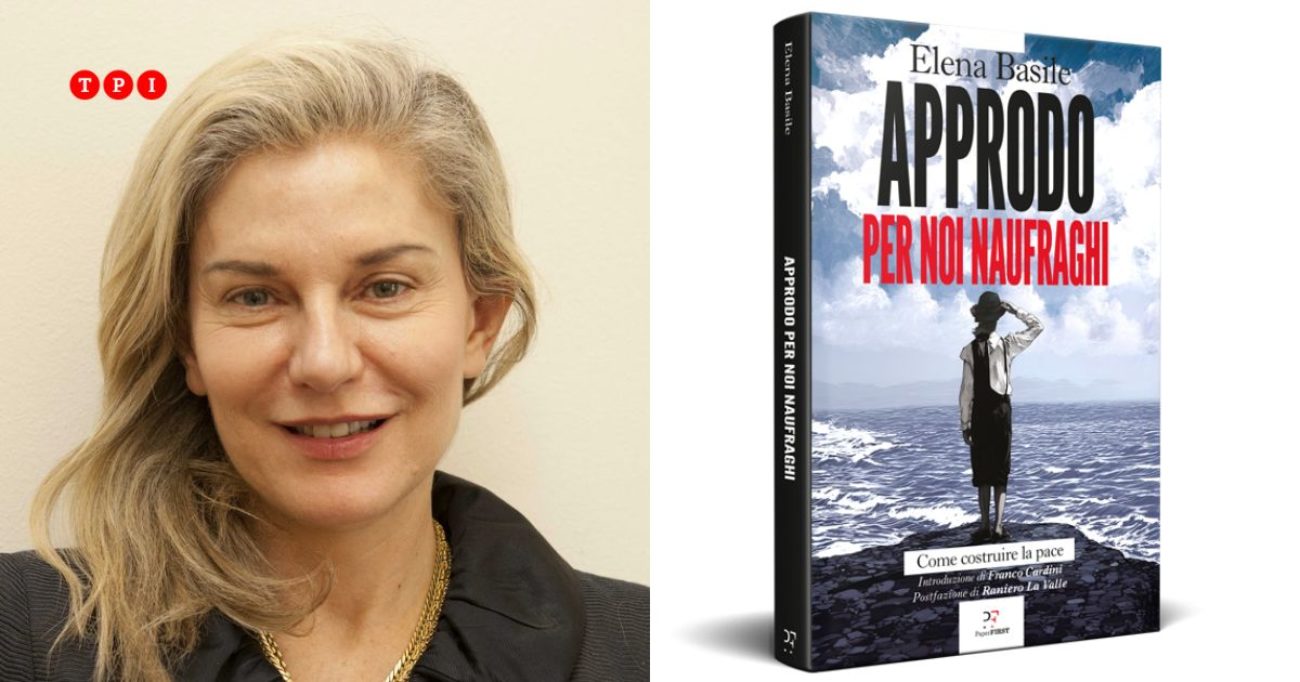Rocky Trump sfida il Drago cinese, ma non è Hong Kong il vero ring tra Stati Uniti e Cina

Dopo 18 mesi di disputa commerciale, la contesa tra Washington e Pechino sembra sempre più politica e Donald Trump la interpreta con le categorie della guerra fredda stile anni Ottanta, ma Hong Kong ha per lo più a che fare con le presidenziali del 2020
Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è salito sul ring per sfidare la Cina su Hong Kong (e magari in futuro sullo Xinjiang uiguro), in uno scontro ormai senza esclusione di colpi. A 18 mesi dall’inizio della disputa commerciale tra Washington e Pechino, voluta proprio dal presidente statunitense, finalmente il confronto coinvolge nel dibattito i diritti, eppure la liberazione dei popoli non sembra il fine di questa nuova guerra fredda, legata piuttosto alle elezioni presidenziali statunitensi e alla superiorità tecnologica e quindi economica di una potenza sull’altra.
Il nuovo Rocky della Casa bianca pare ora pronto a battersi, ma ha cambiato idea velocemente sulle manifestazioni nell’ex colonia britannica. In meno di sei mesi, Trump è passato dal definire “rivolte” le proteste in corso a Hong Kong, a suggerire un incontro tra il presidente Xi Jinping e i manifestanti per risolvere la questione “umanamente”, a vantarsi di aver impedito l’annientamento della città, chiedendo al proprio “amico” Xi di non intervenire militarmente, fino alla firma del Hong Kong Human Rights and Democracy Act, che tante rimostranze ha sollevato a Pechino.
Se le manifestazioni contrarie alla proposta di Carrie Lam per una nuova legge sull’estradizione risalgono a metà marzo, il primo grande corteo di protesta ha sfilato per le vie del centro finanziario cinese soltanto il 9 giugno, dieci giorni prima il lancio ufficiale in Florida della campagna elettorale di Donald Trump per le presidenziali del 2020. Allora, mentre da giorni già si registravano i primi scontri tra dimostranti e polizia nell’ex colonia britannica, Trump identificava i principali avversari nella sua battaglia per conquistare un secondo mandato al grido di “Keep America Great”.
Insieme ai media, al presunto socialismo proposto dai democratici, all’aids, al cancro e alle indagini sulle interferenze russe nelle elezioni del 2016, il presidente degli Stati Uniti indicò Pechino tra gli obiettivi della propria amministrazione per mantenere solida l’economia del Paese. È proprio su quest’ultimo terreno infatti che Trump ha basato la propria lotta politica e la candidatura per un secondo mandato presidenziale, un risultato possibile secondo l’ex presidente repubblicano della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Newt Gingrich, “se l’economia resterà solida”.
Eppure, i vantaggi delle politiche protezionistiche attuate da Washington tardano a farsi sentire sull’economia americana. La denuncia arriva proprio dai più strenui sostenitori del neoliberismo, come Daniel Ikenson, direttore del Herbert A. Stiefel Center for Trade Policy Studies del Cato Institute, non certo un think thank di orientamento democratico, secondo cui i provvedimenti voluti da Trump non hanno riportato in patria la produzione delle aziende americane.
La crescente pressione dei dazi ha spinto multinazionali del calibro di Nike, Crocs, Roomba e GoPro ad avviare la produzione fuori dalla Cina, ma non negli Stati Uniti, bensì in Paesi come Vietnam, India, Bangladesh e Messico, e presto aziende come Dell, Sony, Nintendo e HP potrebbero seguirne l’esempio. Secondo il Reshoring Index 2018 pubblicato dalla società di consulenza AT Kearney, lo scorso anno le importazioni statunitensi dai Paesi asiatici con produzioni a basso costo sono aumentate più che mai dall’inizio della crisi, superando la crescita della produzione lorda degli Stati Uniti, nonostante le misure volute da Trump.
Se infatti produrre in America sembra diventato troppo costoso per molte aziende, i maggiori costi associati all’aumento delle tariffe doganali li hanno pagati soprattutto i consumatori, le imprese, gli azionisti e i lavoratori dipendenti. Nel 2017, gli ultimi 12 mesi prima dell’imposizione delle misure protezionistiche statunitensi sulla Cina, le importazioni di Washington dal Paese asiatico ammontavano a 504 miliardi di dollari, con 13,5 miliardi di dazi pagati alla dogana e un’aliquota media applicata del 2,68%. Lo scorso anno, dopo l’imposizione progressiva e in due tempi di nuove tariffe doganali contro Pechino, il valore delle importazioni statunitensi dalla Cina è stato pari a 544 miliardi di dollari, con 23 miliardi di dazi riscossi e un’aliquota media applicata del 4,23%.
La differenza ha pesato soprattutto sui cittadini americani, ma il danno è stato finora attenuato da una serie di sussidi, stimoli fiscali e da una spesa pubblica più elevata, che hanno favorito la crescita dell’occupazione. Il presidente degli Stati Uniti sta infatti cercando di riportare in patria le produzioni esternalizzate, rivendicando l’aumento dei posti di lavoro come risultato di queste politiche.
Dall’ingresso di Donald Trump alla Casa bianca nel gennaio del 2017, il numero di posti di lavoro negli Stati Uniti è certamente aumentato. Secondo le statistiche ufficiali, negli ultimi due anni, l’economia statunitense ha creato quasi 6 milioni di nuovi posti di lavoro, di cui circa 400 mila nella produzione manifatturiera, meno del 10 per cento dell’incremento totale. Se lo stesso presidente degli Stati Uniti definisce quest’ultimo dato il migliore conseguito dal 1997, la sua crescita non sembra però in linea con la quota del settore sull’occupazione generale. Secondo il Bureau of Labour Statistics degli Stati Uniti infatti, la produzione manifatturiera contribuisce al 12 per cento del Prodotto interno lordo e impiega circa il 10 per cento della forza lavoro del Paese, una proporzione che non vanifica ma ridimensiona il risultato.
Nonostante le misure della Casa bianca, il settore manifatturiero, pur in crescita, continua a perdere peso nell’economia statunitense, mantenendo una tendenza al ribasso cominciata alla fine degli anni Settanta. Allora, quest’industria contribuiva per oltre un quarto al Pil degli Stati Uniti, impiegando quasi 20 milioni di posti di lavoro. Oltre un terzo di questi si sono persi negli anni a causa dell’automazione e dell’esternalizzazione della produzione, costringendo le aziende a concentrarsi sull’innovazione e su produzioni ad alto valore aggiunto. E’ proprio l’industria hi-tech infatti, secondo il Bureau of Labour Statistics, quella responsabile della maggiore crescita dell’occupazione negli Stati Uniti ed è questa la vera arena in cui si stanno misurando le due potenze globali.
Secondo Chi Lo, economista presso la banca BNP Paribas, Trump ha utilizzato i dazi per affrontare questioni al di fuori delle mere dispute commerciali, come le minacce dovute al trasferimento di tecnologia e la protezione del settore hi-tech negli Stati Uniti. Un’opinione confermata dalle dichiarazioni del segretario alla Difesa americano, Mark Esper, secondo cui la contesa tra Washington e Pechino riguarda tanto l’economia quanto la sicurezza.
Lo dimostra l’offensiva diplomatica degli Stati Uniti sugli alleati, in particolare europei, perché rinuncino alla tecnologia cinese (Huawei e Zte su tutti) in materia di reti di telecomunicazioni strategiche come il 5G, con la giustificazione della mancanza di sicurezza in materia di dati. Nonostante la reticenza europea a rompere con Huawei, soprattutto a causa dei costi che comporterebbe per gli operatori, e la sempre minore compattezza del fronte americano, con Microsoft che non intende rinunciare a un così importante cliente, questa guerra tecnologica sembra il vero oggetto del contendere tra Stati Uniti e Cina, al di là delle dichiarazioni e di eventuali sanzioni mirate per tutelare Hong Kong o della vicinanza umana e politica ai manifestanti.
La firma della nuova legge rischia infatti di rappresentare soltanto un capitolo strumentale nelle relazioni tra Washington e Pechino. “Dobbiamo stare con Kong Kong, ma io sto anche con il presidente Xi”, aveva sottolineato Trump in un’intervista alcuni giorni prima della firma della norma. Secondo l’esperto costituzionalista Julian Ku, l’Hong Kong Human Rights and Democracy Act conferisce al presidente degli Stati Uniti poteri sanzionatori di cui è di fatto già in possesso, in virtù di altre leggi simili, rendendo il testo “in gran parte simbolico e ridondante” dal punto di vista legale.
Se per l’esperto l’approvazione di questa norma impedirà al presidente degli Stati Uniti di “scambiare (la libertà di) Hong Kong con migliori relazioni commerciali” con la Cina, inviando un preciso messaggio a Pechino, proprio il rischio di “un grave contraccolpo politico interno” per Trump dimostra quanto questa legge sia rivolta più all’opinione pubblica statunitense che alla tutela dei manifestanti nell’ex colonia britannica.
La pressione esercitata da Washington su Pechino nella disputa commerciale in corso tra i due Paesi ha già prodotto ben altri risultati sulla Cina rispetto a quanto potrebbe avvenire se Trump si avvalesse delle sanzioni mirate previste dalla legge appena firmata. I dazi voluti dalla Casa bianca contro il Paese asiatico ne hanno infatti certamente influenzato il settore manifatturiero. Secondo la China International Capital Corp (CICC), tra luglio 2018 e maggio 2019, l’industria manifatturiera cinese ha perso almeno 1,8 milioni di posti di lavoro a causa delle politiche protezionistiche degli Stati Uniti. Se questo calo è dovuto anche ad alcuni adeguamenti strutturali interni e a vari fattori ciclici, non tiene però ancora conto dell’effetto degli aumenti dei dazi in vigore da maggio. Altri osservatori stimano perdite decisamente inferiori, comprese intorno ai 700 mila occupati in meno, ma è fuor di dubbio un effetto negativo sull’economia cinese dovuto agli aumenti delle tariffe doganali decisi da Washington.
L’approvazione della nuova legge rientra così tra gli strumenti in possesso del presidente degli Stati Uniti per ottenere un nuovo mandato e permette alla sua campagna elettorale di spostare l’attenzione del dibattito dagli effetti economici della guerra commerciale con la Cina alla lotta per le libertà e i diritti, più comprensibile, appassionante e spendibile a livello comunicativo, soprattutto per un elettorato conservatore.
Se soltanto il tempo svelerà il reale peso della legge firmata dal presidente degli Stati Uniti nella lotta tra la piazza di Hong Kong e Pechino, in vista delle presidenziali Trump sembra aver dato un nuovo significato alla disputa con il proprio principale avversario internazionale. Il nuovo Rocky propone se stesso come campione del popolo statunitense nel duello con la Cina, offrendo agli americani un nuovo gioco a cui partecipare, in una vera e propria “gamification” della politica tra grandi potenze.
La volubilità dimostrata da Trump sulle proteste in corso a Hong Kong restituisce l’immagine di un presidente vicino ai sentimenti del popolo americano e disposto a farsi portavoce delle sue istanze. Se un lavoratore degli anni Cinquanta non avrebbe infatti apprezzato i magri risultati economici della politica protezionistica attuata da Trump e un consumatore degli anni Ottanta si sarebbe lamentato degli effetti sui prezzi delle merci importate, il coinvolgimento dell’odierno cittadino-giocatore permette di raccogliere consensi anche intorno a provvedimenti altrimenti percepiti come sfavorevoli dal punto di vista sociale.