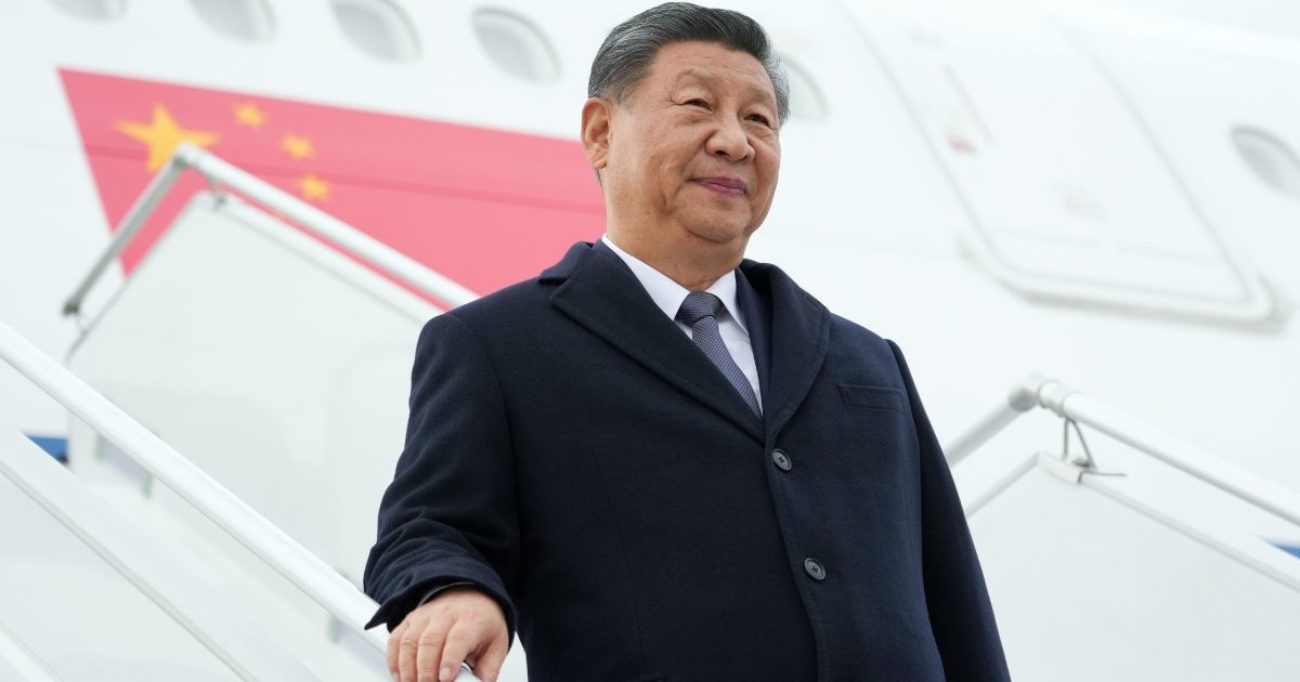La straziante morte di Alì, che sulla rotta dei Balcani ha perso i piedi e la voglia di vivere

Alì è morto il giorno stesso in cui è nato. Solo che non lo sapeva
Rotta balcanica: la storia di Alì, il migrante rimasto senza piedi
Non ce l’ha fatta, Alì. A un certo punto ha smesso di combattere. Ha detto basta a una vita che era diventata indegna di essere vissuta. Alì ha afferrato le stampelle e si è trascinato da qualche parte verso i boschi, fuori dal Bira camp di Bihac, estremo nord ovest della Bosnia Erzegovina.
E lì l’hanno trovato, in stato di incoscienza, e portato all’ospedale più vicino. Sono passati altri dieci giorni di agonia fino all’ora e al minuto del decesso, sabato scorso. Ma Alì era già morto il giorno in cui lo hanno trovato e gettato come un rifiuto tra le sterpaglie.
Era già morto il giorno in cui è arrivato al campo profughi con i piedi ormai in necrosi. Era già morto pochi giorni prima, quando la polizia croata lo ha respinto, denudato, umiliato, rispedito indietro.
Alì è morto il giorno in cui è nato, anche se nessuno glielo aveva detto. La storia di Alì comincia agli inizi di febbraio dell’anno più violento e disumano di sempre da quando chiamiamo la nostra “epoca di pace”. Alì sta percorrendo la rotta balcanica, come tanti. In tasca non ha nulla, nella testa il sogno di ritornare in Germania, quando la polizia croata lo ferma, lo spoglia di tutto quello che ha – gli abiti caldi, le scarpe, i calzini – e lo costringe a ritornare a Kladusa, sul confine tra Croazia e Bosnia, a piedi nudi, attraverso i boschi pieni di neve, a cinque gradi sotto zero.
Quando, il 7 febbraio, Alì arriva per la prima volta al Bira camp di Bihac i piedi ormai sono congelati, le dita nere come pezzi di carbone, in necrosi. È sabato, e fino al lunedì non ci sono medici, né infermieri. Per due giorni Alì resta senza cure, con dolori lancinanti che vorresti urlare, ma tieni dentro, perché sai che non ci sarà nessuno ad ascoltarli, come racconta Nuove Radici.
I piedi di Alì ormai sono in cancrena, l’unica soluzione è l’amputazione. Alì in quel momento si ricorda di quella psicoterapeuta italiana triestina e attivista umanitaria sul fronte bosniaco che aveva conosciuto tempo prima. E, non sa perché, ma si mette in testa che le deve parlare. Sul telefono di Lorena arriva un messaggio, in un inglese stentato, da un contatto comune: “Alì said if he meet you he will said you all what happened to him, but he doesen’t want to do the treatment”. Alì vuole raccontarti tutta la sua storia, ma non vuole essere curato.
Giusto il tempo di ottenere i permessi e Alì e Lorena si ritrovano uno di fronte all’altra, nel container A3 del Bira camp di Bihac, che puzza di morte, feci e urina. Parlano per metà italiano e per metà francese. Alì parla di suo figlio in Tunisia, della sua famiglia lontana. “Se avesse accettato la mutilazione non avrebbe più avuto piedi per andare loro incontro”, ricorda Lorena. “Forse voleva morire. Forse non poteva sopportare la fine di ogni illusione e il dolore che avrebbe dato a sua madre”.
Alì è ridotto a scarto umano, il suo corpo a mero involucro di una persona che non riconosce più. Meglio morire, anzi no, meglio andare, dice Alì. “Dai, andiamo! Andiamo a Zagabria, prendo l’aereo dell’Alitalia e vado in Germania”, ha uno sprazzo di reazione improvvisa, prima di rannicchiarsi dentro la sua coperta della mezzaluna turca e lasciare fuori il rumore del mondo.
Alì e Lorena si vedranno altre volte nei mesi successivi. È l’unica con cui Alì parla, si apre. Le racconta della Primavera araba, della sua fuga nel 2011, l’arrivo in Italia, i sei anni tra la Francia e la Germania ad inseguire un lavoro stabile, il ritorno in Tunisia per stare vicino alla sua famiglia. E, ogni volta, sempre quella parola, quasi come un mantra: “Zagabria”. “Portami a Zagabria, Lorena”.
L’aereo, l’Alitalia, la Germania, via da qui, lontano dal dolore, dalla paura, dai miasmi insopportabili di morte, di feci e di urina. Dopotutto per volare non servono i piedi ma le ali. Un giorno Lorena riceve una foto. È un’immagine “scandalosa”, “oscena” di Alì buttato dentro una carriola, con i piedi in necrosi, punito, oltraggiato dagli operatori, incapace di reagire. Non è solo il corpo ad essere sfuggito al suo controllo ma anche la testa, i pensieri, che se ne vanno per la loro strada senza una logica né una direzione.
TPI esce in edicola ogni venerdì
L’ultima volta che Lorena lo vede, Alì è in un letto di contenzione, legato mani e piedi dentro uno stanzone che funge anche da deposito, accanto a letti, materassi e comodini di ferro accatastati. Si sente deriso, umiliato, saccheggiato nel suo intimo. Nel sonno immagina di avere ancora i piedi, di poter di nuovo camminare. È questo che lo tiene ancora in vita. È per questo che rifiuta le cure. È seguendo questa sua lucida follia che, un giorno, Alì sparisce, nessuno lo trova più.
Ricompare a Sarajevo, in cima a una collina, con due stampelle sottobraccio e i piedi ridotti a un paio di monconi, con le parti necrotiche che sono collassate su se stesse come carne bruciata. Torna ancora a Bira, poi riparte per il suo ultimo viaggio, in qualche tunnel personale che nessuno conosce, sfidando il freddo, la notte, i boschi, i lupi, gli orsi, la polizia, i push back, lungo una rotta incerta verso nord ovest attraverso il confine croato, inseguendo Zagabria, un volo, la Germania, suo figlio, la sua vita.
“Non ho altra scelta”, aveva confessato a Lorena. Non vedrà nulla di tutto questo, Alì. Il suo viaggio finirà qualche chilometro più in là di Bihac, accasciato svenuto contro un albero, vicino a lui il suo paio di stampelle. Alì è biologicamente ancora vivo, ma, dentro, è già morto. È morto il giorno di febbraio in cui ha perso i piedi, a meno cinque gradi, nudo, sotto la neve. È morto quando ha rifiutato di curarsi. È morto il giorno stesso in cui è nato. Solo che non lo sapeva.
Ciao, Alì. Ora sei libero. Ora puoi tornare a camminare.