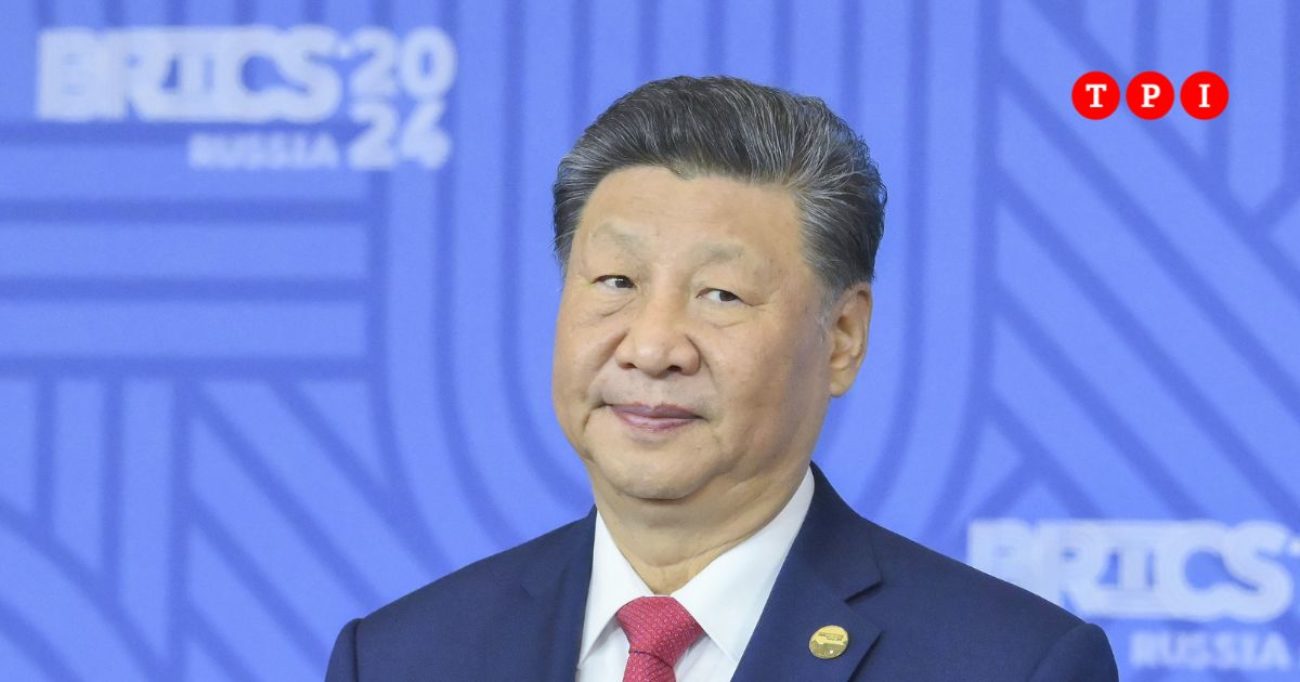Il risveglio degli ayatollah: ecco perché ora l’Iran attacca frontalmente Israele

È finita l’era della “pazienza strategica”. Adesso prevalgono i falchi, per i quali evitare conflitti diretti con gli avversari è segno di debolezza
Per la prima volta l’Iran ha attaccato apertamente un altro Paese e lo ha fatto in maniera spettacolare, con il più grande lancio di droni della storia, che nella notte tra il 13 e il 14 aprile ha dato vita a una scenografia pirotecnica sopra i cieli di Israele e della West Bank, mettendo fine a quasi mezzo secolo di guerra ombra con il suo arcinemico.
Largamente anticipata, l’operazione “True Promise” è stata lanciata in rappresaglia al bombardamento israeliano del primo aprile che ha demolito il consolato annesso all’ambasciata di Teheran di Damasco, provocando la morte del generale Mohammed Reza Zahedi, il più importante generale iraniano ucciso dopo Qassem Suleimani, insieme ad altre quindici persone tra cui membri dei pasdaran e altre milizie legate alla Repubblica islamica.
L’attacco iraniano ha rappresentato un momento di alta tensione, ma i danni provocati al nemico sono stati limitati. Israele, grazie all’aiuto di una serie di alleati e partner tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Giordania, è riuscito a intercettare e abbattere il 99% dei 185 droni, 36 missili da crociera e 110 missili balistici lanciati simultaneamente da basi collocate in Iran, Iraq e Yemen ben prima che raggiungessero i propri cieli. E, sebbene l’attivazione dei sistemi di difesa aerea Iron Dome, Arrow e David’s Sling sia costato in una notte 1,3 miliardi di dollari allo Stato ebraico, per molti analisti si è trattato poco più che di una messinscena, uno spettacolo ben coreografato per l’appunto.
Per quarantacinque anni i due Paesi hanno portato avanti una guerra per procura in Medio Oriente. Pur avendo violato la regola di non colpire mai Israele frontalmente, gli ayatollah sanno di non potersi permettere una guerra totale con le loro capacità limitate, privi di una forza aerea e con una Marina composta da barche da pesca e un esercito di martiri disposti a morire.
L’Iran doveva fare qualcosa per ragioni domestiche. Ma, per ragioni esterne, non poteva fare molto. È quel che si dice deterrenza.
Il copione è simile a quello del 2020, quando su ordine dell’allora presidente statunitense Donald Trump un drone americano ridusse in polvere il generale Suleimani e la vendetta dell’Iran si limitò a colpire una base americana in Iraq con missili balistici senza fare vittime, avendo avvisato Washington in anticipo e scongiurato così una risposta. Ma ora, nel caso di Israele, Teheran non può essere altrettanto certa.
Gli americani e gli iraniani hanno interrotto le relazioni diplomatiche nel 1979, ma hanno tenuto numerosi colloqui nelle ultime due settimane. La Repubblica islamica temeva una rappresaglia da Usa e Israele al punto da aver informato entrambi sull’orario, il genere e le coordinate dell’attacco limitando altre misure che avrebbero potuto provocare danni reali allo Stato ebraico.
La missione iraniana presso le Nazioni Unite ha dichiarato che «la faccenda può ritenersi conclusa», avvisando tuttavia che in caso di un altro errore del regime israeliano, la sua risposta sarà molto più severa, alludendo all’uso di armi nucleari.
Il presidente americano Joe Biden, dal canto suo, ha elogiato il successo dei sistemi di difesa di Israele, lasciando intendere che gli Stati Uniti non avrebbero sostenuto un’escalation militare. La risposta israeliana del 19 aprile con il lancio di missili verso la base militare di Esfahan, dove si trovano diverse strutture legate al programma nucleare iraniano, rappresenta pertanto un messaggio simbolico per gli ayatollah: «I nostri missili possono raggiungervi fino al centro del Paese».
Sebbene annunciato, l’Iran può rivendicare il più vasto attacco aereo contro Israele dal 7 ottobre e la mancanza di obiettivi raggiunti fa pensare a un semplice, seppur spettacolare, avvertimento. Tuttavia, anche l’ipotesi che l’attacco lanciato nella notte fra 13 e 14 aprile abbia rappresentato un test diplomatico, una cartina da tornasole per definire le future alleanze mediorientali, appare plausibile.
TPI esce in edicola ogni venerdì
Teheran ha combattuto lo Stato ebraico per anni creando il cosiddetto “anello di fuoco” intorno al Paese, fornendo armi e finanziando quella che Teheran chiama l’asse della resistenza, trovando conferma nella fedeltà di alleati come Hezbollah in Libano, le milizie paramilitari in Iraq e gli Houthi in Yemen, con cui avrebbe coordinato gli attacchi.
Sull’altro fronte, in questo momento cruciale, Israele ha ritrovato al suo fianco un folto gruppo di vecchi partner, come gli Stati Uniti, la Francia, il Regno Unito e ha avuto anche la prova definitiva di non essere isolato nel Medio Oriente grazie alla Middle East Air Defense Alliance (Mead), l’alleanza militare di difesa aerea nata sulla scia degli accordi di Abramo di cui fanno parte diversi Paesi arabi del Golfo e Israele; la Giordania ha partecipato con i suoi caccia all’intercettazione dei missili iraniani e si parla di un ruolo anche dell’Arabia Saudita a difesa dello Stato ebraico, fermamente intenzionata a mantenere rapporti di buon vicinato con Gerusalemme.
Per contrastare l’alleanza multi-frontale di Teheran, Israele ha sempre intrapreso diverse misure conducendo missioni sotto copertura sia sul suolo iraniano – con operazioni mirate contro scienziati e impianti nucleari, oltre a personaggi di spicco e sedi convenzionali – sia fuori dall’Iran, intercettando i traffici di armi diretti verso il Libano o la Siria. Dopo il 7 ottobre, tuttavia, l’asse filo-iraniano ha intensificato gli attacchi contro le strutture di Israele e Stati Uniti in segno di solidarietà con i cittadini di Gaza.
Come contromisura, Israele ha attaccato prima i gruppi paramilitari sostenuti da Teheran in Libano e in Siria, passando poi a colpire il personale militare iraniano stesso. Tra l’inizio di dicembre e fine marzo, Israele ha eliminato una decina di comandanti appartenenti alle Forze Quds e alle Guardie della rivoluzione islamica, culminando nel bombardamento del consolato di Damasco del primo aprile che ha ucciso il generale Zahedi, l’uomo al comando delle operazioni delle Forze Quds in tutto il Levante.
Per Teheran, l’attacco nella capitale siriana è stato disastroso, avendo fatto emergere l’ennesimo fallimento della sua intelligence in seguito a una serie di eventi in cui Israele è riuscito a raggirare abilmente le difese iraniane. La risposta degli ayatollah rappresenta quindi un cambio di strategia netto rispetto al pensiero tradizionale iraniano.
Per anni, l’approccio dell’Iran verso Israele e gli Stati Uniti è ruotato intorno a quella che gli ufficiali iraniani definivano «pazienza strategica», un approccio a lungo termine orientato a rafforzare i gruppi paramilitari invece di rispondere subito e apertamente agli attacchi: una strategia fondata sulla capacità di proiettare il potere della Repubblica islamica attraverso le sue reti senza entrare in diretto conflitto con gli avversari, garantendosi sempre la possibilità di negare i fatti. Ma i falchi del regime, ora in ascesa, vedono in questa pazienza un segno di debolezza, spingendo pertanto il governo ad aumentare la tolleranza al rischio e a fronteggiare di più il nemico. Questa nuova mentalità si è riflessa nel comportamento dell’Iran degli ultimi mesi.
A gennaio Teheran ha colpito diversi obiettivi in Iraq e in Siria settentrionale, sostenendo che fossero legati a Israele o al sedicente Stato islamico. Il giorno dopo, ha colpito il suolo pakistano, attaccando quelle che ha definito «basi operative di gruppi militanti che avevano colpito l’Iran». Ora, il Paese ha attaccato anche Israele.
«L’era della pazienza strategica è finita», ha dichiarato sulla piattaforma X un ufficiale iraniano il 14 aprile: «L’equazione è cambiata».
Il messaggio ai Paesi occidentali è inequivocabile: con gli attacchi sui mercantili nello stretto di Bab el-Mandeb, fra il Golfo di Aden e il Mar Rosso sulla tratta verso Suez e il Mediterraneo, le democrazie hanno perso il controllo degli snodi fisici della globalizzazione, e smentire tale messaggio – cioè che l’Occidente si stia vedendo sfilare le redini di quel che fino a pochi anni fa era l’ordine internazionale – si sta rivelando più difficile del previsto.
Secondo l’ala più estremista della Knesset israeliana, l’attacco rivendicato dall’Iran offre a Netanyahu l’occasione perfetta per fermare i programmi nucleari degli avversari nella regione. Dal bombardamento del sito iracheno di Osiraq nell’operazione “Babilonia” agli attacchi hacker della cyberdivisione dell’Aman, l’Unità 8200 sospettata di aver colpito in passato i siti iraniani, fino all’ultimo attacco del 19 aprile, Israele si è sempre mosso attivamente in questa direzione e si troverebbe di fronte all’«ultima finestra di tempo utile» per impedire all’Iran di diventare una potenza nucleare.
Se la risposta dello Stato ebraico fosse stata più decisa, la situazione sarebbe precipitata. Se i due Paesi si ritrovassero in una situazione di aperta ostilità, ciò potrebbe provocare numerose vittime destabilizzando ulteriormente la regione e gli Stati Uniti, spinti a difendere Israele, rischierebbero di essere coinvolti direttamente nella mischia, mentre gli attacchi degli alleati parastatali dell’Iran diventerebbero sempre più violenti e belligeranti. A quel punto, gli ayatollah cercherebbero ulteriore sostegno verso la Cina e la Russia e le sanzioni occidentali non farebbero altro che rafforzare il coordinamento con Mosca e Pechino.
Qualora Israele non riuscisse a indebolire l’avversario tramite le sue milizie alleate nella regione e con l’uso di armi convenzionali, Teheran potrebbe far ricorso al suo programma nucleare e produrre un’arma atomica. Ma Netanyahu è già impegnato su più fronti a Gaza e nel sud del Libano, ed è necessario che eviti un’escalation se vuole ottenere il via libera dagli Stati Uniti per la sua controffensiva su Rafah. Esistono perciò ragioni sufficienti per sperare che una tale escalation non accada. Da ottobre Washington tenta di evitare che il conflitto esploda nella regione, e l’invito a Netanyahu è di ritenere i successi nella difesa del suo Paese già una vittoria e di fermarsi là.
Gli Stati Uniti mantengono ancora una leva sostanziale su Israele e questa linea potrebbe prevalere, ma lo Stato ebraico non è un vassallo degli Usa e Biden non può garantire che Netanyahu non agisca.
Teheran ha calcolato rischi e benefici prima del suo attacco storico, stabilendo che doveva pareggiare i conti con Israele per evitare che ulteriori provocazioni (come il raid al consolato di Damasco). Il governo israeliano ha risposto in maniera limitata – per ora – ma i due campioni regionali sembrano prima o poi destinati a entrare in una rotta di collisione molto più disastrosa. Fino al 14 aprile il Medio Oriente non è esploso, ma il rischio di un conflitto più ampio e senza vincitori è sempre alle porte.