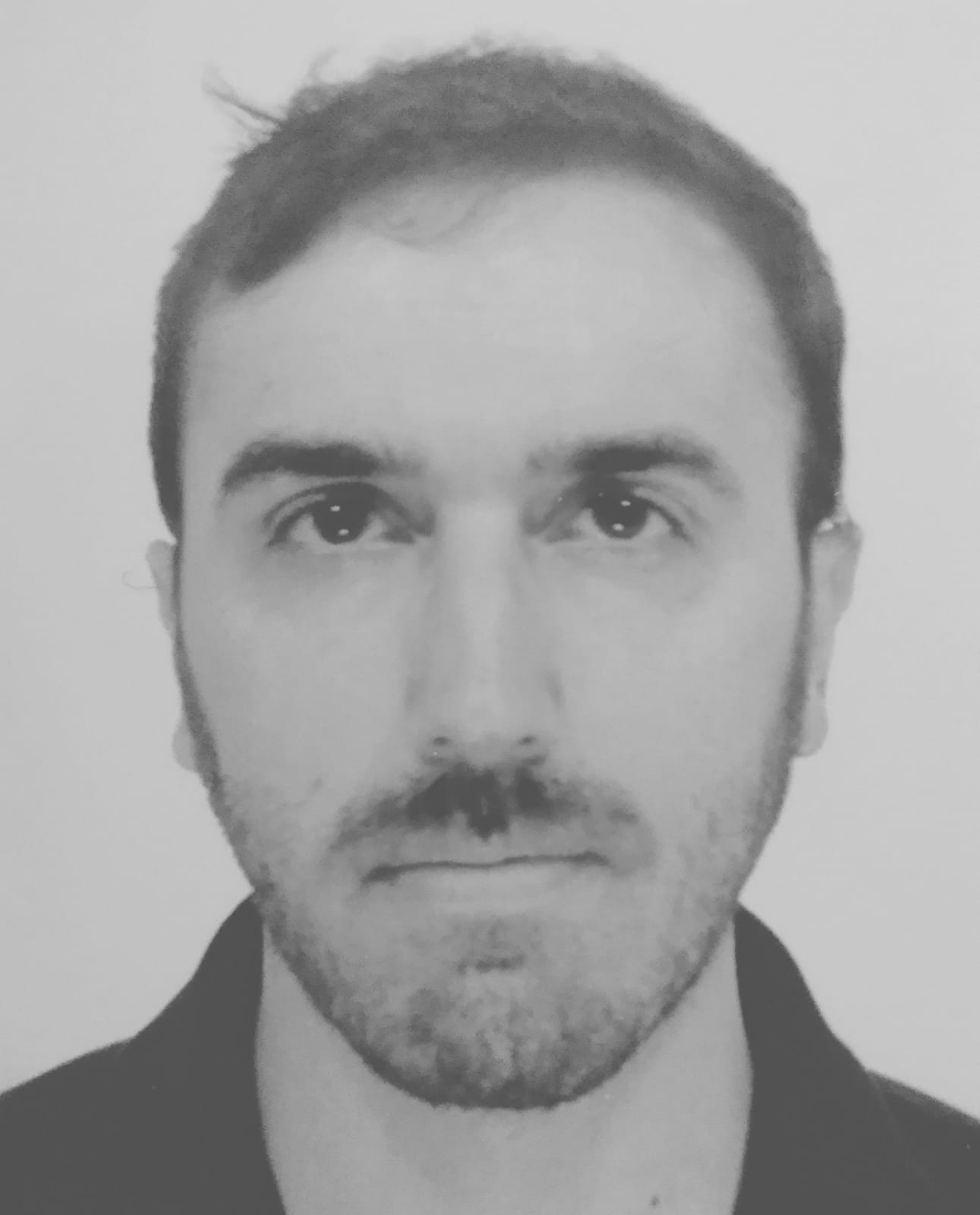L’era di un nuovo mondo: così Trump sconvolge il World Liberal Order e spacca l’Occidente in due

Addio multilateralismo. Addio alleati. Addio globalizzazione. E democrazia liberale sotto attacco. Il presidente Usa sta sconvolgendo l'ordine mondiale liberale retto dagli Stati Uniti per 80 anni. Così spacca in due l’Occidente. Ma l’Europa è ancora solo una mera aspirazione
Nel 2002, all’indomani degli attentati alle Torri Gemelle, in un libro dal titolo “La morte dell’Occidente” il commentatore politico Pat Buchanan scrisse parole che – rilette oggi – suonano come profetiche rispetto all’ascesa al potere di Donald Trump: «Poiché è un progetto delle élites, e poiché i suoi architetti sono sconosciuti e non amati, il globalismo si schianterà sulla Grande Barriera Corallina del patriottismo». E ancora: «Se le élites dei professionisti si stanno spostando a sinistra, i bianchi poveri si stanno spostando a destra».
Il pensiero Buchanan, tra i più influenti esponenti della corrente paleoconservatrice interna al Partito Repubblicano, già consigliere dei presidenti Nixon, Ford e Reagan, è considerato una delle principali fonti d’ispirazione per la dirompente visione del mondo di Trump.
Il magnate del settore immobiliare è stato eletto alla Casa Bianca per la seconda volta in otto anni proprio ergendosi a paladino degli esclusi della globalizzazione e promettendo di ridefinire nel profondo l’identità della potenza statunitense. Il suo «America First» è un impegno a mandare in frantumi quel World Liberal Order plasmato dalle élites prese di mira da Buchanan. Nella «nuova età dell’oro» trumpiana non c’è spazio per il multilateralismo, la libera circolazione delle merci, la protezione militare degli alleati.
«Nell’arco di soli 50 giorni, il presidente Trump ha fatto più di tutti i suoi predecessori moderni per minare le fondamenta di un sistema internazionale che gli Stati Uniti hanno faticosamente eretto negli 80 anni trascorsi dalla loro uscita vittoriosa dalla Seconda guerra mondiale», ha notato David Sanger, storico cronista politico del New York Times. «Vivere a Washington in questi giorni significa sentirsi come se si fosse presenti alla distruzione».
Da Truman a Donald
Il 12 marzo 1947, due anni dopo la sconfitta del nazismo, in un memorabile discorso al Congresso, l’allora presidente Harry Truman affermò che «la politica degli Stati Uniti deve essere quella di sostenere i popoli liberi che resistono ai tentativi di sottomissione da parte di minoranze armate o di pressioni esterne». L’idea alla base della cosiddetta “Dottrina Truman” era che difendere la democrazia all’estero fosse vitale per gli interessi nazionali degli Stati Uniti.
Di lì a poco fu annunciato il Piano Marshall: 12,7 miliardi di dollari stanziati dagli Usa – principalmente a fondo perduto – per aiutare i Paesi dell’Europa occidentale nella ricostruzione post-bellica. In quello stesso solco, nel 1949 Washington promosse la creazione della Nato, un’Alleanza militare con cui sostanzialmente gli Stati Uniti si facevano garanti della sicurezza dei loro affiliati in caso di attacco sovietico. Nel preambolo del trattato istitutivo, i Paesi firmatari si impegnavano a «salvaguardare la libertà, il patrimonio comune e la civiltà dei loro popoli, fondata sui principi di democrazia, libertà individuale e stato di diritto».
Ebbene, quell’approccio appartiene ormai al passato. Trump è interessato poco o nulla alla difesa della democrazia liberale. Tantomeno all’estero.
Già nel 1987 l’allora semplice tycoon pubblicò una lettera a tutta pagina su tre quotidiani statunitensi per criticare l’impegno degli Usa nella protezione degli alleati: «Il mondo – scrisse – ride dei politici americani mentre proteggiamo navi che non ci appartengono, che trasportano petrolio di cui non abbiamo bisogno, destinato ad alleati che non ci aiuteranno».
Adesso che è alla Casa Bianca, Trump minaccia di tradurre quella riflessione critica in azione politica. «Se non pagano, non li difenderò», ha detto poche settimane fa parlando degli altri Paesi membri della Nato.
Per la verità, prima di lui anche il democratico Barack Obama aveva esortato l’Europa a spendere di più, definendola «compiacente rispetto alla propria difesa». Ma The Donald è più truce e più ostile, anche nei toni: «Gli europei – ha detto – sono dei parassiti».
TPI esce in edicola ogni venerdì
Abbandonare Paesi stranieri al proprio destino è una pratica che il neo-presidente ha perseguito anche quando ha deciso di smantellare l’80% dei programmi di UsAid, l’Agenzia statunitense per lo Sviluppo internazionale che fornisce aiuti umanitari e finanziamenti a governi, aziende e ong di mezzo mondo.
Non si trattava certo di meri atti di generosità: nel 1961 l’Agenzia fu creata dall’allora presidente Kennedy con l’obiettivo di impedire che il caos e la miseria travolgessero altri Paesi finendo per danneggiare anche gli Stati Uniti. Si chiama «soft power». Ma la convinzione diffusa oggi in America, di cui Trump si fa interprete, è che la principale superpotenza mondiale sia stata finora sistematicamente sfruttata dal sistema che essa stessa ha creato. E quindi, grazie e arrivederci.
Onu, che fastidio
Il 47esimo presidente immagina un ordine globale regionalizzato in cui i Paesi più potenti dispongono di determinate sfere d’influenza e fanno valere la propria forza sui più deboli. Il multilateralismo cede così il passo a un bilateralismo fondato sulla prepotenza.
In linea con questa visione, le organizzazioni internazionali vengono percepite con manifesto fastidio da Trump. Figurarsi l’Onu, un’organizzazione per la pace fondata sul diritto internazionale.
Le Nazioni Unite furono costituite nel1945 su iniziativa proprio degli Stati Uniti (non a caso, nella versione originaria dalla bandiera Onu, gli Usa sono raffigurati al centro) con l’intento strategico di dare una legittimità istituzionale almeno apparente al “superiore” modello americano: quella supremazia veniva resa accettabile dal fatto di radicarsi in un ordine mondiale liberale, aperto e regolamentato.
Per il tycoon è tutta fuffa: le organizzazioni internazionali violano la sovranità nazionale degli States, limitano la loro libertà di azione e costano troppo. Ecco spiegata la raffica di ordini esecutivi con cui il presidente, appena insediato, ha deciso l’uscita del suo Paese da una lunga serie di trattati internazionali, fra cui l’Organizzazione mondiale della Sanità, il Consiglio Onu per i diritti umani e gli Accordi sul Clima di Parigi.
L’obiettivo dichiarato di annettere Groenlandia, Canale di Panama e persino Canada, così come le minacce nei confronti del Messico e la scarsa considerazione per le rivendicazioni dei popoli ucraino e palestinese sono una diretta conseguenza di questo modus pensandi.
Come ha osservato la storica Jennifer Mittelstadt sul New York Times, «è un periodo tumultuoso per le relazioni internazionali, meno centralizzato e meno governato da principi condivisi».
Cortocircuito a destra
Il discorso di Trump fa presa su una larga parte di cittadini statunitensi (oltre 77 milioni di voti raccolti alle ultime elezioni). La maggioranza degli analisti concorda nel rintracciare l’origine di questo consenso in una serie di errori strategici commessi dagli Stati Uniti negli ultimi 25 anni. Sul piano militare, con le disgraziate campagne in Afghanistan e Iraq. E su quello economico, con la decisione – presa nel mondo temporaneamente unipolare del post-Guerra fredda – di promuovere a ogni latitudine l’abbattimento delle barriere commerciali, al punto da includere nel grande e sregolato mercato globale anche la Cina, senza accorgersi che così si stava favorendo la sua ascesa a superpotenza mondiale.
La globalizzazione sospinta dagli Usa ha prodotto effetti collaterali – aumento delle disuguaglianze e de-industrializzazione – sui quali si è poi innestata la crisi finanziaria del 2008. Il successo politico di Trump nasce lì.
Tra gli anni Ottanta e Duemila, il neoliberismo ha di fatto snaturato la sinistra, permeandola sul piano dei programmi economici e portandola a concentrare la propria attenzione sulle battaglie civili più «politically correct». Così, in un singolare cortocircuito, quando le questioni sociali sono esplose, il principale avversario della destra liberal era diventata la destra reazionaria. In assenza di un’alternativa, è in quell’area che ha trovato una rappresentanza il risentimento delle classi (operaie e non) tagliate fuori dal disegno globalista.
Arriva “Tariff Man”
Nel 2000 negli Usa erano oltre 17 milioni i lavoratori nell’industria, pari al 13% del totale degli occupati. Nel 2024 il loro numero era calato a 13 milioni, ovvero l’8% del totale.
Proprio la perdita di posti di lavoro nelle fabbriche americane è alla base del ragionamento che ha convinto il neo-presidente a promulgare dazi sui beni provenienti da oltre 100 Paesi.
L’obiettivo dichiarato – sulla cui realizzabilità pesano molte incognite – è quello di scoraggiare le importazioni dall’estero e rianimare la manifattura statunitense. Ma c’è anche un’altra possibile spiegazione per la guerra commerciale dichiarata da Trump: come sottolineato dal nuovo presidente del Council of Economic Advisors della Casa Bianca, Stephen Miran, le tariffe potrebbero essere usate come efficace arma negoziale allo scopo di ottenere da Europa e Cina la disponibilità a comprare debito Usa.
Quel che è certo è che i dazi rischiano di far molto male ai Paesi dell’Unione europea. Su tutti Germania e Italia, per i quali l’export verso gli Stati Uniti vale rispettivamente il 4 e il 3% del Pil nazionale.
«Le nazioni europee ci stanno derubando, pensano che siamo stupidi», attacca Trump.
Uomini duri
Sembra quasi che i governi con cui il presidente ha maggior fretta di litigare siano quelli occidentali. Al contrario, sono riprese le relazioni dirette con il presidente russo Vladimir Putin.
Il tycoon condivide con il leader del Cremino l’idea di un mondo multipolare dominato da grandi potenze libere di agire senza l’intralcio del diritto internazionale, avendo come unica stella polare il perseguimento del proprio specifico interesse nazionale.
Secondo George Packer, analista della rivista The Atlantic, «America First è più imperialista che isolazionista»: Trump «sta liberando se stesso e il Paese dai codici restrittivi (lo stato di diritto in patria, l’ordine basato sulle regole all’estero) e li sta sostituendo con un semplice test: “Cosa ci guadagno?”. Sta disarmando unilateralmente l’America del suo soft power, rendendo gli Stati Uniti non diversi dalla Cina, dalla Russia o dall’Iran».
Non solo. Autocrati come Putin e l’ungherese Viktor Orbán sono vicini all’attuale presidente degli Usa anche sul piano dei valori ideali. Tutti insieme rabbiosamente impegnati nella crociata contro il «wokismo» e le rivendicazioni della comunità Lgbtq+. E poi negazionisti del cambiamento climatico, considerato un’invenzione delle lobby ambientaliste. E ancora, anti-abortisti. E, almeno nel caso di Trump e Orbán, incondizionatamente alleati di Israele, anche quando il suo premier Benjamin Netanyahu fa massacrare decine di migliaia di civili innocenti, fra cui migliaia di bambini.
Così l’Amministrazione Usa vieta da un giorno all’altro di usare sui documenti federali parole come «transgender» o «crisi climatica», fa arrestare gli studenti stranieri che manifestano per la Palestina e vota con Russia e Corea del Nord contro una risoluzione Onu che condanna l’invasione dell’Ucraina.
Frammentazione finale
A inizio marzo, tre giorni dopo lo scontro in diretta tv alla Casa Bianca tra Volodymyr Zelensky, Trump e il suo vice J.D. Vance, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha rilevato che «l’Occidente ha iniziato a frammentarsi».
In effetti è così. Le politiche del «Make America Great Again» stanno esasperando le inveterate divisioni interne all’Unione europea e sono destinate – per certi versi persino orientate – a rompere il ponte ideale che unisce le due sponde dell’Atlantico. Così il fronte occidentale si spezza in due.
Ma se l’Occidente alla maniera di Trump sta assumendo connotati molto precisi, l’altro Occidente – che in linea teorica dovrebbe far capo al vecchio continente – è ad oggi ancora una mera aspirazione, soffocata dal chiasso di ventisette voci che si sovrappongono. E che diventano quindi irrilevanti nel caos globale di questa nuova era.
Lo storico Hal Brands ha scritto su Foreign Affairs che se Trump seguirà i suoi istinti più «distruttivi», gli Usa «diventeranno meno impegnati a livello globale ma più aggressivi, unilaterali e illiberali. Non saranno una superpotenza assente ma una superpotenza rinnegata, un Paese che alimenta il caos globale e aiuta i suoi nemici a rompere il sistema guidato dagli Stati Uniti». In altre parole, «il rischio più grande» del secondo mandato del tycoon «non è che [Trump] abbandonerà l’ordine liberale. È che renderà gli Stati Uniti attivamente complici della sua scomparsa».