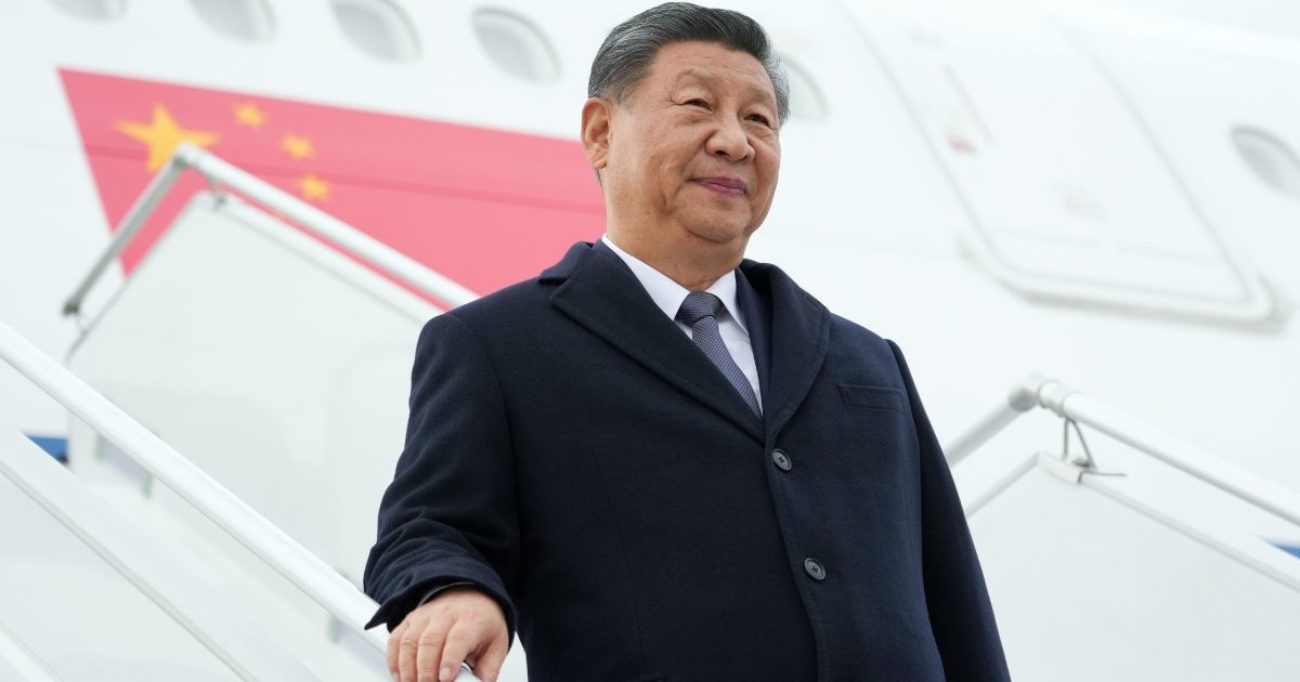Memorie da Tripoli: la fuga degli ebrei libici nel 1967

Alla fine degli anni Sessanta, a causa delle crescenti violenze della comunità araba su quella ebraica, migliaia di ebrei furono costretti a emigrare dalla Libia
Sono le otto di mattina e una folla imbestialita marcia verso la Città Vecchia, la zona nord-occidentale di Tripoli, in Libia. È il giugno del 1967 e in concomitanza con la Guerra dei Sei Giorni – un conflitto tra Israele, Egitto, Siria e Giordania – gli ebrei di Tripoli sono il bersaglio della comunità araba locale. Bruciano i negozi, distruggono le macchine, entrano nelle case degli ebrei, profanano templi e rotoli della Torah.
Giulia, ebrea trentenne, sta correndo da un terrazzo all’altro con in braccio il più piccolo dei suoi tre figli, un neonato di pochi mesi. Non sa da che parte scappare, teme per la sua famiglia e per i suoi bambini. Le sembra di essere in un incubo.
Fino a quel giorno, a Tripoli gli ebrei convivevano con gli arabi. Tuttavia in quegli anni si respirava una crescente atmosfera di ostilità, principalmente in conseguenza della creazione dello Stato di Israele il 14 maggio del 1948. Quello stesso anno dimostrazioni e sommosse contro la comunità ebraica libica aumentarono considerevolmente.
I rapporti tra la comunità araba e quella ebraica si facevano sempre più instabili. Tra gli ebrei, vi era una crescente preoccupazione e ci si interrogava sull’esigenza di lasciare la propria patria ed emigrare in un luogo sicuro. Tuttavia, per alcuni, era difficile pensare di poter lasciare Tripoli.
Giulia, ad esempio, era la figlia del proprietario di una grossa distilleria e moglie del gestore di uno stabilimento in cui si produceva materiale da costruzione. “La vita della mia famiglia a Tripoli era agiata, – racconta Giulia – avevamo una bella casa, una Volkswagen e i nostri figli andavano alla scuola privata delle suore bianche”.
Tripoli aveva le sembianze di una città italiana. Nel 1934, sotto l’impulso di Benito Mussolini, l’Italia avviò una politica di colonizzazione della Libia, costruendo infrastrutture come strade, ponti, ospedali e scuole. La colonizzazione italiana della Libia (1934-1947), terminò con il Trattato di pace firmato tra l’Italia e le potenze vincitrici della seconda guerra mondiale, con cui lo Stato italiano doveva rinunciare a tutte le sue colonie, compresa la Libia.
Dato il lungo periodo di colonizzazione, tutte le vie principali di Tripoli portavano nomi come Corso Vittorio, Piazza Italia o via Dante. Era una bellissima città, c’era lusso e ricchezza, alberghi eleganti e spiagge paradisiache. Nella stessa città convivevano arabi, ebrei e cristiani. Le donne arabe si riconoscevano facilmente poiché nascoste dietro ai baracani, antenati del burqa, che le coprivano interamente lasciando solo un occhio scoperto.
La calma era però solo apparente. In realtà, la censura era asfissiante, le donne non potevano uscire da sole senza essere importunate da sguardi indiscreti e mani invadenti. Gli ebrei inoltre erano soggetti a diverse restrizioni.
A nessun ebreo era concesso avere il passaporto. Per lasciare la Libia, si doveva richiedere il Travel, un documento provvisto di un visto valido per tre mesi. Nessun nucleo famigliare poteva lasciare il paese senza che uno dei familiari rimanesse in Libia. Gli ebrei potevano fare i commercianti, ma non potevano assumere posizioni di rilievo all’interno della società.
Con la Guerra dei Sei Giorni, le tensioni esplosero definitivamente. Il 5 Giugno del 1967 a Tripoli si scatenò un pogrom contro gli ebrei. Il bersaglio era la hara, quartiere ebraico della città. La folla era violenta e accecata dall’odio e i risvolti furono drammatici: 17 ebrei vennero trucidati. Tre di questi furono pugnalati. Due famiglie vennero prelevate da un finto ufficiale libico con la scusa di essere portate in salvo in un campo di raccolta: appena fuori città, furono uccise.
TPI esce in edicola ogni venerdì
Giulia ricorda quel giorno come se fosse ieri: “Mentre ero in fuga e correvo tra un terrazzo all’altro dei palazzi di Tripoli, ho rivolto lo sguardo alla strada solo per un attimo. Proprio in quel momento, ho visto un gruppo di arabi uccidere brutalmente il figlio del nostro macellaio, 19 anni, mentre tentava di aprire il locale del padre così come faceva ogni mattina”.
Quei giorni furono un inferno per gli ebrei libici. La famiglia di Giulia rimase in casa per un mese insieme al marito Aldo e i figli Josy, nove anni, e Gaby, di pochi mesi.
“All’appello mancava mia figlia Elizabeth, sette anni, che era rimasta all’asilo dalle suore bianche dalla mattina del 5 giugno, giorno del pogrom contro gli ebrei”, ricorda.
Le suore bianche la riportarono a casa tre giorni dopo, camuffata da bambina araba.
Per alcuni aspetti, la famiglia di Giulia poteva ritenersi più al sicuro delle altre. Non abitavano nel quartiere ebraico e il loro appartamento aveva una porta blindata, un lusso a quei tempi. Nonostante ciò, non c’era giorno in cui Giulia non ricevesse minacce telefoniche. “Presto arriverà il tuo momento, stiamo arrivando a prendere i tuoi figli”, le ripetevano tutti i giorni al telefono.
“Non facevo altro che pregare, pregavo che non venissero a prenderci gli arabi, pregavo per la salvezza dei miei figli, pregavo che saremmo riusciti a emigrare al più presto”.
Vista la condizione degli ebrei libici, impossibilitati a uscire di casa senza mettere a repentaglio la propria vita, l’unica soluzione per la comunità ebraica di Tripoli rimaneva l’espatrio. Tuttavia, per un ebreo lasciare la Libia non era così facile. Serviva un visto rilasciato dalle autorità locali.
Preoccupato della condizione degli ebrei di Tripoli, il presidente della comunità ebraica in Libia inviò un appello al primo ministro locale per ottenere un permesso speciale affinché gli ebrei potessero lasciare il paese anche solo momentaneamente. Pochi giorni dopo, il permesso venne accordato con l’approvazione del Re Idris.
Seppur non avesse preso alcuna posizione riguardo alla Guerra dei Sei Giorni, sul primo re di Libia pesava la responsabilità di non essere riuscito a garantire l’incolumità degli ebrei libici. Dunque al Re Idris non rimaneva altra scelta che farli espatriare, seppur per un tempo limitato.
Entro settembre del 1967, circa 4.100 ebrei libici emigrarono in Italia. Giulia e Aldo erano tra questi e nel mese di giugno del 1967, raggiunsero l’Italia.
“All’aeroporto ci eravamo divisi. Non potevamo lasciare la Libia come famiglia unica, non ce l’avrebbero permesso. Dunque ho finto di non essere sposata e ho viaggiato con il mio cognome da nubile”. Il viaggio non fu facile. Giulia raccontò alle autorità libiche di voler lasciare il paese per andare a un matrimonio in Italia.
Al fine di rendere la sua versione più credibile, mise in valigia un vassoio d’argento come regalo per la coppia sposata, un vestito da sera e un bel bracciale da indossare al ricevimento. Ma soprattutto si raccomandò con i suoi figli, il più grande di nove anni, di non chiamarla mamma in pubblico e di non avvicinarsi a lei per nessun motivo.
Le autorità libiche, sospettose fino all’ultimo, cercarono di mettere Giulia in difficoltà. Persino sull’aereo, prima del decollo, la perquisirono davanti a tutti i passeggeri, compreso il marito, che dovette stare a guardare fingendo di non conoscerla.
Aldo e Giulia arrivarono in Italia con i loro tre figli e nient’altro. Non avevano soldi, vestiti, oggetti di valore. Dovettero abbandonare tutta la propria vita alle spalle.
“A Tripoli ho lasciato tutti i miei ricordi, tutte le fotografie dell’infanzia dei miei bambini, i loro giocattoli preferiti, la nostra prima casa”.
Tutti i 4.100 ebrei che sono stati costretti ad andare via da Tripoli alla volta dell’Italia subirono la stessa sorte. Sono dovuti partire con poche monete in tasca – venti sterline a testa per l’esattezza – e lasciare tutti i loro beni in Libia, confiscati dalle autorità locali.
In Italia furono riconosciuti rifugiati sotto l’egida dell’Alto Commissario dell’Onu. Molti di loro si stabilirono a Roma. La gioventù lavorava per mantenere i genitori. Le famiglie ebree vivevano nella miseria aspettando ogni giorno, alla stazione Termini o all’aeroporto di Fiumicino, notizie sui propri cari. Molte famiglie erano divise tra la Libia e l’Italia.
Giulia si trasferì per pochi mesi a Ostia con la sua famiglia, per poi spostarsi in Via Pascarella, a pochi passi dalla stazione Trastevere. Rimase in Italia fino al 1970, anno in cui la sua famiglia decise di fare Aliyah, ovvero trasferirsi in Israele.
Ancora oggi, Giulia vive a Tel Aviv.