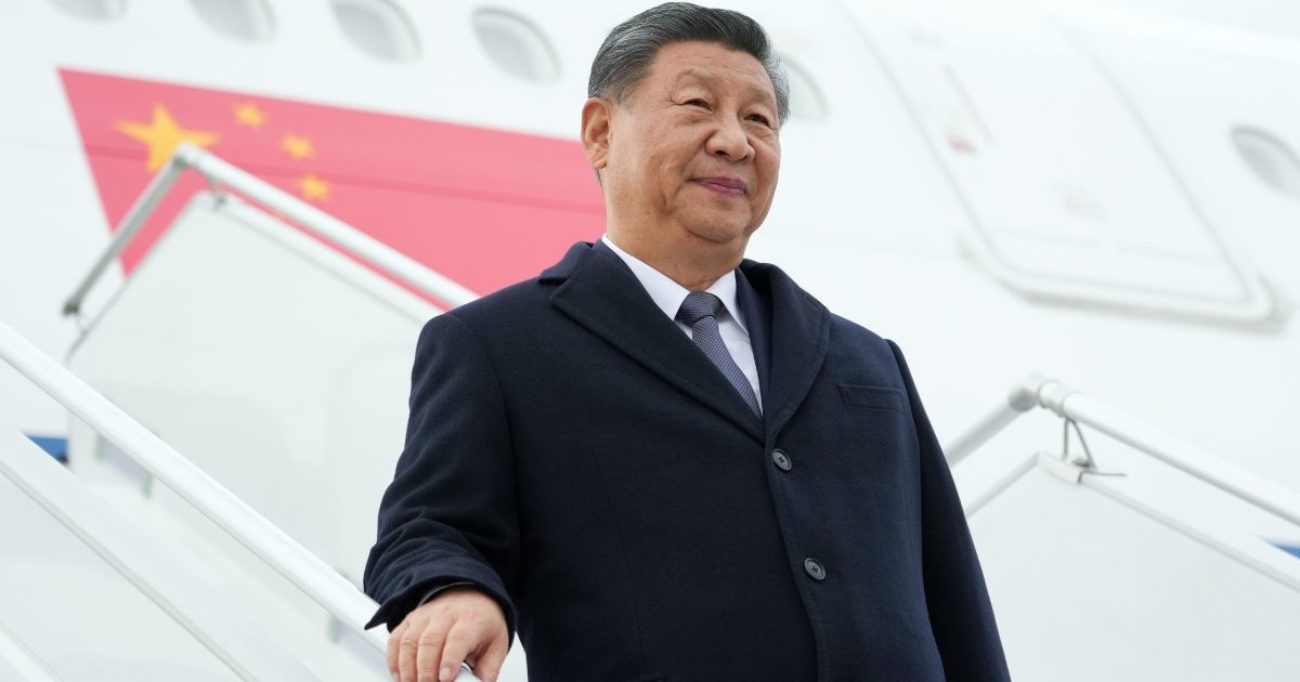Libia, le dimissioni di Sarraj sono un segno di stabilizzazione ma i veri problemi restano armi e petrolio (di A. Lanzetta)

Qualcosa si sta muovendo in Libia ma il raggiungimento della pace e della stabilità in un Paese così importante per l’Italia non è affatto scontato
I nuovi sviluppi politici in Libia fanno finalmente sperare in una ricomposizione della drammatica crisi che attanaglia il Paese africano da oltre 9 anni ma approfondendo le ragioni e le divisioni interne alla nostra ex colonia la situazione appare ancora molto complicata e di difficile soluzione, nonostante i proclami e le aspettative di pace.
Il premier del Governo di Accordo Nazionale libico, l’unico riconosciuto legittimo dalle Nazioni Unite in Libia, Fayez al-Sarraj, ha annunciato l’intenzione di rassegnare le proprie dimissioni entro ottobre e di trasferire i propri poteri a un nuovo esecutivo che dovrà emergere dai colloqui di pace cominciati in Marocco e che proseguiranno in Svizzera.
L’annuncio segue di pochi giorni la caduta di un altro governo libico, quello “parallelo” della Cirenaica, non riconosciuto dalla comunità internazionale e presieduto da Abdullah al Thinni, che nella giornata di domenica 13 settembre “ha presentato le proprie dimissioni al presidente della Camera dei Rappresentanti (di Tobruk), Aguila Saleh”, dopo giorni di proteste di piazza e persino attacchi a sedi istituzionali.
Qualcosa si sta certo muovendo ma il raggiungimento della pace e della stabilità nel Paese africano, così centrale – non solo a livello geografico nel Mediterraneo e per l’Italia – non è affatto scontato. In un meno di un mese, al-Sarraj e Saleh hanno dapprima annunciato un cessate il fuoco su tutto il territorio libico e la ripresa del processo politico per organizzare nuove elezioni a marzo, poi il 10 settembre, dopo giorni di colloqui a Bouznika, in Marocco, le delegazioni dell’Alto Consiglio di Stato di Tripoli e del parlamento di Tobruk, hanno raggiunto un accordo sui criteri e i metodi di gestione della sovranità in Libia.
Inserite in questo quadro, le dimissioni delle due amministrazioni rivali in Tripolitania e Cirenaica rappresentano un passo avanti se non per la soluzione quantomeno per la semplificazione del complesso quadro del Paese ma i fattori contrari alla stabilizzazione restano ancora molti. A partire da Khalifa Haftar, il signore della guerra appoggiato da Russia, Egitto ed Emirati Arabi Uniti, comandante dell’Esercito nazionale libico che, seppur sconfitto e progressivamente isolato e nonostante la sostanziale adesione (per propria debolezza militare) alla sospensione delle ostilità, è ancora in campo dopo aver liquidato come semplice “marketing” la distensione tra Tripoli e Tobruk.
A questo si vanno ad aggiungere le varie milizie coinvolte nel conflitto da più parti e a vario titolo che andranno sciolte, disarmate o integrate in una forza unita, presumibilmente a tutto vantaggio dei loro comandanti e finanziatori, spesso anche implicati nel traffico di esseri umani. Senza dimenticare il ruolo delle tribù, finora non direttamente interpellate dal più recente processo negoziale e sempre pronte a dire la propria e in alcuni casi a cambiare bandiera, e i mercenari stranieri foraggiati dalle diverse fazioni in conflitto. Fino ad arrivare al petrolio, la cui produzione fermata da Haftar non è ancora ripartita e la cui gestione dei profitti rappresenta sin dall’inizio della crisi libica il vero oggetto del contendere tra le parti in guerra e gli attori internazionali interessati.
L’evoluzione della crisi: quale direzione prende la Libia?
L’annuncio delle dimissioni del capo del governo di Tripoli accelera innanzitutto la tabella di marcia prevista dai colloqui tenuti la scorsa settimana in Marocco. Le parti avevano infatti stabilito di incontrarsi il mese prossimo a Ginevra per concordare la formazione di un nuovo consiglio presidenziale e organizzare le elezioni entro 18 mesi.
Secondo le indiscrezioni circolate negli scorsi giorni sui media statunitensi, il premier del governo libico internazionalmente riconosciuto aveva sì in programma di rassegnare le proprie dimissioni prima dei colloqui in Svizzera ma sarebbe comunque rimasto in carica come primo ministro dimissionario, a garanzia della buona riuscita dei negoziati.
Nel suo discorso in televisione invece, Sarraj ha invitato le parti ad accelerare il dialogo e a nominare al più presto un nuovo esecutivo favorendo il passaggio dei poteri entro la fine di ottobre e segnando la fine di cinque anni di contrastata e controversa leadership su un’amministrazione che raramente è riuscita a controllare più della sola capitale e della costa della Tripolitania.
Le ragioni delle dimissioni del premier libico, intese ufficialmente a favorire il processo di pace, nascondono proprio alcuni dei fattori contrari alla stabilizzazione della Libia. Queste risiedono forse più nelle lotte intestine alla difficile alleanza tra le fazioni politiche e le milizie che appoggiano il governo di Tripoli, rimaste unite fintantoché la capitale rischiava di finire sotto il giogo di Haftar, che nei negoziati avvenuti in Marocco, come dimostrato non più di qualche settimana fa dalla sospensione e poi dal reintegro del ministro dell’Interno, Fathi Bashagha.
TPI esce in edicola ogni venerdì
Dopo aver guidato la difesa della città con la fondamentale assistenza della Turchia, a seguito della presa d’atto del rifiuto di un aiuto militare da parte dell’Italia, Sarraj ha dovuto affrontare un movimento di protesta contro la corruzione e la mancanza di servizi nel Paese, fortemente dipendente dai proventi del petrolio e i cui giacimenti sono stati chiusi su ordine del comandante dell’Esercito nazionale libico a partire dal 18 gennaio provocando finora, secondo la National Oil Corporation libica, almeno 9,8 miliardi di dollari di perdite.
Proprio Bashagha, considerato vicino al governo di Ankara e originario della città di Misurata, da dove provengono alcune tra le principali milizie a sostegno di Tripoli, è stato sospettato di aver fomentato o quantomeno permesso le proteste contro il governo Sarraj per poi essere frettolosamente reintegrato se non altro per evitare di indebolire ancora di più l’amministrazione riconosciuta dalle Nazioni Unite.
Sebbene il primo ministro libico sia stato spesso considerato “un’anatra zoppa” per le difficoltà nel gestire i rapporti tra i propri sostenitori, anche a livello internazionale, le sue dimissioni ed eventuali rimpasti potrebbero non riuscire a calmare le tensioni tra le fazioni che finora hanno appoggiato Tripoli ma rischiano anzi di aumentare i problemi con la necessaria condivisione del potere con gli attori della Cirenaica, che fino a ieri erano considerati i nemici da sconfiggere.
Le stesse compagini attualmente al potere nell’est del Paese sono tutt’altro che unite, come dimostrato dal golpe compiuto la scorsa primavera da Haftar, rivolto anche contro Tobruk, la cui variegata Camera dei Rappresentanti è sì riconosciuta come un corpo politico dal governo di Tripoli ma che senza l’appoggio delle truppe del generale ha visto ridurre sensibilmente il proprio peso, favorendo una ricomposizione con il governo della capitale.
La situazione in Cirenaica sembra essersi recentemente complicata ancora di più, soprattutto per il comandante dell’Esercito nazionale libico, che ha perso il favore dei Qadhafa, la tribù dell’ex dittatore Muammar Gheddafi, dopo una serie di arresti di massa dei suoi membri ad opera delle forze di Haftar. Sebbene non coinvolta nella distensione tra Tripoli e Tobruk, il ritiro del sostegno della tribù, tradizionale perno del regime ultra-quarantennale del dittatore, al generale Haftar, ex braccio destro di Gheddafi, ha di certo contribuito alla debolezza dell’Esercito Nazionale libico, che tuttavia resta ancora un attore saldamente in campo e con cui fare i conti.
La situazione internazionale e il nodo delle armi
La ricomposizione della crisi libica sembra essere lievemente favorita anche dall’evoluzione del quadro internazionale, con l’avvicinarsi delle posizioni tra Turchia e Russia, il paventato ma finora non ancora avvenuto intervento dell’Egitto e le indiscrezioni circa un possibile allentamento delle sanzioni occidentali contro il presidente della Camera dei Rappresentanti di Tobruk, Aguila Saleh. Anche da questo punto di vista però le prospettive non sono così ottimistiche, vista la situazione sul campo al di là delle dichiarazioni politiche di facciata.
Non più tardi della scorsa settimana, un panel di esperti delle Nazioni Unite ha denunciato infatti come le fazioni in lotta in Libia e i loro sostenitori internazionali abbiano violato a più riprese e continuino a violare l’embargo imposto dall’Onu sulle armi, definito “totalmente inefficace”, citando ad esempio il dispiegamento di personale militare straniero, il trasferimento di attrezzature da guerra e la spedizione di mercenari dall’estero nel Paese nordafricano.
Anche la missione EUNAVFOR MED “Irini” a guida italiana non sembra aver inciso realmente sulla violenza in corso in Libia. Istituita a marzo dal Consiglio dell’Unione europea con l’obiettivo di contribuire all’embargo sulle armi nel Paese, la sua incapacità di controllare in maniera efficace le rotte verso la Libia, senza alcun contrasto al traffico di armi per via terrestre e aerea, e l’assenza di poteri di intervento contro le violazioni del blocco non permette alla missione di cambiare le sorti del conflitto, alimentato sempre più dall’arrivo di uomini e mezzi e dalle ambizioni delle potenze internazionali interessate.
I principali attori stranieri coinvolti nel conflitto, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Francia, Russia, Turchia, Qatar e anche l’Italia, hanno tutti i propri interessi in Libia e sembrano più impegnati a impedire l’emergere di un governo contrario al proprio tornaconto che a trovare una vera soluzione alla guerra.
Se l’interventismo della Turchia nel Mediterraneo è legato a ragioni energetiche e il coinvolgimento della Russia si inserisce nel nuovo ruolo ritagliatosi dal Cremlino in Medio Oriente, le aspirazioni degli Emirati Arabi Uniti e dell’Egitto si muovono nel quadro di un maggior peso, anche economico, a cui queste medie potenze aspirano nel Mare Nostrum, mentre il nostro Paese resta per forza di cose interessato alla stabilità della Libia con particolare riguardo alla lotta all’immigrazione e alla “sete” di petrolio e gas.
Il petrolio è il vero oggetto del desiderio
Purtroppo, gli ultimi sviluppi politici in Libia, per quanto certamente incanalati verso la giusta direzione del dialogo e dei negoziati, non sembrano (ancora) affrontare i più gravi ostacoli alla fine del conflitto, né a livello interno né internazionale. La fine della crisi e la stabilizzazione del Paese passano infatti necessariamente dalla soluzione delle motivazioni economiche alla base della guerra.
Se il processo di distensione in corso tra Tripoli e Tobruk non si allargherà agli altri principali attori in campo e si limiterà a cercare di far rispettare un fragile accordo di cessate il fuoco, organizzando nuove elezioni senza disarmare o accordarsi con le milizie che effettivamente controllano il territorio e riuscire a far valere la propria voce con le potenze internazionali coinvolte, non avrà maggior successo di tutti gli altri tentativi compiuti finora.
Secondo un’ancora valida analisi dell’Atlantic Council, con la caduta di Gheddafi l’autorità effettiva in Libia si è spostata dal centro alla periferia, mentre la gestione dei proventi del petrolio è rimasta a Tripoli. In questa situazione, le varie milizie esercitano il controllo del territorio a livello locale, spesso senza l’intervento della capitale, mentre ciascun gruppo armato prova a controllare la città, “dove si trova davvero il denaro”. Il tentativo di riunificare l’amministrazione del Paese va proprio in questa direzione ma si scontra ancora con tante resistenze sul campo.
Nonostante la sconfitta, il generale Haftar, che entro il 12 settembre avrebbe dovuto riaprire i rubinetti dei giacimenti petroliferi, continua ad esempio a impedire la produzione, mettendo una serie ipoteca sulla tenuta del Paese, che questo inverno dovrà fronteggiare le maggiori esigenze energetiche della popolazione, già dimostratasi insofferente alla mancanza di servizi sia a Tripoli che in Cirenaica.
Il nodo fondamentale resta sempre la distribuzione “trasparente ed equa”, come richiesto da varie parti in conflitto, dei ricavi del petrolio e lo sfruttamento dei depositi di idrocarburi al largo della Libia che, secondo lo US Geological Survey, potrebbero contare diversi milioni di barili di petrolio e migliaia di miliardi di metri cubi di gas naturale per un valore di centinaia di miliardi di dollari. E’ qui che si scontrano gli interessi interni e delle potenze straniere coinvolte nella crisi e senza un accordo su questo punto non sarà davvero possibile stabilizzare la Libia.
Leggi anche: 1. Libia, l’Italia rischia di ritrovarsi in casa i mercenari siriani di Erdogan e Putin / 2. Libia, altro che soluzione alla crisi: per i paesi stranieri (Italia compresa) contano solo il petrolio e il gas