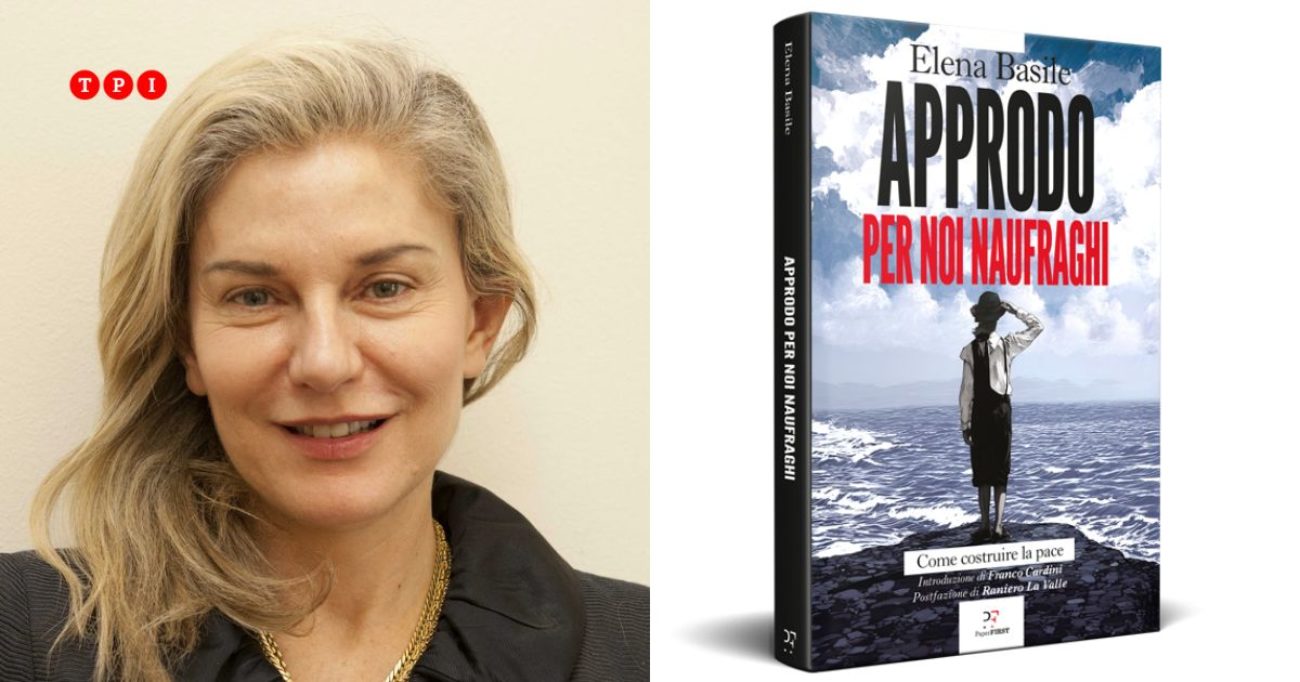Libia, altro che soluzione alla crisi: per i paesi stranieri (Italia compresa) contano solo il petrolio e il gas

Gli interessi dei Paesi stranieri in Libia sembrano prevalere sulla volontà di trovare una soluzione alla crisi, ma più la situazione resta in stallo e più l’Italia ha da perdere
Libia, conferenza Berlino: per i paesi stranieri contano petrolio e gas
Vari osservatori internazionali, tra cui l’ex presidente della Commissione europea Romano Prodi, hanno definito “mezzo vuoto” il bicchiere uscito dalla Conferenza di Berlino sulla Libia. Al di là degli aspetti positivi e negativi di un vertice che non ha prodotto alcun accordo tra le parti in Libia, ma solo (e non è poco) una dichiarazione di intenti delle maggiori potenze internazionali coinvolte, va sottolineato come il bicchiere di Berlino sia prima di tutto “sporco”.
Perché parlare di Libia significa soprattutto discutere di petrolio e del suo commercio internazionale, in particolare con l’Italia, che mantiene imprescindibili legami economici e soprattutto energetici con la propria ex colonia, e dei rapporti tra una serie di Paesi stranieri con le milizie impegnate nella guerra.
Il proseguire del conflitto si gioca infatti sulla lotta tra i vari gruppi armati per la gestione dei proventi della vendita degli idrocarburi, che rappresentano circa il 90 per cento delle entrate del Paese africano, il cui principale partner commerciale è proprio l’Italia, destinazione di circa il 18 per cento delle esportazioni totali libiche, complessivamente composte per oltre il 97 per cento da prodotti petroliferi e derivati.
Conferenza di Berlino sulla Libia, gli interessi economici dell’Italia
L’influenza del petrolio sulla vita quotidiana degli italiani, evidente in vari aspetti dell’economia, dai consumi, al lavoro, alla produzione industriale fino all’inflazione, rende impossibile per il nostro Paese ignorare quanto accade in Libia. Se il 35,4 per cento dei consumi totali di energia in Italia sono assorbiti dai trasporti, i prodotti petroliferi incidono per il 91,8 per cento su questo settore e per il 5,5 per cento sui prezzi alla produzione dell’intera industria italiana. Inoltre, i “carburanti e lubrificanti per mezzi di trasporto privati” gravano per oltre il 4,13 per cento sui prezzi al consumo nel nostro Paese, che dipende dall’estero per il 77 per cento del proprio fabbisogno energetico nazionale.
La Libia ospita le maggiori riserve accertate di petrolio in Africa, superiori secondo i dati dell’Opec a 48 miliardi di barili, oltre ai circa 26 miliardi di barili di riserve tecnicamente recuperabili di olio di scisto. Tripoli potrà inoltre sfruttare parte delle ingenti risorse di idrocarburi stimate nel Mediterraneo centro-orientale. Secondo lo US Geological Survey, la regione potrebbe contenere diversi milioni di barili di petrolio e migliaia di miliardi di metri cubi di gas naturale per un valore di centinaia di miliardi di dollari. Queste risorse potrebbero così incrementare il potenziale di uno dei principali Paesi detentori di riserve di idrocarburi al mondo.
Secondo Eurostat, tra il 2007 e il 2017, la Libia ha fornito il 5,2 per cento di tutto il petrolio importato nell’Unione europea mentre, secondo l’Unione petrolifera, nel 2018 il Paese africano ha venduto all’Italia il 10,2 per cento del greggio arrivato nel nostro Paese, una percentuale più che dimezzatasi dall’inizio del conflitto, ma raddoppiata negli ultimi due anni.
Il petrolio occupa così la seconda posizione tra le principali importazioni in Italia dove, secondo il ministero dello Sviluppo Economico, nel 2018 sono stati consumati 60,9 milioni di tep di prodotti petroliferi, pari al 34 per cento dei consumi energetici nazionali, facendo di questa la seconda fonte di energia più consumata nel nostro Paese dopo il gas naturale. Secondo i dati dell’Unione petrolifera, nello stesso anno l’Italia ha importato oltre 37 miliardi di euro di petrolio e derivati, con il solo greggio a rappresentare il 6,5 per cento delle importazioni complessive nel nostro Paese e la Libia a pesare da sola per l’1 per cento su tutto l’import italiano.
Il ruolo dell’Eni
Non sorprende quindi che la principale azienda coinvolta nei rapporti tra Italia e Libia sia ovviamente l’Eni, la multinazionale controllata dal ministero dell’Economia e delle Finanze, per cui il Paese africano risulta sempre più importante e dove il Cane a sei zampe ha addirittura aumentato il proprio peso relativo dall’inizio del conflitto.
Secondo la Relazione finanziaria annuale 2018 dell’azienda, la Libia “rappresenta il 16 per cento della produzione d’idrocarburi complessiva” di Eni, presente nel Paese dal 1959, mentre nel 2018 la produzione libica di competenza della società è stata pari a 302 mila barili equivalenti di petrolio al giorno, superiore al 31,75 per cento della produzione petrolifera libica complessiva, arrivata nello stesso anno a una media di oltre 951 mila barili al giorno.
Pur registrando un calo delle attività a causa del conflitto in corso dal 2011, il peso relativo di Eni nel Paese africano è comunque aumentato. Nell’anno precedente lo scoppio delle ostilità infatti, la quota di competenza dell’azienda in Libia (273 mila boe al giorno) rappresentava poco più del 14 per cento della produzione media giornaliera totale, attestatasi allora a 1,91 milioni di barili al giorno.
Al confronto, la francese Total, principale concorrente del Cane a sei zampe nel Paese africano, ha registrato una produzione di 63 mila boe al giorno in Libia nel 2018, pari a poco più del 6,62 per cento della produzione petrolifera annua complessiva libica. Nonostante il peso ancora relativamente limitato del gruppo francese e il poco significativo aumento in valori assoluti della produzione nel Paese africano rispetto al periodo precedente al conflitto (nel 2010 Total produceva già 55 mila boe al giorno in Libia), la sua percentuale sulla produzione petrolifera libica annua totale è quasi triplicata in oltre 8 anni di guerra.
Il paragone tra i due colossi energetici coinvolge soprattutto la geografia del Paese africano e gli schieramenti nel conflitto. Se il Cane a sei zampe concentra le proprie attività in Tripolitania (nel deserto e in alcuni impianti offshore al largo della capitale) e nel sud-ovest della Libia, mantenendo stabile la produzione grazie ai 520 chilometri del gasdotto Greenstream che collega il Paese all’Italia, il gruppo francese, anch’esso presente in Fezzan, ha messo gli occhi soprattutto sul bacino della Sirte, dove comanda il maresciallo Khalifa Haftar. Ne è un esempio l’acquisizione, risalente al marzo dello scorso anno, della Marathon Oil Libya Limited, che detiene il 16,33 per cento delle quote in concessione dei giacimenti di Waha e che permetterà al gruppo transalpino di accedere alle ingenti risorse della Cirenaica, controllate proprio dall’Esercito Nazionale Libico di Haftar.
Il petrolio è il vero oggetto del desiderio
Qualsiasi attore intenda investire nell’area vive così una situazione che rasenta il paradosso, dovendo negoziare con la compagnia energetica statale libica, con sede a Tripoli, che insieme all’Eni controlla il 70 per cento della produzione petrolifera del Paese, e poi con le varie autorità e milizie locali. Se l’unico soggetto legittimato a livello internazionale a esportare idrocarburi dalla Libia resta infatti la National Oil Corporation (NOC), la maggior parte dei giacimenti si trovano in aree controllate dal maresciallo Haftar, capace di influenzare l’apertura e la chiusura di pozzi e terminal.
Le forze della Cirenaica hanno infatti disposto il fermo delle attività nei porti e nei giacimenti petroliferi dell’est della Libia prima del vertice di Berlino, mentre nel fine settimana anche i pozzi di El Sharara ed El Feel, dove opera in joint venture anche Eni, hanno interrotto la produzione, lasciando operativi soltanto gli impianti controllati dalle autorità del Governo di Accordo Nazionale di Tripoli, il solo gestore dei proventi dell’intero export petrolifero del Paese africano. Secondo i vertici della NOC, questa mossa costa alla Libia quasi 55 milioni di dollari al giorno e rischia di ridurre la produzione petrolifera del Paese di 800 mila barili al giorno, mentre al Cane a sei zampe potrebbe potenzialmente costare tra i 470 e i 730 milioni di euro all’anno.
Nel 2019, la Libia ha prodotto in media 1,2 milioni di barili di petrolio al giorno, mentre la compagnia petrolifera statale ha registrato 22,495 miliardi di dollari di ricavi. Questi fondi rappresentano il vero oggetto del contendere nel conflitto. La NOC, dichiaratamente neutrale, versa infatti i propri proventi alla Banca centrale di Tripoli, praticamente “l’unica fonte di reddito per il popolo libico”, secondo il presidente dell’azienda, Mustafa Sanalla.
Il nodo fondamentale, citato ma non risolto dal vertice di Berlino, resta “la distribuzione trasparente ed equa dei ricavi del petrolio”. Il governo di Tripoli è infatti accusato da Haftar e dalle autorità della Cirenaica, non riconosciute a livello internazionale, di ripartire in maniera diseguale questi fondi, usandoli per finanziare le milizie a sé fedeli e i mercenari stranieri, mentre l’amministrazione riconosciuta dall’Onu non intende foraggiare attori nemici.
Tutti a Tripoli!
Nonostante l’evidenza delle motivazioni economiche alla base del conflitto, attualmente il dibattito sulla Libia continua così a concentrarsi sulla necessità di far rispettare un fragile accordo di cessate il fuoco, peraltro già violato, intervenendo con poco successo sugli effetti e non sulle cause della guerra.
La mancanza di consenso da parte dei governi rivali e la carenza di autorità delle milizie impegnate negli scontri non permettono infatti da anni di concludere alcun accordo politico che sia riconoscibile da parte di tutta la miriade di attori in campo. La principale preoccupazione di questi gruppi resta il proprio finanziamento e per questo qualsiasi soluzione alla lotta per le risorse del Paese, rappresentate soprattutto dalle entrate delle esportazioni petrolifere e dai proventi delle attività criminali, come il traffico di idrocarburi ed esseri umani, non può essere altro che economica.
Secondo un’analisi dell’Atlantic Council, con la caduta di Gheddafi l’autorità effettiva in Libia si è spostata dal centro alla periferia, mentre la gestione dei proventi del petrolio è rimasta a Tripoli. In questa situazione, le varie milizie esercitano il controllo del territorio a livello locale, spesso senza l’intervento della capitale, mentre ciascun gruppo armato prova a controllare la città, “dove si trova davvero il denaro”.
Il controllo di Tripoli rappresenta così l’obiettivo dei principali attori in campo, mentre il conflitto in corso in città si modella prevalentemente sugli schieramenti in lotta durante la guerra civile del 2011, a cui si aggiungono nuovi attori internazionali.
Dal marzo del 2016 la capitale libica, oggetto da oltre nove mesi di un’offensiva di Haftar contro il Governo di Accordo Nazionale, è stata controllata principalmente da quattro diverse milizie, che si sono spartite i vari quartieri. Sebbene nominalmente leali al governo, questi gruppi, in lotta tra loro, hanno influenzato per anni l’amministrazione libica, alimentando il risentimento della popolazione.
Secondo un rapporto diffuso ad agosto scorso dallo Small Arms Survey, un progetto di ricerca indipendente del Graduate Institute di Ginevra, l’offensiva lanciata da Haftar ha cambiato radicalmente questo scenario, promuovendo la collaborazione tra i vari gruppi e il reclutamento su larga scala di volontari nelle zone fedeli al Governo di Tripoli. “La maggior parte delle forze che combattono contro Haftar proviene dalle stesse comunità che hanno sostenuto l’insurrezione contro Muammar Gheddafi”, mentre i combattenti fedeli al maresciallo libico provengono spesso da gruppi “percepiti come lealisti” all’ex dittatore.
Se è accertata la presenza in entrambi gli schieramenti sia di estremisti religiosi che di noti criminali, impegnati anche nel traffico di migranti, il documento certifica che il grosso delle forze fedeli a Tripoli, finanziate in parte dal Qatar, è composto per lo più da volontari piuttosto che da milizie armate strutturate. Secondo l’Osservatorio siriano per i diritti umani, a questi combattenti si sono già uniti almeno 2.600 mercenari siriani trasferiti dalla Turchia nel Paese africano, provenienti principalmente dalla comunità turcomanna e in parte da gruppi accusati di torture e violazioni dei diritti umani in Siria, mentre anche Ankara si appresta a inviare propri militari in Libia.
Di contro, l’Esercito Nazionale Libico guidato dal maresciallo Haftar, che tende a presentarsi come una forza armata ordinata e professionale, potrebbe invece nascondere un variegato mosaico di alleanze e gruppi armati. Secondo Wolfram Lacher dell’Istituto tedesco per gli affari internazionali e la sicurezza (SWP), tra le fila delle forze fedeli al generale libico è possibile identificare una serie di milizie riconducibili ai fratelli Al-Kani di Tarhuna, alla brigata Borg al-Nasr di Zintan e ai combattenti salafiti ispirati dal predicatore radicale saudita Rabi al-Madkhali, tutti gruppi accusati a vario titolo di aver commesso crimini in Libia. Il generale Haftar si avvale inoltre di un imprecisato numero di mercenari forniti dal Wagner Group, una compagnia militare privata russa, e dell’appoggio militare e tecnologico di Egitto e soprattutto Emirati Arabi Uniti.
Se l’interventismo della Turchia nel Mediterraneo è legato a ragioni energetiche e il coinvolgimento della Russia si inserisce nel nuovo ruolo ritagliatosi dal Cremlino in Medio Oriente, le aspirazioni degli Emirati Arabi Uniti e dell’Egitto si muovono per lo più nel solco del contrasto ai regimi nati dalle ceneri delle Primavere arabe e nell’appoggio a fazioni autoritarie e fedeli ai precedenti schemi di potere nella regione.
Un’infinita impasse
Le principali potenze straniere coinvolte, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Francia, Russia, Turchia e Qatar, sembrano così più impegnate a impedire l’emergere di un governo contrario ai propri interessi, che a trovare una vera soluzione in Libia. Il sostegno alle varie milizie rivali consente loro per il momento di mantenere proprie sfere di influenza nel Paese, alimentando il conflitto e trasformandolo in un’altra guerra per procura sullo scenario internazionale.
In questo senso va letta anche l’assenza di una politica europea comune in Libia, nel solco delle divisioni tra i vari Paesi del vecchio continente riguardo i propri interessi strategici nell’area. A questo proposito, la Conferenza di Berlino non ha certificato altro che la volontà delle potenze straniere di continuare a interferire nella crisi libica, senza però intervenire in maniera efficace.
L’impossibilità di disarmare i vari gruppi che controllano le diverse aree del Paese con un intervento internazionale, i divergenti interessi delle potenze straniere e la mancanza di volontà da parte di chi detiene i cordoni della borsa in Libia di condividere queste risorse continuano a impedire la conclusione della questione libica, che la dichiarazione d’intenti emersa dal vertice in Germania si limita più che altro a descrivere. In una situazione del genere, l’Italia sembra avere solo da perdere, soprattutto restando immobile. D’altra parte, “l’irresoluzione è peggio della disperazione”, scriveva Leopardi nello Zibaldone.