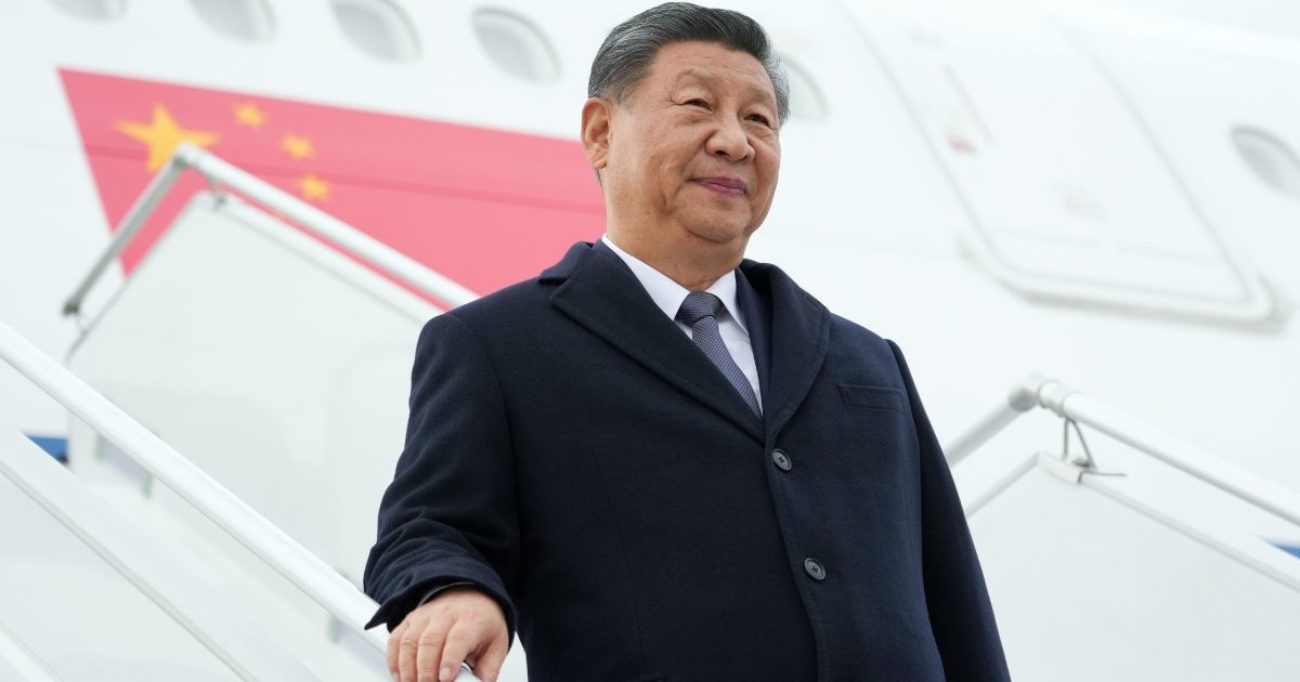La strategia mediatica di Obama in Afghanistan

Obama è riuscito a togliere l’Afghanistan dalle prime pagine dei giornali grazie alla collaborazione di un ‘professore’ e di giornalisti disponibili
Per gli americani, l’Afghanistan è un romanzo di cui è stato svelato il finale. Costruendo una strategia il cui obiettivo è “lasciare tutto in mano agli afghani”, Barack Obama ha tolto l’interesse del suo pubblico per assistere a come andrà a finire il conflitto nell’Hindu Kush. E ha escluso dal mercato della notizia una guerra costosa e impopolare (il 60 per cento degli americani non pensa valga la pena di combattere quella guerra).
La Casa Bianca è riuscita a non fare dell’Afghanistan un tema delle elezioni presidenziali. Secondo il Project for Excellence in Journalism del Pew Research Center, nel 2011 solo il 2 per cento delle notizie statunitensi ha riguardato la guerra a Kabul, relegata al settimo posto e battuta dall’economia (20 per cento), rivolte nel Grande Medio Oriente (12 per cento) ed elezioni (9 per cento). L’Afghanistan è anche uscito dai dieci temi più dibattuti sui blog e su Twitter.
Inoltre, agli americani piace come Obama ha gestito l’Afghanistan. In gennaio, un sondaggio accordava un 56 per cento di gradimento al modo in cui il presidente ha maneggiato l’Afghanistan, un aumento di 12 punti rispetto al 2011. E il 75 per cento degli americani è favorevole (o la vorrebbe accelerata) alla tabella di marcia del ritiro delle truppe.
Come ha fatto Obama a evitare critiche e attacchi sostanziali dai media? L’obiettivo del disegno mediatico del presidente sembra essere prevenire una copertura giornalistica troppo negativa che ostacoli tanto l’ordinaria “exit strategy” dall’Hindu Kush quanto le elezioni del prossimo novembre. L’uso strategico dei media da parte dell’amministrazione s’è avvalso di tre leve: a) il silenzio imposto alle opposizioni; b) la stampa “semi-indipendente”; c) fissare i termini del dibattito sfruttando la figura del “Generale Narratore”.
Arrivato alla Casa Bianca, Obama ha lanciato una revisione della strategia della guerra. Nella sua amministrazione, si scontravano due partiti: quello dei militari (più truppe per fare nation building) e quello del vice-presidente Joe Biden (meno truppe per dare solo la caccia ad al-Qa’ida). Per dare il proverbiale colpo al cerchio e alla botte insieme, Obama ha scavato una terza strada: accordare al Pentagono 33 mila soldati ma dare tempo 18 mesi per ottenere progressi, perché da luglio 2011 le truppe avrebbero cominciato il rientro.
Così, Obama ha inchiodato i militari alle loro responsabilità, prevenendone le critiche. Il 29 novembre 2009, il presidente ha convocato nello studio ovale Gates e i generali per sottoporre loro la decisione finale. Un momento in stile: “Parlate ora o tacete per sempre”. Dando l’assenso, i militari si legavano, anche mediaticamente, alla strategia: Obama ha infatti chiesto loro di salire con lui sul podio per annunciare la nuova strategia.
L’unica voce critica, quella del comandante sul campo Stanley McChrystal, è stata pagata a caro prezzo: dopo commenti (suoi e del suo staff) poco signorili sull’amministrazione registrati dal reporter di Rolling Stone Michael Hastings, il generale è stato licenziato. Annunciando la sua sostituzione, Obama ha avvisato: “Accetto il dibattito nella mia squadra ma non tollererò divisioni”. Il presidente faceva capire di essere rientrato in possesso della catena di comando militare.
La seconda leva scaturisce dalla prima. Senza un’opposizione politica che si fa campione della critica all’amministrazione, la stampa americana non riesce a svolgere il suo ruolo di “cane da guardia”. Secondo Bennett, Lawrence e Livingstone, il sistema dell’informazione americano è così “semi-indipendente”: fa notizia solo ciò che un’autorità dice a un giornalista. Il motore di questo modello, però, non è un fatto, ancor meno un fatto credibile: il motore della notizia è il potere. La stampa americana s’interessa a un argomento quando questo può essere letto in chiave di scontro politico interno a Washington o interno all’amministrazione.
Una prova? Il picco di interesse verso l’Afghanistan è arrivato negli ultimi tre mesi del 2009, quando ha attirato il 10 per cento delle notizie americane. Tuttavia, questo risveglio ha coinciso con lo scontro tra Casa Bianca e Pentagono su quante truppe inviare nell’Hindu Kush, uno scontro che si è fatto pubblico, con una serie di spifferi alla stampa.
Secondo Richard Haass, il presidente del Council on Foreign Relations, i media hanno fallito nel non porre domande “dure” all’amministrazione sull’Afghanistan: “Quanto contribuisce la guerra a rendere più sicura l’America?” oppure “Quanto costa all’economia?” o ancora “I progressi compiuti sono sostenibili?”. Il risultato è che i media conducono una critica procedurale al potere, ossia criticano il modo in cui il presidente ha gestito una politica. Raramente, invece, i media scelgono la critica sostanziale, attaccando la politica stessa o l’opportunità di adottare una strategia.
TPI esce in edicola ogni venerdì
La terza leva per l’uso strategico dei media consiste nel fissare i termini del dibattito delegando quasi totalmente ai militari la comunicazione sull’andamento della guerra. I generali Stanley McChrystal e David Petraeus (un anno a testa a capo delle truppe a Kabul tra 2009 e 2011) sono stati resi la faccia e i portavoce della guerra, aiutati dalla buona stampa che i due sono sempre stati maestri nel ricevere, tanto che il primo, nel 2009, ha corso per la copertina di “Uomo dell’anno” di Time.
L’ascesa mediatica dei due comandanti svela come, negli ultimi anni, un nuovo tipo di leadership si sia affermato tra le forze armate statunitensi: il Generale Narratore. Per questo modello di ufficiale, la battaglia che si combatte nell’etere è tanto importante quanto quella sul campo. Anzi, “le percezioni spesso contano più della realtà”, recita un mantra in voga in questi circoli militari. Evitare crolli nel supporto americano è uno dei compiti di questi generali, convinti che, per non perdere una guerra, bisogna convincere il pubblico a casa che si stanno facendo progressi.
L’obiettivo del Generale Narratore è “plasmare l’ambiente informativo”: fissare i termini del dibattito mediatico per evitare che se ne impossessi il nemico (o i critici in America). Questo non vuol dire imporre una sorta di censura che filtri solo le notizie positive: un manuale di comunicazione militare assesta la soglia di critica accettabile al 40 per cento del volume totale delle notizie. Lo stile comunicativo è piuttosto una rappresentazione selettiva della realtà.
Obama ha sfruttato i militari finché non ha potuto annunciare, nel giugno 2011, che i “progressi fragili e reversibili” erano stati raggiunti. E che era il momento di iniziare il ritiro. Da quel momento, la narrazione è cambiata: non più invertire l’iniziativa della guerra ma tornare a casa, sia pur con una “transizione ordinaria”. Obama è venuto incontro alla richiesta di “riportare i ragazzi indietro” da parte di un pubblico stanco e concentrato sulla crisi dell’occupazione.
Eppure, dal nuovo anno solo cattive notizie sull’Afghanistan affollano i media. Nessun problema. Il video dei Marines che urinano sui cadaveri dei nemici; i Corani bruciati alla base di Bagram che hanno scatenato violente proteste; il sergente americano che ha ucciso 17 civili; gli attacchi a Kabul del 15 aprile non fanno altro che dare ragione a chi vuole accelerare il ritiro. Guarda caso, Barack Obama.
Una versione più estesa di questo articolo è pubblicata col titolo “David Petraeus, il generale narratore e i media compiacenti” dal 26 aprile sul Quaderno speciale ‘Media come armi’ di Limes, la rivista italiana di geopolitica.