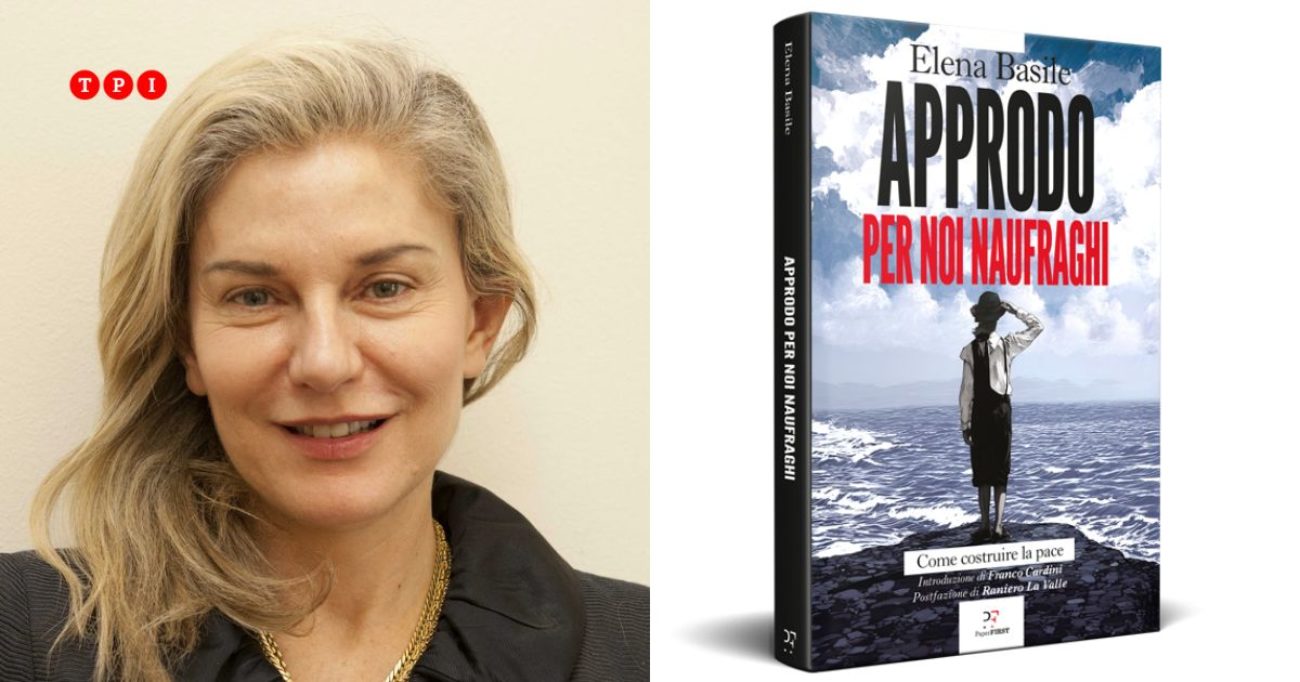Le proteste di piazza che stanno sconvolgendo l’Iraq a due mesi dal voto

A due mesi dalle elezioni in Iraq, la situazione nel sud del paese si è fatta incandescente. L'analisi di Laura Silvia Battaglia
Non c’è ancora un nuovo governo, il mandato del vecchio è formalmente scaduto lo scorso 30 giugno, le schede elettorali sono nuovamente in fase di conteggio e il sud del paese è scosso da proteste di piazza che stanno per diventare ingestibili: l’Iraq post-elettorale presenta uno scenario difficile da governare e pericoloso per il cambiamento che si presupponeva stesse per avvenire nel paese.
Ad esso si aggiunge “il tradimento” degli elettori della compagine vincitrice – Sairoon, una coalizione formata dai comunisti iracheni e dai sadristi – da parte del loro leader popolare, Mottaqa al-Sadr, che inizialmente ha portato voti al suo partito con una campagna elettorale improntata alla lotta alla corruzione e a zero compromessi con i governi precedenti ma che, a distanza di due mesi dal voto, è adesso disposto a qualsiasi cosa pur di restare in sella.
Così, a Bassora, la città più a sud del paese dove è anche più alto il numero dei lavoratori nel settore petrolifero, per la prima volta è stata data a fuoco l’immagine dell’ayatollah iraniano Khomeini, il padre della rivoluzione islamica del 1979, nell’apoteosi delle proteste che imperversano da più di una settimana nella zona e stanno colpendo anche – e addirittura – i check point.
Il primo ministro ancora in carica, Haider al-Abadi, è arrivato in città, direttamente da Bruxelles, dove aveva preso parte al vertice Nato, nei colloqui bilaterali della cosiddetta “Coalizione contro lo Stato islamico” e si è trovato di fronte la potente tribù dei Tamimi (Bani Tamim) e il loro leader, Muhazim al-Tamimi, pronto a dare un ultimatum al governo: o il governo si darà da fare a impiantare una centrale elettrica e un sistema di desalinizzazione, contemporaneamente adoperandosi per contrastare la disoccupazione e accelerare il trasferimento degli investimenti per le raffinerie sullo stabilimento di Bassora, o il Sud dell’Iraq metterà in ginocchio il paese.
I manifestanti nello stesso giorno avevano bloccato l’aeroporto di Najaf e il palazzo del governatore di Nassiria, mentre il presidente iracheno Fuad Masum si era appellato proprio ai governatori delle province per sedare gli animi.
Cosa che non è accaduta, al punto che l’unità antiterrorismo delle Forze speciali è già arrivata a Bassora, per intervenire alla bisogna e, soprattutto per proteggere i siti delle compagnie petrolifere già in parte saccheggiati lo scorso 11 luglio 2018.
Gli elicotteri hanno già evacuato il personale della Lukoil nel quartiere di Qurna, dove si trova la seconda più grande piattaforma petrolifera del paese e dove le proteste sono più intense. La patata bollente tocca adesso a Jabbar Ali al-Luaibi, ministro del settore petrolifero.
Il ministro uscente ha già preparato un piano in tre fasi, reso noto alla stampa: “Primo: entro due mesi implementare i servizi mancanti: acqua, elettricità, settore sanitario, servizi pubblici e di sicurezza; secondo: un piano di medio periodo fino a sei mesi; terzo: un piano di lungo periodo fino a due anni”.
Intanto, i primi contributi a pioggia saranno pari a due miliardi per creare una rete di acqua potabile finalmente fruibile dalla cittadinanza, per poi aumentare le ore di elettricità dopo avere ripristinato il collegamento con le centrali iraniane.
Più avanti, il governo promette altri 10mila posti di lavoro come risposta alla crisi.
Una risposta che è lontana dall’essere sostenibile, considerato anche che il nuovo, futuro governo (quando ci sarà) sarà inabile a potere attuare programmi di lungo periodo, vuoi per l’estrema debolezza politica prevista, vuoi perché ogni progetto e investimento nel paese sulla popolazione è comunque sottomesso al sistema parlamentare e settario delle quote etniche e geografiche.
In pieno ciclone sociale, l’Iraq è anche e soprattutto in pieno vacuum istituzionale, considerato che è stato ordinato un riconteggio delle schede elettorali a partire dal 3 luglio.
La causa del riconteggio è ascrivibile a ipotetici brogli sui voti del quartiere Rusafa di Baghdad, una circoscrizione da 1 milione e 800mila abitanti. Il conteggio non è ancora concluso, con l’aggravante che 100mila schede sul milione e 800mila già citato sono andate in fumo a causa di un incendio (nessuno ancora sa se sia doloso o meno) scoppiato nel magazzino di Rusafa.
Il conteggio in corso è eseguito manualmente dai giudici della Corte Federale irachena ma l’avere messo una pezza sulle recenti elezioni non placa la percezione dell’opinione pubblica sul fatto che il cittadino iracheno sia vittima delle istituzioni e delle classi al potere.
Questo sentimento, del resto, aveva guidato il voto dello scorso maggio: le ultime politiche sono state, infatti, le meno prevedibili, da quanto l’Iraq è una Repubblica parlamentare islamica indipendente dalla dittatura di Saddam, conclusasi nel 2004 con passaggio a nuova costituzione.
L’alleanza Sairoon, formata dal partito del clerico sciita ex terrorista Moqtada al-Sadr, in coalizione con il partito comunista, ha ottenuto il consenso massimo (35 per cento), seguita dal favorito di queste elezioni (con il 28 per cento): il partito Fatah di Hadi al-Amri, l’ala più intransigente e locale dello sciismo iracheno, forte del sostegno politico ed economico dato prima e poi ottenuto indietro con il voto ai volontari delle PMU, ossia le Unità di mobilitazione popolare, milizie organizzate a livello popolare dal 2014 per contrastare l’espansione dello Stato islamico sull’Iraq.
La particolarità della vittoria di Moqtada è stata l’alleanza con il partito comunista iracheno, intorno al quale si sono coagulate le speranze di molti attivisti laici per le minoranze di genere e religiose, e lo zoccolo duro del sindacato iracheno in difesa, soprattutto, dei lavoratori delle piattaforme petrolifere sparse in tutto il paese.
Ma la coalizione Sairoon – come prevedibile – si è sfaldata sull’altare della real-politik, minata da un clima di tensioni subito dopo il voto e confermata dal sospetto di brogli elettorali mossi dai partiti perdenti sulla circoscrizione elettorale di Baghdad.
Moqtada al-Sadr, da leader pragmatico, ha dunque proposto un’inversione di rotta. Il religioso nazionalista, che si era sempre dimostrato riluttante al coinvolgimento di Teheran nel paese e si era sempre tenuto molto distante, sia dall’ex premier al-Maliki, sia da Hadi al-Amri, leader delle milizie popolari filo-iraniane, ha dovuto agire con furbizia per non perdere la maggioranza appena conquistata.
Così ha inneggiato a “una vera alleanza per accelerare la formazione di un governo nazionale lontano da ogni dogmatismo”.
Lui che, fin dal post-elezioni aveva invitato tutte le forze politiche a rimanere unite per il bene dell’Iraq e rifiutava categoricamente l’idea di ritornare al voto, sostenendo che “l’Iraq è in pericolo” senza stabilità politica, ha aperto la sua prossima maggioranza di governo al partito numero due di queste elezioni: Fatah di Hadi al-Amri.
Segno questo che, nonostante le previsioni degli entusiasti della prima ora su questi risultati elettorali inediti, al-Sadr non può fare un “nuovo” Iraq senza tenere in considerazione il suo primo vicino e investitore: l’Iran.
Teheran, che aveva mostrato preoccupazione nella prima ora, si è potuta dunque rilassare sul compromesso dichiarato da al-Sadr e necessario all’Iran per mantenere il suo controllo sulla regione.
Non lo stesso proposito, però, può dirsi essere stato abbracciato dai comunisti, trascinati in un gioco politico dal quale stanno rischiando di essere schiacciati, se non sul profilo dello sviluppo di un Iraq più “nazionale”, soprattutto sul piano dei diritti dei lavoratori e delle minoranze, un tema che non incontra di certo il benestare né di Fatah né dei sadristi.
Lo scenario attuale la dice lunga, quindi, sul focolaio di tensioni ormai visibile su cui poggia l’apparente tenuta del paese. E conferma uno dei timori del post-elezioni dopo il risultato: il paese, nonostante abbia espresso un voto totalmente avulso dalle precedenti scelte politiche, votando resta prigioniero di logiche di rivendicazione interne di potere, di interessi di potenze regionali vicine e internazionali debitrici, e di un generale clima di sfiducia nei confronti della classe politica che accomuna trasversalmente tutta la cittadinanza irachena, da Nord a Sud.
E che, ormai sdoganato in piazza, rischia, se non più ascoltato, di essere nuovamente oppresso – e con estrema violenza – dai gruppi di potere al governo.