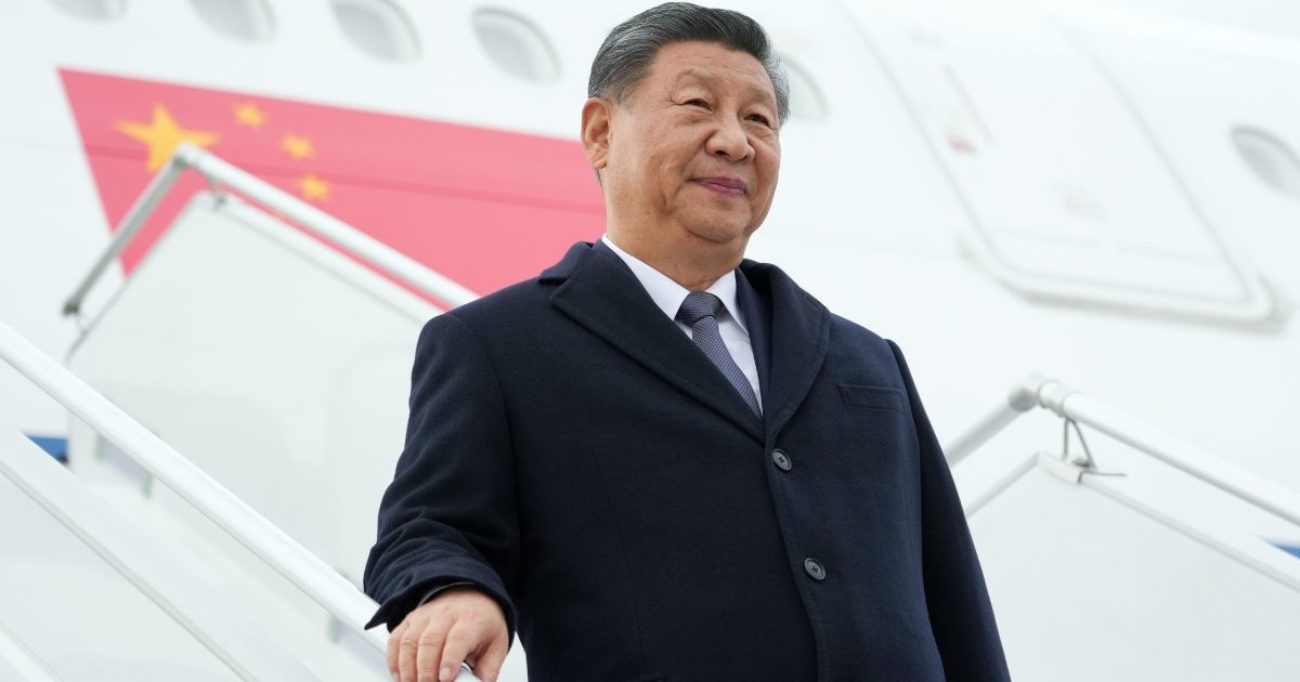L’Iran è un Paese spaccato a metà

Da una parte la Repubblica islamica fondamentalista che bastona. Dall’altra un popolo vessato che sfida gli ayatollah nelle piazze. E che non ha voluto festeggiare l’attacco a Israele. Ecco i due volti dell’Iran
Teheran, primo pomeriggio, ora di punta per chi torna al lavoro dopo un pranzo veloce. Nella metropolitana c’è un fracasso gioioso, come quasi ogni giorno. Al centro di uno dei vagoni un crocchio di donne senza velo si fa spazio tra la calca e accenna come può qualche passo di danza, tutt’attorno chi si è accaparrato un posto a sedere batte le mani sorridendo, tutti (anziani inclusi) cantano.
Qualche fermata. Poi lo squadrone del regime sale a bordo, avvisato da chi le metropolitane le sorveglia in borghese, e inizia a sfoderare i bastoni, a picchiare, a trascinare per i capelli le donne fuori dal vagone. Una, la più giovane, viene seguita: ha 16 anni, si chiama Armita. Dopo poco la fermano, la polizia la picchia a sangue così forte da farle perdere i sensi: Armita finisce in ospedale, in coma. Morirà dopo un mese.
Tutti hanno paura: sanno che oltre agli occhi umani, ci sono quelli elettronici: osservano, identificano, intercettano, seguono e puniscono. Ma sui vagoni di tutte le linee della metropolitana, si canta e si balla ancora.
Qualche settimana più tardi, nel Grand bazaar della capitale (dieci chilometri di corridoi tra negozi, moschee e banche che lo rendono il centro della vita economica non solo della capitale, ma dell’intero Iran), una serie di mercanti affigge un cartello all’ingresso: «Qui verrà servito solo chi entra danzando, con o senza velo, meglio ancora se intona Donna, vita, libertà. Gli altri possono rivolgersi altrove».
Si formano le code, in tanti si avventurano e iniziano a intonare motivetti mentre sono in fila: le autorità della Repubblica islamica irrompono e lanciano lacrimogeni, sgomberano e fanno abbassare le saracinesche ai “dissidenti”. I giorni successivi la storia si ripete: sempre più mercanti, al ritmo di una ola di libertà, replicano lo storytelling.
È un paradosso strano: lo Stato finanziatore delle forze più temute in Medio Oriente (gli Houthi nello Yemen, Hezbollah in Libano, Hamas a Gaza), l’Iran che si pone come “padre nobile” e stratega dello scacchiere internazionale della Repubblica islamica, è in difficoltà a gestire delle persone che ballano, al punto da inasprire una repressione già violenta e costellata di tabù e finto moralismo.
Queste storie della nuova quotidianità persiana palesano la complessità della questione iraniana: un Paese tranciato a metà, dove la base non sostiene più, ormai apertamente da tempo, chi la governa. E lo esplicita mettendo in atto una “rivoluzione gentile”.
Da un lato, c’è l’orgoglio dei mullah che di fronte al mondo devono mantenere la loro leadership fondamentalista, con le forze dell’ordine che tentano di fare ciò che riesce loro meglio, ovvero opprimere e reprimere. Dall’altro, c’è una popolazione che non riconosce al governo alcuna autorevolezza, vessata da leggi che non condivide, da provvedimenti disciplinari che ledono qualsiasi basico diritto umano, affamata da una povertà che il regime utilizza per alimentare il clima del terrore.
Da un lato c’è lo Stato pro-Hamas, che bastona in nome della Repubblica islamica, che vorrebbe in cenere Israele. Dall’altro c’è la popolazione che condanna e sfida (anche solo danzando) il terrorismo armato degli ayatollah, che è solidale con i civili di Gaza, ma che allo stesso tempo non vuole la guerra con Netanyahu: sono troppo vividi il ricordo e le cicatrici del lungo conflitto con l’Iraq ed è troppo forte il desiderio di pace e di libertà.
Voglia di democrazia
L’attacco iraniano del 13 aprile contro Israele è stato un’azione senza precedenti: mai Teheran si era spinta a colpire a viso aperto dentro i confini israeliani. Si è trattato di una risposta all’offensiva contro l’ambasciata iraniana a Damasco, in cui sono stati uccisi diversi alti ufficiali dei pasdaran, tra cui il generale Mohammad Reza Zahedi, l’ufficiale più importante dopo la morte, avvenuta a Baghdad nel 2020, di Qasem Soleimani, colui che aveva guidato le più sanguinose e segrete operazioni iraniane all’estero.
TPI esce in edicola ogni venerdì
Zahedi era il comandante della Forza Quds, nonché responsabile del coordinamento militare in Libano e in Siria: svolgeva un ruolo ponte tra Teheran e gli Hezbollah garantendo le armi iraniane al Partito di Dio.
La mossa di Israele è stata giudicata una provocazione troppo sfacciata: per questo l’Iran ha lanciato la sua offensiva con centinaia di droni e di missili, un’azione dimostrativa, una prova di forza ritenuta “necessaria” dai militari persiani che ne hanno fatto una questione di “onore di fronte al mondo”. Un onore che i cittadini non intendono celebrare: l’alta tensione, dopo oltre un anno e mezzo di guerriglia interna, è palpabile.
«Questa generazione non si riconosce nella Repubblica islamica: vuole la democrazia. Pressoché nessuna persona comune è scesa in piazza a esultare per l’attacco, così come nessuno ha voluto calpestare la bandiera di Israele quando è stata posizionata al centro di una delle strade principali: tutti, tranne gli uomini della polizia morale, ci sono passati accanto, schivandola», racconta concitato a TPI Mehdi, uno studente di Scienze Politiche di casa nella capitale.
«Gli unici a gioire nelle piazze – prosegue – erano i miliziani e i mercenari islamici, alcuni provenienti dall’Afghanistan perché pagati dai mullah. Sono le stesse persone che stanno torturando, violentando e uccidendo i manifestanti. Non è un caso che in contemporanea all’attacco si sia intensificata la guerra del regime contro le donne».
Come annunciato dalle autorità, infatti, dal 13 aprile la polizia morale è stata rafforzata per scovare le donne senza velo: la legge si chiama Nour (luce) e per chi non rispetta il dettame della castità e dell’hijab scattano dieci anni di carcere (il regolamento precedente prevedeva da dieci giorni a due mesi di reclusione). La norma non si limita a punire le donne che non indossano il velo in pubblico – o che, proprio come Mahsa Amini non lo indossano in modo corretto – ma riguarda anche le scuole, dove hijab e castità vanno promossi.
«Grazie all’intelligenza artificiale e alle telecamere sono stati monitorati tutti gli insegnanti: tantissimi sono stati multati, licenziati e sostituiti dagli ayatollah o da donne del regime. Altri, soprattutto docenti universitari, sono stati arrestati, hanno confiscato loro le automobili e sequestrato i passaporti, altri ancora sono accusati di spionaggio e di cospirazione con governi e media stranieri», spiega Farideh, una docente dell’Università di Shiraz rimasta senza cattedra e senza più la vista da un occhio, a causa delle percosse e delle torture subite durante i suoi due mesi di detenzione.
«Il mio avvocato ha impiegato un mese prima di riuscire a parlare con me, dicevano che avevo promosso la rivolta degli studenti e che avevo deriso l’uso dell’hijab. Quando sono uscita dal carcere, hanno arrestato lui: al momento nessuno ha più sue notizie».
Secondo il rapporto stilato dal gruppo per i diritti umani Hengaw, nel 2023 nelle prigioni e nei centri di detenzione iraniani sono morti 32 prigionieri, due sono deceduti «poco dopo il loro rilascio», mentre un imputato «è stato ucciso dal fuoco diretto delle forze del dipartimento di intelligence mentre tentava la fuga». Nove erano prigionieri politici e almeno undici persone sono state uccise mentre erano sotto tortura.
Farideh è una donna energica, di cultura, il coraggio non le è mai mancato, per informarsi guarda la tv satellitare e per non abbandonare a loro stessi i suoi studenti e le sue studentesse registra delle lezioni e dei brevi messaggi video: la chiavetta viene recapitata di persona e passa di mano in mano. «Sono preoccupata», dice: «La gente lotta per la sopravvivenza e soprattutto le ragazze sono determinate a proseguire questa rivolta nata e cresciuta dal basso, senza leader. Io sono al loro fianco, ma sono anche angosciata: ecco perché, in parte, nel profondo, ad essere onesta un po’ in Israele confido».
La professoressa confessa quello che parecchi pensano, ma che esplicitano a denti stretti. Un terzo fronte di pensiero. «La Repubblica islamica – osserva – non può cavarsela con l’impunità per tutti i crimini che ha commesso. Non siamo per la guerra a Israele, ma non siamo neanche per la guerra a Gaza, dove la pena dei civili viene usata dagli ayatollah mettendo tutti ancora più in pericolo. Qui nessuno vuole vendetta, quel che si vuole è la pace e la libertà. Si chiedono giustizia sociale e stato di diritto, che significa avere tribunali indipendenti e una legge uguale per tutti, con la tutela delle minoranze».
«Un anno e mezzo di proteste -continua Farideh – ha portato a oltre cinquecento esecuzioni, a migliaia di arresti, a tanto dolore. All’inizio c’è stato il clamore internazionale, poi siamo rimasti soli a lottare per noi stessi senza supporto. Per questo l’idea che Israele possa colpire in modo mirato i pasdaran e il centro di potere del presidente Ebraim Rahisi potrebbe paradossalmente rappresentare l’unico spiraglio per cacciarlo e per toccare con mano due valori tanto semplici quanto alti: la pace esterna e la libertà interna. Perché quella che in particolare noi donne stiamo combattendo qui dall’interno, subendo conseguenze irreversibili, è già una guerra: una guerra di civiltà. Eppure riceviamo solo violenza da parte della Repubblica islamica. Per arrivare alla verità e alla riconciliazione c’è bisogno di giustizia».
Una rivoluzione gentile
La costanza delle proteste – che negli ultimi mesi sono diventate diffuse e sparse, senza più l’epicentro della piazza – ha reso ancora più evidente la crisi di legittimità della Repubblica islamica, ma nei fatti non ha rappresentato finora una minaccia esistenziale per il sistema, che non appare sul punto di cedere né di cadere.
Tuttavia, la trasformazione sociale prodotta dal movimento pro-democrazia è irreversibile. La vicenda di Sadegh Booghi è emblematica. La storia è questa: a Rasht, la più grande città iraniana vicina al mar Caspio, il tassista registra un video in cui danza nel bel mezzo del mercato del pesce intonando «Ow, ow, ow».
Il filmato diventa virale e ben presto in molti registrano altri video in cui ripetono lo stacchetto: fra questi, anche parecchie donne senza hijab. Sadegh diventa un caso politico: il suo filmato viene bollato come anti-islamico e rivoltoso, l’espressione «Ow, ow, ow» viene messa all’indice. Lui e tutti coloro che lo hanno imitato vengono identificati e arrestati.
Dopo una serie di nuove proteste e dibattiti pubblici, il motivetto viene “scagionato”, il tassista viene rilasciato, le donne no. E i video di giovani senza hijab si sono moltiplicati, in sfregio all’ennesima vessazione: «Combattiamo il nostro oppressore con metodi pacifici», ripetono.
Il gap tra società civile e Stato repressivo è diventato incolmabile: circa l’80 per cento degli aventi diritto al voto, durante le elezioni presidenziali del primo marzo, ha boicottato i seggi per delegittimare la Repubblica. Nel 2009 l’Onda verde, il grande movimento di protesta, era scesa in piazza al grido di «Che fine ha fatto il mio voto?», oggi nessuno crede più nella capacità dei mullah di attuare delle riforme o dei passi concreti verso il progresso, la civiltà e i diritti invocati dalla popolazione.
Al contrario, innescano un climax di tabù, nel nome della religione. E le piazze continuano a scaldarsi, a portare avanti la causa sopruso dopo sopruso, come una sorta di staffetta per diritti imprescindibili che vanno ancora conquistati.
Il sistema non cede, la società neppure e l’intervallo di tempo tra un’ondata di proteste e un’altra, tra una repressione più violenta della precedente e un’altra, si riduce sempre di più. Questo è lo stallo e insieme l’enorme cortocircuito: una rivoluzione senza rivoluzione. Una rivoluzione gentile.