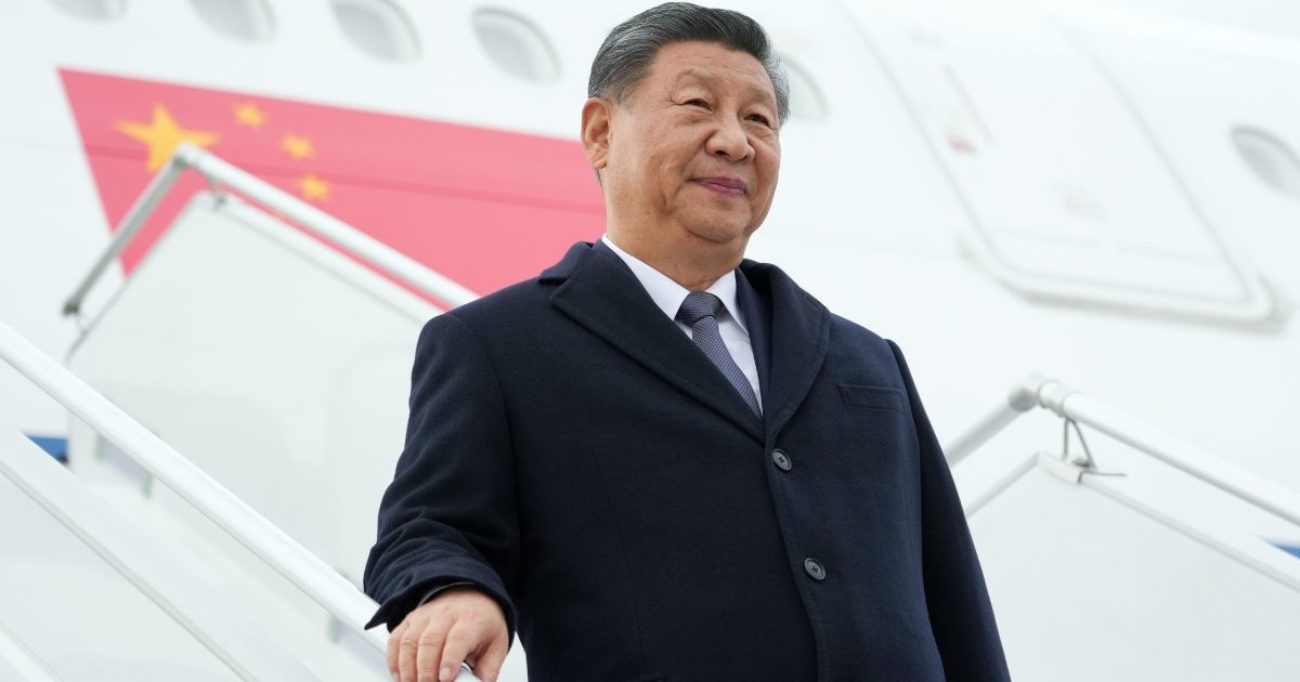La rivoluzione del velo: ecco la doppia vita delle donne in Iran sotto l’hijab

Per le donne esistono due Iran diversi. Uno pubblico, con l’obbligo del chador. E uno privato, fatto persino di minigonne. Ora la morte di Mahsa Amini cambia tutto. Come nel ’79 le manifestanti tornano in piazza per rivendicare i propri diritti. Ma stavolta il regime non riesce a domare la rivolta dei giovani
«So che può sembrare assurdo agli occhi di chi ci guarda dall’esterno, ma in Iran c’è sempre stato uno dei movimenti femministi più forti, coraggiosi e radicati del mondo». La voce – fiera e stentorea – è di Taraneh, docente di storia, classe 1958, che risponde a TPI dalla città ribattezzata «la metà del mondo», quella Isfahan che si è fatta spazio nel mezzo del Paese, culla di una visione umanistica e rinascimentale che si rilegge nelle sue architetture. Quando si consumò la rivoluzione della cacciata dello scià, nel 1979, Taraneh (che per motivi di sicurezza ha chiesto di mantenere il cognome anonimo) aveva 21 anni, era abituata a sentire il vento tra i capelli, raggiungeva le amiche in minigonna e tacchi alti, sfoggiava rossetti e smalti. Ma no, «a differenza di ciò che si pensa, con lo scià non c’era la democrazia ma la dittatura: il punto è che si trattava di una dittatura politica e non religiosa basata su un pensiero unico e su un partito unico, con una occidentalizzazione imposta in fretta e furia e accelerata dall’asse con l’America», ci spiega.
«Se non si ricorda questo, si riscrive la storia e non si comprendono le ragioni di quella rivoluzione durante la quale poi, certo, il popolo è stato ingannato. La nostra voce allora, insieme a quella di molti uomini, si è alzata per la conquista di diritti che ritenevamo e riteniamo più importanti delle limitazioni sul vestiario: la libertà di espressione», prosegue nel corso di un racconto che riallaccia storia e attualità, svelando le due anime di un Iran stravolto e a tratti contraddittorio: quello dell’apparenza e quello del quotidiano, che tuttora si vive fra le mura domestiche. Dove i diktat degli ayatollah, salvo rare eccezioni, non esistono.
Stavolta la crepa che ha rotto le dighe di una rivolta dirompente è stata la morte di Mahsa Amini, la 22enne uccisa dalla polizia perché non abbastanza coperta, ma questo braccio di ferro serrato tra governo e popolo – seppur in modo meno clamoroso – è in corso da oltre un anno e mezzo e ha radici molto più solide e profonde. «La battaglia delle donne nel nostro Paese è sempre stata per la libertà, per questo la si descrive come una rivolta più sociale che politica: sta qui il grande fraintendimento e anche la grande differenza tra noi e gli altri popoli sottomessi», aggiunge la studiosa. «L’hijab è un simbolo forte, lo è soprattutto per il regime, ma sono tante le lotte che, nei decenni, dopo l’avvento del governo religioso, sono state ritenute più importanti rispetto a quella del velo», come il diritto al divorzio o l’uguaglianza tra uomo e donna per ricevere l’eredità o in materia di testimonianze in tribunale.
Le proteste dopo la morte di Amini hanno conclamato la centralità dell’hijab obbligatorio come simbolo di repressione ma soprattutto come emblema dell’impunità del regime. Lo slogan “donna, vita, libertà” o “ucciderò chi ha ucciso mia sorella” intersecano il reclamo dei diritti delle donne con quello per i diritti e per la libertà della nazione in generale. Questo perché il caso di Mahsa, curda-iraniana, è stato la miccia d’innesco di proteste trasversali che hanno unito persone di origini etniche, linguistiche e di classi differenti. Mentre le donne lavoravano su questioni sociali sostanziali, capaci di influenzare sia le loro vite sia il Paese (come le concessioni estere o l’istruzione e la partecipazione alla vita politica e al mondo del lavoro), i governanti e i governi a dominanza maschile trattavano i loro corpi come teatri di politica identitaria. «Reza Shah Pahlavi, soprannominato il modernizzatore, ha vietato il velo nel 1936, costringendo molte a non lasciare mai le loro case. Questo finché il divieto non è stato sciolto, con la sua detronizzazione, nel 1941», ricorda Taraneh. Con la crescita del fervore rivoluzionario, negli anni Settanta le donne giocarono un ruolo di prim’ordine in tutti i gruppi politici – da quello comunista a quello nazionalista, passando per le formazioni più islamiste – e contribuirono notevolmente alla caduta della dinastia Pahlavi. Tutti furono traditi dal canto delle sirene rappresentato dal leader rivoluzionario, l’ayatollah Khomeini, che sì sottolineò l’importanza del genere femminile, ma che «aveva una comprensione tradizionale del suo ruolo nella società, vedeva noi donne come complementari anziché come pari».
Meno di un mese dopo il colpo di Stato, Khomeini pronunciò il famoso discorso di Qom, declamando che le dipendenti statali avrebbero dovuto indossare il velo, perché «il peccato non può essere commesso nei ministeri islamici». Neppure allora, come oggi, tutto è passato sotto silenzio. «Io c’ero quel giorno, l’ultimo per le strade senza velo obbligatorio in testa», confessa Golnar, collega di Taraneh ma di casa a Tabriz, la più grande città dell’Iran nord occidentale. «Decine di migliaia di donne hanno marciato per sei giorni dall’8 marzo del ’79, reclamando sempre la stessa cosa: libertà. Per le strade c’era chi, come me, aveva i capelli in vista ma anche chi indossava il foulard, proprio come nelle proteste di oggi. Eravamo le stesse donne che avevano fatto la rivoluzione, che erano insorte sfidando i carri armati dello scià. Ma mentre noi siamo state disposte a morire per la libertà di tutti, mettendo a repentaglio la nostra, a quel punto la fiamma della protesta generale si era affievolita e gli altri sono rimasti spettatori».
I nuovi leader rivoluzionari e i media di Stato hanno quasi ignorato quelle piazze e lo stesso hanno fatto molte fazioni di sinistra e laiche che, fino a poche settimane prima, avevano contribuito a rovesciare uno dei regimi più potenti del mondo. La rassegnazione di Golnar si rilegge in un tono di voce che si assottiglia: «Da lì in avanti è stata un’escalation». Le musiciste non hanno trovato sostenitori in pubblico quando è stato detto loro che le voci soliste non sarebbero state più consentite.
E allora il messaggio rivolto alle donne risuonò cristallino: «Indipendentemente dal nostro contributo nel 1979, per noi non era il momento di avanzare alcuna richiesta, perché i nostri diritti erano secondari rispetto alla vittoria di questa rivoluzione antimperialista. Rispondemmo che il cuore della questione non erano né la libertà orientale né la libertà occidentale, bensì la libertà universale ma non servì. La dittatura era stata ormai sostituita da una teocrazia reazionaria». Un doppio tradimento per le femministe che hanno messo sul piatto la loro libertà lottando per quella altrui e che poi, consumata la rivoluzione, si sono viste sottrarre diritti «che non parevano essere in discussione. A quel punto, quando la separazione dei poteri non c’era più e il governo era quello religioso, anche noi donne eravamo divise: molte credenti hanno avuto un ruolo di primo piano al fianco degli ayatollah».
Nel 1983 l’hijab venne poi imposto sin dall’età dell’adolescenza, entrò in servizio la polizia morale che pattugliava e pattuglia le strade e che ben presto fu soprannominata in gergo “Fati commando” in modo dispregiativo, una crasi semantica tra Fatima (la figlia del profeta Maometto, ndr) e il concetto di vigilante armato. Il resto è storia conosciuta e porta ai giorni nostri. Quel che è invece meno noto è l’Iran autentico, dentro le case e nel mosaico di piccoli grandi segnali che la stessa Repubblica islamica non ha mai avuto interesse a pubblicizzare: farlo, avrebbe significato palesare le crepe del regime, una finestra sul mondo che gli ayatollah cercano di chiudere in ogni modo.
La rassegnazione, è vero, ha regnato per decenni. Ma la rivoluzione delle donne, seppur in modo più sommesso, è proseguita. A partire dal vestiario. In Iran il nero o il blu scuro – simboli cromatici del fanatismo velato – non sono mai diventati un codice di abbigliamento. Per le strade, accanto alle credenti che per loro scelta indossavano e indossano il chador, hanno sempre sfilato rusarì (foulard) colorati, dai quali spuntava la frangia e che spesso incorniciavano occhi imbellettati dal mascara e guance accentuate da una passata di trucco. Il mondo fondamentalista e i dettami della Repubblica islamica apparente si sgretolano non appena varcata la porta di casa, dove le feste (sì, in minigonna e con abiti scintillanti) continuano a svolgersi nei saloni dei ricevimenti, dove in pressoché tutti i cortili interni o sui balconi spunta l’antenna parabolica per scavalcare la disinformazione di Stato, dove le nuove generazioni non sono impigliate nel fondamentalismo degli ayatollah. E dove a “comandare” sono le donne.
Non è poca cosa. Così, proseguendo una resistenza coriacea che non metteva troppo in imbarazzo l’architettura dell’apparenza, negli anni 2000 le donne hanno conquistato la legge sul divorzio, si sono riprese il diritto di ricevere la propria eredità, hanno ottenuto dei seggi in Parlamento (il majlis) e rappresentano oltre la metà degli studenti universitari. Lo Stato ha drizzato le antenne con le proteste del Movimento Verde, gridando all’invasione culturale. Si sono moltiplicati i controlli sia negli spazi pubblici sia in quelli virtuali, ma ormai era troppo tardi. È nata per questo la “polizia di Internet” iraniana che – in particolare con l’attuale presidente Ebrahim Raisi – ha iniziato a setacciare i siti, limitando e ingabbiando gradualmente la scena musicale e culturale underground iraniana. «Finora, senza sfidare gli ayatollah sull’obbligo dell’hijab, siamo riusciti a fare molto, a cominciare dalla salvaguardia culturale delle giovani generazioni. È grazie a questo lavoro sotterraneo, condotto nei decenni, che si arriva, oggi, alle piazze», sottolinea Golnar.
TPI esce in edicola ogni venerdì
Tanto quei rusarì multicolori quanto le attività sui social hanno insomma normalizzato la vita al di fuori delle rigide imposizioni statali, creando di fatto un “non-movimento” che ora è difficilissimo, per gli ayatollah, da combattere perché oggi si è compreso ciò che non fu chiaro dopo la cacciata dello scià: la libertà di tutti rimane sfuggente se viene preclusa quella di un solo gruppo, in questo caso le donne. Eccola la ricongiunzione generazionale e culturale delle due rivoluzioni, quella delle madri, in piazza nel ’79, e quella delle figlie e dei figli, in strada oggi. Come cantano i manifestanti: “Donna, vita, libertà”.