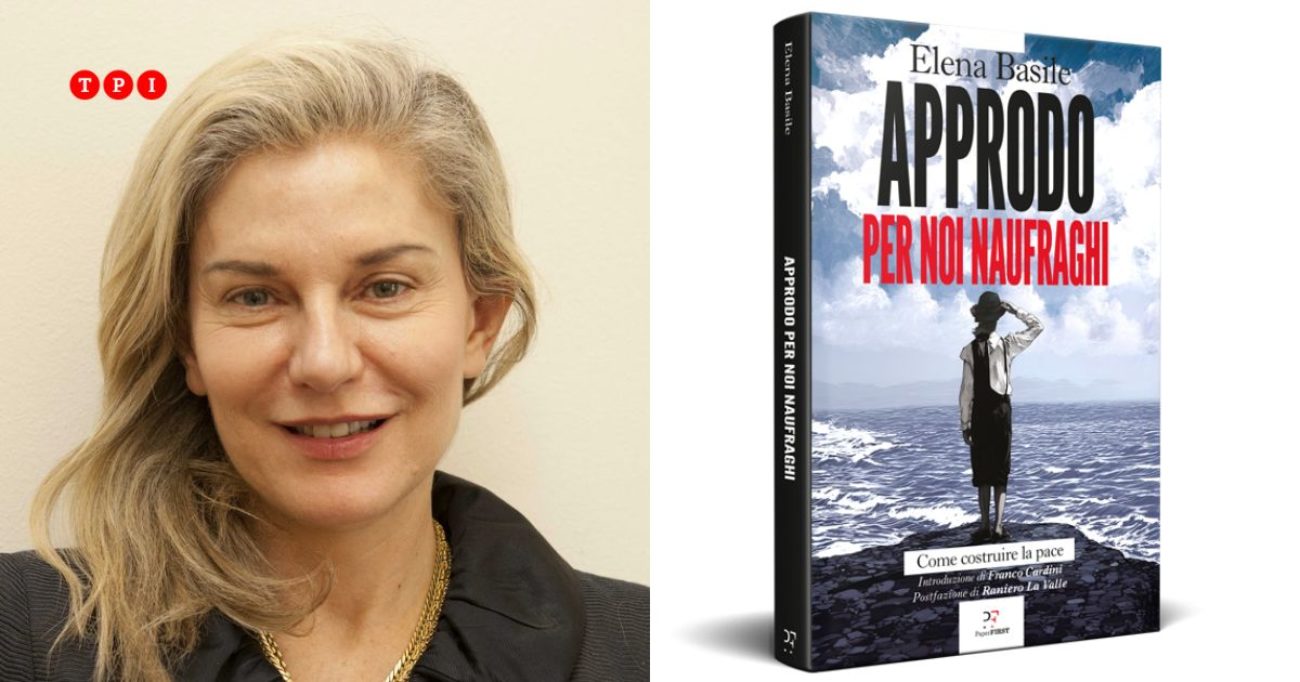I Falasha, ebrei d’Etiopia

Secondo alcuni sono una delle tribù perdute di Israele, ma negli ultimi decenni sono tornati nella Terra Promessa. Una vicenda con alcuni lati oscuri
I Falasha ebrei d’Etiopia
Gondar, nord dell’Etiopia. In un’improvvisata sinagoga un gruppo di ragazzi legge con trepidazione un foglio. Lì è scritto il loro destino. Sono i Beta Israel, o Falasha, ovvero gli ebrei d’Etiopia. Su quel foglio ci sono le sono date e i programmi di un’attesa emigrazione.
Si ritiene che i Falasha siano una delle antiche tribù perdute d’Israele. Oggi ormai hanno progressivamente abbandonato l’Africa. In Etiopia, dove oltre il 60 per cento della popolazione è composto da cristiani, e il 34 per cento circa da musulmani, questi ragazzi sono tra le poche migliaia rimaste. La loro comunità ha sofferto e soffre ancora oggi discriminazioni, le persecuzioni dei secoli scorsi spinsero molti a convertirsi al cristianesimo.
Secondo il Professor Kaplan, docente di religione e studi sull’Africa presso la Hebrew University di Gerusalemme, “essi vivono un atipico status di rifugiati nel proprio Paese, come in un limbo. Il loro unico desiderio è andare via e riunificarsi con le rispettive famiglie”, emigrate negli anni passati.
Dagli anni Ottanta, con una serie di spregiudicate e spettacolari operazioni, il governo israeliano decise di trasferire in massa questa comunità. Per ragioni umanitarie e di opportunità. Un massiccio ingresso di nuovi cittadini israeliani avrebbe contribuito a contrastare la crescita demografica araba, oltre che a porre in salvo questa fetta di popolazione da persecuzioni e carestie in Etiopia e in Sudan.
Nel 1985 prima, e nel 1991 poi, le operazioni Mosè, Giosuè e Salomone traferirono decine di migliaia di Falasha nello Stato ebraico. In assoluta segretezza furono organizzati dei ponti aerei: nel 1991 in 36 ore 34 aerei dell’aviazione militare israeliana imbarcarono 15 mila persone. I sedili furono rimossi per guadagnare spazio e un contrassegno venne appiccicato sulla fronte di ogni individuo. Viaggiarono con pochi oggetti personali, senza bagaglio.
I Falasha lasciarono così una nazione che era stata la loro casa per 2 mila anni, per una terra conosciuta solo attraverso lo studio delle sacre scritture. Oggi in 130 mila vivono in Israele. A Gondar e Addis Abeba ne sono rimasti poco più di 4 mila. E oggi gli ultimi rimasti di una comunità che affonda le sue radici nei tempi biblici stanno per raggiungere la Terra Santa. È l’ultima chiamata per Tel Aviv.
Nel campo per rifugiati di Gondar c’è chi aspetta da oltre 10 anni. Lo scorso luglio il governo israeliano ha deciso dare il via all’operazione ‘Dove’s Wing’ e completare un’ondata migratoria durata 30 anni, e che dovrebbe concludersi entro marzo del prossimo anno. “Questo è l’inizio della fine” ha dichiarato Yehuda Sharf, a capo del dipartimento immigrazione della Jewish Agency, lo scorso ottobre, quando 237 etiopi sono sbarcati a Tel Aviv e hanno riabbracciato le rispettive famiglie.
Il dibattito antropologico sulla reale appartenenza dei Falasha alla comunità ebraica è ancora oggi acceso. Nonostante le pronunce favorevoli di due autorevoli rabbini, Ovadia Yosef e Shlomo Amar, la corrente ultra-ortodossa rifiuta questo riconoscimento. Nel 2003 il governo israeliano decise di concedere la cittadinanza anche ai cristiani convertiti che potessero provare una discendenza ebraica da parte di madre. Cosi, dopo lunghi iter burocratici e con il supporto della Jewish Agency for Israel, oggi una clausola speciale della Law of Entry agevola la loro emigrazione e gli consente di diventare cittadini israeliani. A condizione che una volta giunti in Israele abbraccino la religione ebraica.
I nuovi immigrati vengono accolti nell’Ibim Absorption Center, nei pressi di Sderot. Ma, una volta arrivati, la speranza di una vita migliore per molti si rivela una delusione. L’impatto con la moderna e tecnologizzata Israele, per chi proviene da una società tribale e basata sull’agricoltura, ha causato non pochi problemi di integrazione. Un contesto sociale profondamente diverso da quello di origine. Oltre il 90 per cento degli etiopi è arrivato in Israele da analfabeta, e privo delle competenze necessarie per svolgere un lavoro. L’emarginazione è stata una naturale conseguenza.
Famiglie abituate a vivere in grandi ed estesi gruppi sono state dislocate in varie città e divise tra di loro. Non solo, i lavoratori etiopi sono i meno pagati del Paese, e il tasso di criminalità tra i giovani è tre volte superiore alla media israeliana. Tra i più anziani, che nella società tribale godevano di autorità e rispetto, sono stati numerosi i casi di suicidio.
Oggi un ruolo decisivo nell’integrazione è svolto dall’arruolamento nell’esercito e dalle scuole. I più giovani vengono inseriti in programmi educativi e religiosi specifici. Tuttavia, il processo di omologazione e inserimento, che inizia nei campi di transito in Etiopia e prosegue in quelli di accoglienza, è oggetto di critiche, in quanto tenderebbe a snaturare l’identità di un’intera comunità. E presenta dei lati oscuri. Un’inchiesta della giornalista Gal Gabay ha denunciato la somministrazione controllata alle donne etiopi del Depo Provera, un farmaco anticoncezionale. Sotto accusa sono il Joint Distribution Committee e il Ministero della Salute israeliano.
Esponenti femminili della comunità etiope hanno comunque raggiunto posizioni di vertice nell’estabilishment di Tel Aviv. Belaynesh Zevadia è stata nominata, lo scorso anno, ambasciatrice per Israele ad Addis Abeba. E, dopo le elezioni di martedi scorso per la prima volta una donna etiope, Pnina Tamano-Shata, del partito Yesh Atid, farà parte del Knesset.
Il processo di integrazione è lungo e difficile. Ma il sogno della Terra promessa per gli ultimi ebrei d’Etiopia continua.