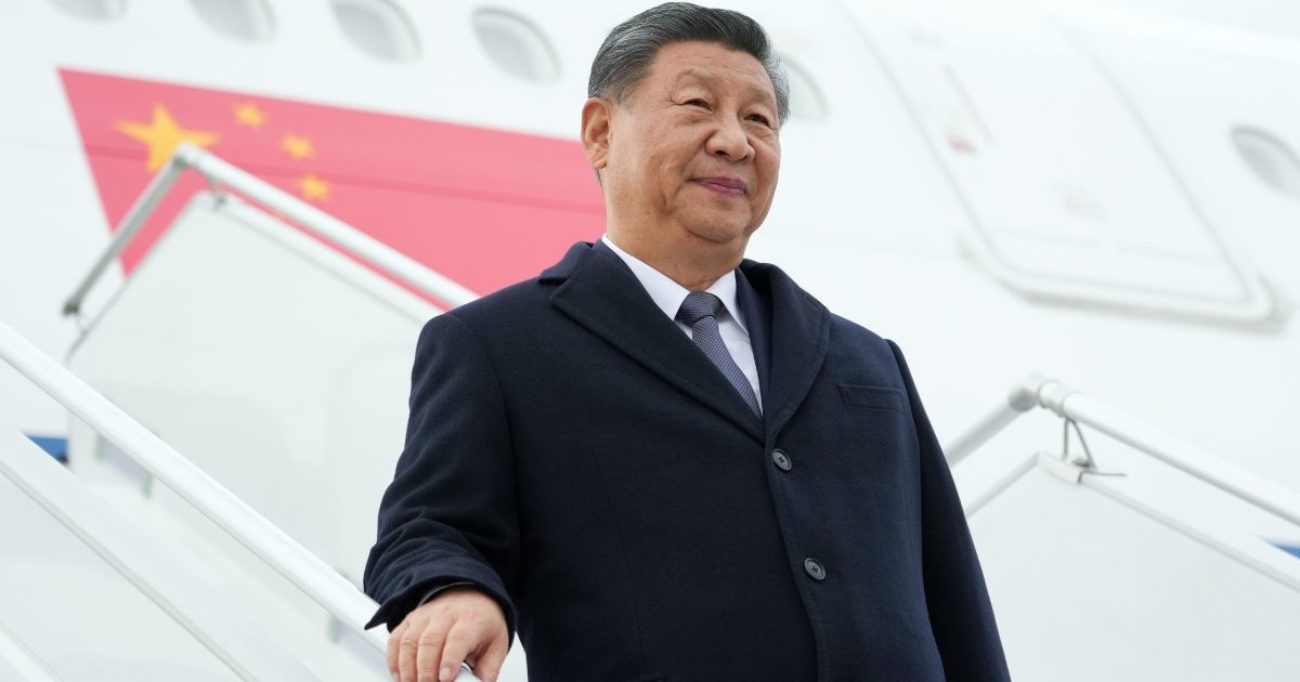“Hamas sparava contro la nostra casa mentre noi eravamo dentro. I miei suoceri sono dispersi”: il racconto a TPI di un israeliano sopravvissuto al raid

"Io, mia moglie e la nostra bimba di un anno siamo stati 12 ore nel bunker di casa. È stato terribile. Quando siamo usciti fuori, c’era l’inferno. Noi siamo sopravvissuti. Ma i miei suoceri sono dispersi”
C’è chi sostiene che la storia è destinata a ripetersi, sempre o quasi sempre. Che la natura dell’uomo è fondamentalmente incline allo sbaglio e che chi non impara dai propri sbagli è condannato a trarne le conseguenza per molto e molto tempo.
Che Israele fosse in pericolo di subire un assalto improvviso e inaspettato era chiaro a tutti (evidentemente, tranne che al governo di Netanyahu). Gli esperti in materia di sicurezza locale avevano avvisato, i giornalisti avevano scritto, eppure nessuno aveva ascoltato. Così, con una puntualità davvero impressionante, la storia si è ripetuta in Medio Oriente.
A cinquant’anni (e due giorni) esatti dallo scoppio della Guerra dello Yom Kippur, la più tragica della storia del Paese, dove Israele fu sorpresa dal nemico e colta impreparata durante un attacco violento e congiunto su diversi fronti, ecco che lo Stato Ebraico compie lo stesso errore e si fa trovare di sprovvisto mentre l’organizzazione criminale terroristica Hamas invade brutalmente il suo territorio.
Avviene il sabato del 7 ottobre, alle 6.30 del mattino. Decine (secondo altre fonti centinaia) di terroristi palestinesi sfondano i recinti che dividono i due territori, armati fino ai denti, e compiono una vera e propria strage: oltre 700 morti, 2.000 feriti, 100 vittime tenute in ostaggio a Gaza e altri centinaia di dispersi.
Avidor Shwartzman, un cittadino israeliano salvatosi per miracolo insieme alla moglie e alla figlia dalle grinfie di Hamas, ha ripercorso in esclusiva per TPI i momenti di orrore vissuti sotto il fuoco nemico.
«Io e mia moglie ci siamo trasferiti da Beer Sheva a Kibbutz Kfar Aza, proprio al confine con Gaza, appena due mesi fa. Volevamo crescere nostra figlia Saar, che ha da poco compiuto un anno, in un ambiente più piccolo e comunitario. I miei suoceri, poi, abitano lì da sempre e ci faceva piacere stare vicino a loro», mi spiega Avidor. E precisa immediatamente: «Sapevamo che vivere vicino a Gaza poteva essere pericoloso, ma pensavamo che la minaccia principale fossero i missili lanciati periodicamente da Hamas e intercettati quasi sempre dall’Iron Dome».
La famiglia Shwartzman non poteva immaginare che la nuova vita a Kfar Aza, presto si sarebbe trasformata in un incubo. «Quando sabato mattina ha suonato la sirena, ci siamo nascosti immediatamente nella camera blindata all’interno della casa. Era evidente che l’attacco fosse ben diverso dai precedenti. Gli scoppi erano più vicini, più potenti, più frequenti. La sirena ha suonato per più di un’ora e poco dopo ci sono arrivati dei messaggi su WhatsApp che comunicavano l’infiltrazione di un gruppo di terroristi nel Kibbutz. Era vero. Alle 7.30 del mattino abbiamo cominciato a sentire i primi spari. Colpi secchi di arma da fuoco sulla parete esterna di casa nostra. Ad ogni sparo, sentivamo il muro sbriciolarsi e diventar polvere».
Avidor fa una breve pausa. «Era terribile, un incubo. Tutti gli spari erano accompagnati da urla e imprecazioni in lingua araba. Sembrava di essere in un film, non poteva essere vero. Io mi sono sdraiato sopra mia moglie, per proteggerla, mentre lei stringeva stretta stretta nostra figlia».
Come concepisce un neonato la guerra? Il neo papà, spiega: «Saar è la vera eroina di questa storia. Ha come capito che fossimo in stato di emergenza e per lunghe e lunghe ore non ha fiatato, non ha pianto, non ha fatto capricci. È stata esemplare».
E un papà e una mamma terrorizzati all’idea di morire, di cosa parlano nei momenti di sconforto? Il sopravvissuto risponde immediatamente, con decisione: «Certo non della morte. Eravamo troppo impegnati a restare in vita per ipotizzare la nostra morte».
TPI esce in edicola ogni venerdì
Le scorte? I bisogni fisici? Avidor incalza: «Io e mia moglie non abbiamo mangiato nulla tutto il giorno. Non avevamo preparato le scorte per noi. Saar invece aveva tutto ciò di cui aveva bisogno. Per quanto riguarda i bisogni, abbiamo utilizzato delle vecchie pentole ormai in disuso che avevamo dimenticato lì».
Shwartzman ripercorre minuto per minuto, ora per ora, la prigionia forzata in casa sua. «Il momento più buio, più tragico, in cui abbiamo realizzato la drammaticità di ciò che ci stava succedendo, è stato quando abbiamo letto della morte del capo del Kibbutz, Ofir Livshtein, che era uscito a combattere con un’altra manciata di volontari i terroristi di Hamas. Come Davide e Golia. Un gruppo di volontari scarsamente armati contro un gruppo criminale ricoperto di armi. A differenza di Davide, loro non ce l’hanno fatta. Livshtein si è sacrificato per difendere il suo Kibbutz», ricorda.
Dopo dodici ore estenuanti di combattimenti feroci, a mezzanotte, i soldati israeliani riescono a prevalere sui terroristi palestinesi ed evacuare la zona. «Inizialmente credevamo fosse Hamas che cercava di penetrare in casa. Credevamo fosse giunta la nostra ora. Quando abbiamo visto che erano i nostri soldati, siamo corsi ad abbracciarli. Non ricordo di aver mai abbracciato così qualcuno in tutta la mia vita», rievoca Avidor, cantando così vittoria decisamente troppo presto.
«L’immagine che si è presentata davanti ai nostri occhi una volta usciti all’aria aperta, era apocalittica. A tratti surrealistica. Le nostre macchine erano completamente distrutte. Gli alberi bruciati. Le case in rovina. Il nostro piccolo paradiso, era diventato un inferno».
I soldati decidono dunque di radunare tutti i sopravvissuti del Kibbutz per spostarli in un luogo sicuro. Decisione, che si rivela presto essere sbagliata. «D’un tratto sentiamo delle altre urla in arabo e degli altri spari. Era Hamas. I nostri soldati ci hanno circondati e fatto da scudo umano. Poi ci hanno rispostato all’interno di un’abitazione e liberati definitivamente quando i terroristi erano ormai neutralizzati. Ci hanno dato da mangiare e da bere, ci hanno fatti salire su un pullman e portati in direzione nord. Era ormai l’alba, non avevamo dormito tutta la notte, eppure non riuscivamo a chiudere occhio. Ora ci troviamo a casa di un amico di famiglia, al sicuro a Herzliya, nel centro del Paese».
La storia della famiglia Shwartzman potrebbe essere una storia a lieto fine, se non fosse per un tragico dettaglio. «Già alle 17.00 i miei suoceri avevano smesso di rispondere ai nostri messaggi. Avevamo intuito che ci fosse qualcosa di strano, ma avevamo deciso di essere ottimisti. Oggi, tre giorni dopo, ancora non siamo riusciti a trovarli», spiega Avidor con un filo di voce.
«Potrebbero essere ancora vivi, nascosti e terrorizzati. Escludo che siano morti, perché i loro corpi non si trovano da nessuna parte. La terza ipotesi, la peggiore, non voglio nemmeno prenderla in considerazione». Una pausa. «Possibile che siamo ostaggi di Hamas, a Gaza?», domando io. «Sì, ma quella parola io e mia moglie non la pronunciamo nemmeno, non vogliamo pensarci. O crederci», risponde lui.
L’incubo vissuto dalla famiglia Shwartzman e il mistero che ancora aleggia sulla mancata o presunta sopravvivenza di Yigal e Sidney Flash, i suoceri di Avidor, rappresentano tragicamente il dramma vissuto dai cittadini israeliani nell’ultima settimana: il terrore, la paura, il dolore, la morte, la scomparsa, l’incertezza. Un prezzo troppo caro da pagare, persino per questo pezzo di terra conteso da tutti.