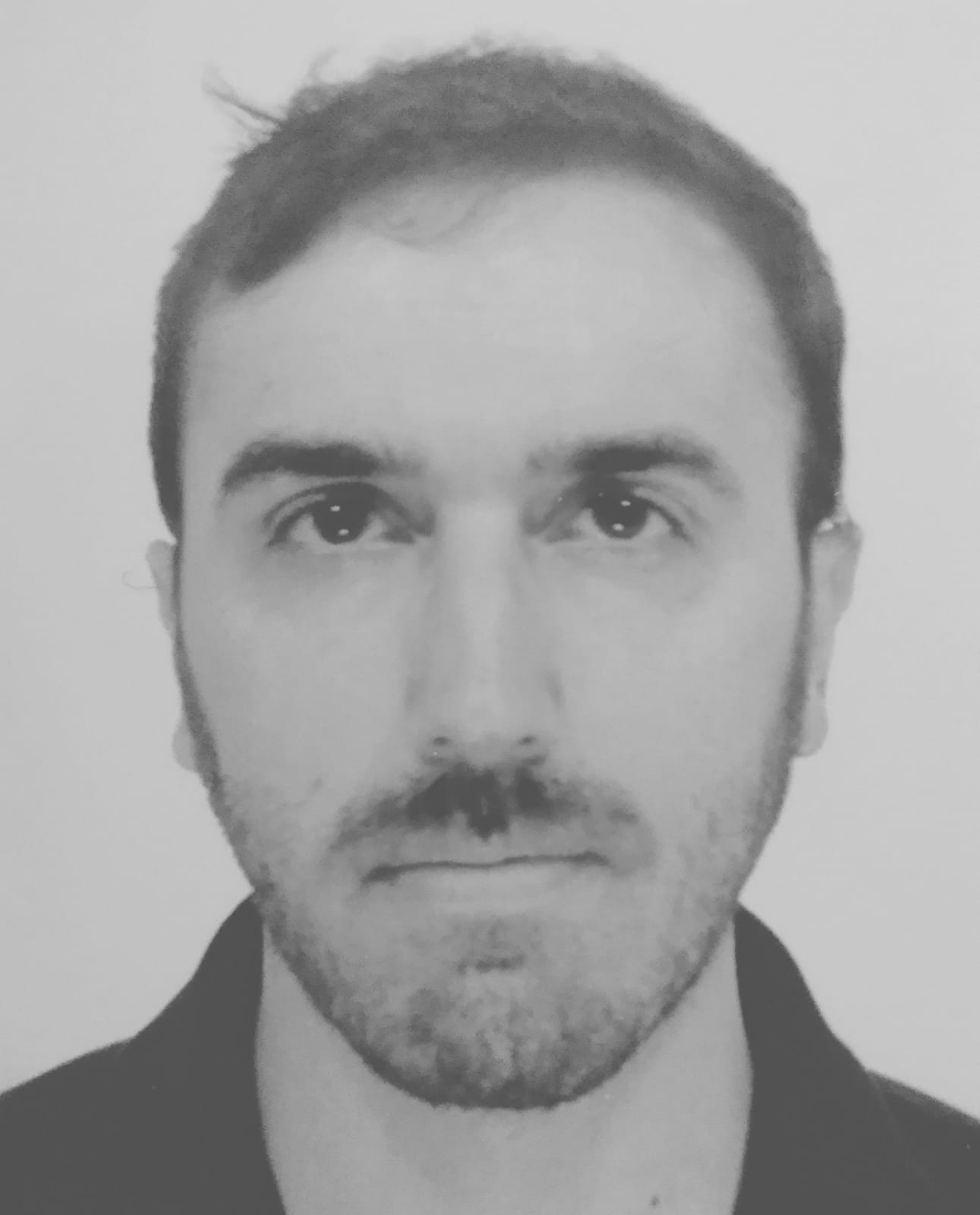“Fateci vivere”: le proteste dei francesi per la riforma delle pensioni di Macron sono una rivolta contro questo modello socio-economico

La rivolta dei francesi contro Macron non è solo una battaglia per la pensione. Ma anche un atto di ribellione verso un modello economico-sociale che non rende felici le persone. E verso una politica sorda e lontana
«La verità è che non hanno capito perché siamo qui. Noi non difendiamo soltanto il diritto di godere di una pausa nella nostra esistenza. Noi soprattutto affermiamo che il tempo della vita non è unicamente il tempo del lavoro, quello considerato “utile” perché dedicato a produrre, ma anche il tempo libero. Il tempo libero non è un momento di inattività, ma un tempo di cui noi possiamo disporre. Vivere, amare, anche non fare nulla, prenderci cura dei nostri cari, leggere poesie, dipingere, cantare, oziare. Il tempo libero è il momento in cui abbiamo la possibilità di essere totalmente umani. Ecco di cosa parliamo».
Jean-Luc Mélenchon, il “líder máximo” della sinistra francese, usa queste parole per arringare la folla che da settimane protesta in strada in tutto il Paese contro la riforma delle pensioni voluta dal presidente della Repubblica, il contestatissimo Emmanuel Macron. Ed è un discorso che fa subito breccia nei manifestanti. Mélenchon parla di «tempo libero», di amore, poesia, ozio: argomenti insoliti per un comizio politico, ma poderosamente efficaci.
I francesi non si stanno mobilitando solo contro l’innalzamento dell’età di pensionamento da 62 a 64 anni: più in generale, la loro è una ribellione contro un’organizzazione della società che percepiscono sempre più insoddisfacente.
Lo dimostrano i tanti giovani che marciano col pugno chiuso alzato al fianco dei loro genitori e nonni. E basta leggere i cartelli e gli striscioni esibiti dai dimostranti, per capire il senso più profondo di questa mobilitazione: «Vampiri, ridateci la nostra vita», «Non voglio lavorare di più, voglio del tempo per vivere», «Non c’è solo il lavoro nella vita, la pensione a 60 anni è già troppo tardi».
Un nuovo welfare
D’accordo, ma chi paga? Come può sostentarsi una società in cui tutti chiedono di lavorare meno? Su questo giornale il sociologo Domenico De Masi propone un’interessante analisi: se è vero che i progressi della tecnologia consentono all’essere umano di produrre sempre di più lavorando sempre di meno, allora chi governa dovrebbe smetterla di inseguire tassi di occupazione fasulli, attraverso il proliferare di lavori precari e stressanti, e concentrarsi invece sul «progettare nuove forme “politiche” di ripartizione dei compiti, della ricchezza, del potere, del sapere, delle opportunità e delle tutele».
«Poiché un numero crescente di persone fruirà di beni e servizi che non contribuisce a produrre – osserva De Masi – occorreranno forme nuove di welfare per soddisfare i bisogni di chi non lavora e forme nuove di gratificazione per soddisfare i bisogni di chi lavora».
Qualche germoglio già si vede: dal Giappone al Regno Unito, dalla Nuova Zelanda alla Spagna, fino ad alcuni esempi anche in Francia, Germania e Italia (vedi Intesa Sanpaolo e Lavazza) iniziano a essere tanti i casi di aziende che introducono – o almeno sperimentano – la settimana lavorativa corta, cioè con orario di lavoro ridotto e spalmato su quattro giorni anziché cinque. I risultati sono il più delle volte ottimi: dipendenti meno stressati e produttività aumentata.
Sarebbe bene che chi governa, o aspira a farlo, prendesse nota e studiasse soluzioni innovative per un mondo che cambia e un elettorato che esprime nuove esigenze. Ma qui entra in gioco un altro sentimento a cui le proteste contro Macron danno corpo, un malessere che cova non solo in Francia ma in tutte, o quasi, le società dell’Occidente: la sfiducia verso le istituzioni.
Cittadini e politica sono ormai separati da un abisso. La rabbia sociale dilaga. Lo abbiamo visto anche in Israele, quando lo scorso 27 marzo centinaia di migliaia di cittadini hanno circondato la Knesset e costretto l’autoritario premier Benjamin Netanyahu a sospendere il suo progetto di riforma della giustizia.
Presa della Bastiglia
«Se in Francia le proteste sono state così veementi è anche per il modo in cui l’intervento sulle pensioni è stato attuato, scavalcando il Parlamento», fa notare Nicoletta Pirozzi, responsabile del programma Unione europea dell’Istituto Affari Internazionali.
Pur di approvare la riforma, il capo dell’Eliseo ha fatto ricorso al famigerato articolo 49 comma 3 della Costituzione, che consente all’esecutivo di adottare un provvedimento senza passare dal voto dell’Assemblea legislativa: «Così i cittadini hanno avuto la percezione che Macron abbia camminato sulle loro teste e su quelle dei rappresentanti democraticamente eletti», spiega Pirozzi.
Così la rivolta delle piazze «rischia di polarizzare ancora di più il sistema politico francese: se entra in crisi l’anima moderata e liberale che Macron interpreta, i soggetti politici che si vedono all’orizzonte sono Le Pen e Mélenchon».
I consensi verso il presidente della Repubblica sono al minimo: secondo un sondaggio del quotidiano Le Figaro, il 64 per cento dei francesi non ha fiducia in lui e il suo indice di popolarità ha perso 5 punti nel mese di marzo. Un crollo che, peraltro non lo destabilizza più di tanto: il leader di En Marche è infatti al suo secondo mandato e la Costituzione gli impedisce di ricandidarsi, quindi può permettersi trascurare la ricerca di approvazione.
«Pensate che mi faccia piacere fare questa riforma? La risposta è no. Avrei potuto mettere la polvere sotto al tappeto, come tanti prima di me, ma dobbiamo andare avanti: è nell’interesse superiore della nazione», si è difeso.
Macron sostiene che la riforma delle pensioni sia necessaria per la tenuta dei conti pubblici. Lo Stato francese spende per il welfare circa il 31,4 per cento del proprio Pil: più di ogni altro Paese europeo. Se guardiamo alla sola spesa pensionistica il rapporto è del 14,7 per cento: il terzo più elevato dopo Grecia (16 per cento) e Italia (15,9). E Parigi – dopo il biennio pandemico – ha un debito pubblico pari al 113 per cento del Pil (in questo caso dietro a Grecia, Italia, Portogallo e Spagna).
Tuttavia, secondo la politologa Nadia Urbinati, docente di Teoria politica alla Columbia University di New York, la tesi del presidente «non è convincente»: «Mentre recupera risorse dalla riforma delle pensioni – fa notare la professoressa – Macron riduce le tasse alle classi più abbienti, che sono poi i suoi veri referenti».
Il capo dell’Eliseo, fra l’altro, è indagato dalla Procura finanziaria nazionale francese per i suoi legami con la multinazionale della consulenza McKinsey, che avrebbe ottenuto appalti per «importi colossali» in cambio di finanziamenti per la campagna elettorale del 2017.
«I cittadini francesi – prosegue Urbinati – protestano contro un potere politico che percepiscono totalmente disinteressato a ciò che loro pensano, un potere che interpreta il fatto di essere stato eletto come una delega assoluta rispetto alle decisioni da prendere. Così la democrazia rappresentativa si trasforma in una oligarchia, nel senso tecnico del termine: la cerchia che è al potere, cioè, ritiene di avere uno status superiore a quello dei cittadini. Non c’è accountability e neppure responsibility».
Non solo: la posizione di Macron, sottolinea la professoressa, «è resa più insindacabile dal sistema presidenzialista francese, meno elastico e legato alla rappresentanza popolare rispetto alla democrazia parlamentare»: in quel sistema, infatti, «se c’è una crisi di governo, cade il governo, ma il presidente resta dov’è (con l’eccezione di Charles De Gaulle, che fu cacciato dalle manifestazioni del maggio 1968)».
In più, prosegue Urbinati, «Macron non ha alle spalle un partito a cui dover rendere conto ed è al secondo mandato: non potendo essere rieletto e facendo parte di una forza politica che ha un’esistenza autonoma da lui, oggi il presidente sente di non avere alcun limite davanti a sé. È di fatto un monarca dai poteri straordinariamente ampi, che ci riporta quasi al cesarismo di Napoleone III».
«Ma i francesi – conclude la politologa – non si fanno abbindolare facilmente. Hanno una profonda cultura della sovranità popolare: le “roi peuple”, il “re popolo”. Nel loro sistema la visione repubblicana, cioè la volontà popolare, si tiene insieme con un esecutivo di stampo monarchico. Ma quando quest’ultimo entra in collisione con la volontà dei cittadini, questi si rivoltano. Basta vedere la storia della Francia: una storia di rivoluzioni continue».
“Oberati”
La rivoluzione di oggi si è accesa in difesa delle pensioni e nel nome del «tempo libero», ma il tema di fondo è il lavoro: un lavoro sul quale si fa concorrenza al ribasso, svilito da stipendi da fame e precarietà, un lavoro dal quale non si vede l’ora di fuggire.
E anche in questo caso la Francia è solo il contesto più rovente al momento, ma il malessere è trasversale a quasi tutto il mondo occidentale. In primis l’Italia, l’unico Paese europeo dell’area Ocse in cui tra il 1990 e il 2020 le buste paga in media sono diminuite anziché aumentare, nonché il quarto nell’Unione europea per percentuale di “working poor”, ossia persone che versano in stato di povertà nonostante abbiano un lavoro.
Eppure gli italiani non sono ancora scesi in piazza: abbiamo una storia diversa dai francesi, il filosofo Antonio Gramsci parlava di «rivoluzione passiva» per descrivere la nostra opinione pubblica così incline ad adattarsi.
A livello globale, la sensazione di disagio collettivo rispetto al lavoro è esplosa in particolare dopo l’uscita dai lockdown pandemici, con il fenomeno delle “grandi dimissioni”: solo in Italia nei primi nove mesi del 2022 hanno lasciato volontariamente il proprio posto più di 1,6 milioni di persone (sono dati del ministero). Meglio disoccupati che infelici, insomma.
Certo, però, non tutti possono permetterselo. Soprattutto in tempo di inflazione galoppante, mutui che riprendono a costare caro e incertezza su tutti i fronti. Ecco allora che un’altra battaglia portata avanti dal basso è quella sui salari e sulla difesa del potere d’acquisto.
Lo scorso 28 marzo, mentre nelle strade francesi andava in scena l’ennesima giornata di scontri fra manifestanti e polizia, i sindacati tedeschi hanno paralizzato la Germania: i lavoratori di porti, aeroporti, ferrovie e in generale di tutti i mezzi pubblici di trasporto hanno scioperato per chiedere corposi aumenti di stipendio, senza i quali – dicono – sarebbe difficile tenere il passo del crescente costo della vita. È stata una delle più grandi mobilitazioni degli ultimi trent’anni nel Paese. «Le persone non sono solo sottopagate, sono irrimediabilmente oberate di lavoro», ha detto il leader sindacale Frank Werneke intervistato dal quotidiano tedesco Bild.
Riorganizzazione
Il problema, riassume Federico Butera, professore emerito di Sociologia dell’organizzazione all’Università Bicocca di Milano, è che «il lavoro non dà più identità né soddisfazione». «Questa forte attenzione al tema del posticipo della pensione in Francia non è altro che una condanna del lavoro: il lavoro insignificante, pesante, pericoloso, ma anche quello qualificato non sufficientemente protetto».
«Il lavoro, che era la fonte dell’identità delle persone, sta perdendo peso: c’è un’emergenza del lavoro di qualità», sottolinea il sociologo. «Mancano strategie, modalità, culture, che diano al lavoro il senso della dignità».
D’altro canto, però, “scappare” dal lavoro non degno per “rifugiarsi” nel tempo libero può rivelarsi un esercizio effimero: «Oggi il tempo libero – secondo Butera – è il più delle volte un tempo degradato, invaso da pulsioni al consumo opulento o mediocre, in ogni caso compulsivo. E questo tocca una grande maggioranza nella popolazione, tanto che qualcuno parla di una “neo-plebe”».
«Questo tempo libero – continua il professore – è un tempo di fuga da un lavoro cattivo ma non di accrescimento personale: non è un tempo durante il quale ci si arricchisce culturalmente e intellettualmente. Lo scenario del cosiddetto tempo libero non è di qualità, esattamente come non è di qualità il lavoro».
Come uscirne? Butera qualche suggerimento lo dà: «Le società occidentali devono essere capaci di attivare programmi e iniziative per dare qualità al lavoro: aprire “cantieri” nelle imprese, nelle Pubbliche amministrazioni, nelle università, nelle organizzazioni del terzo settore, per ridisegnare l’organizzazione del lavoro».
Non esistono scorciatoie: «È impossibile ripensare il lavoro senza ripensare i modelli gerarchici che ci portiamo dietro dal Novecento e senza pensare a un uso della tecnologia per cui l’uomo possa esserne alla guida, anziché guidato».
L’esempio da seguire sono progetti come la Mittbestimmung tedesca, l’Industrial Democracy scandinava ma anche i Patti territoriali per il lavoro siglati in Emilia-Romagna. Quanto al tempo libero, invece, secondo il sociologo bisogna intervenire su due piani: «Il primo è la scuola, che in Italia versa in uno stato deplorevole non solo perché gode di fondi insufficienti ma anche perché nessuno ha messo mano alla sua riorganizzazione. Il secondo è la riorganizzazione del welfare per sostenere i soggetti più deboli, come giovani, donne, anziani».
«Ma la vera domanda – conclude amaro Butera – è: le forze politiche hanno un progetto di società per realizzare tutto questo?». La risposta la lasciamo a voi lettori.