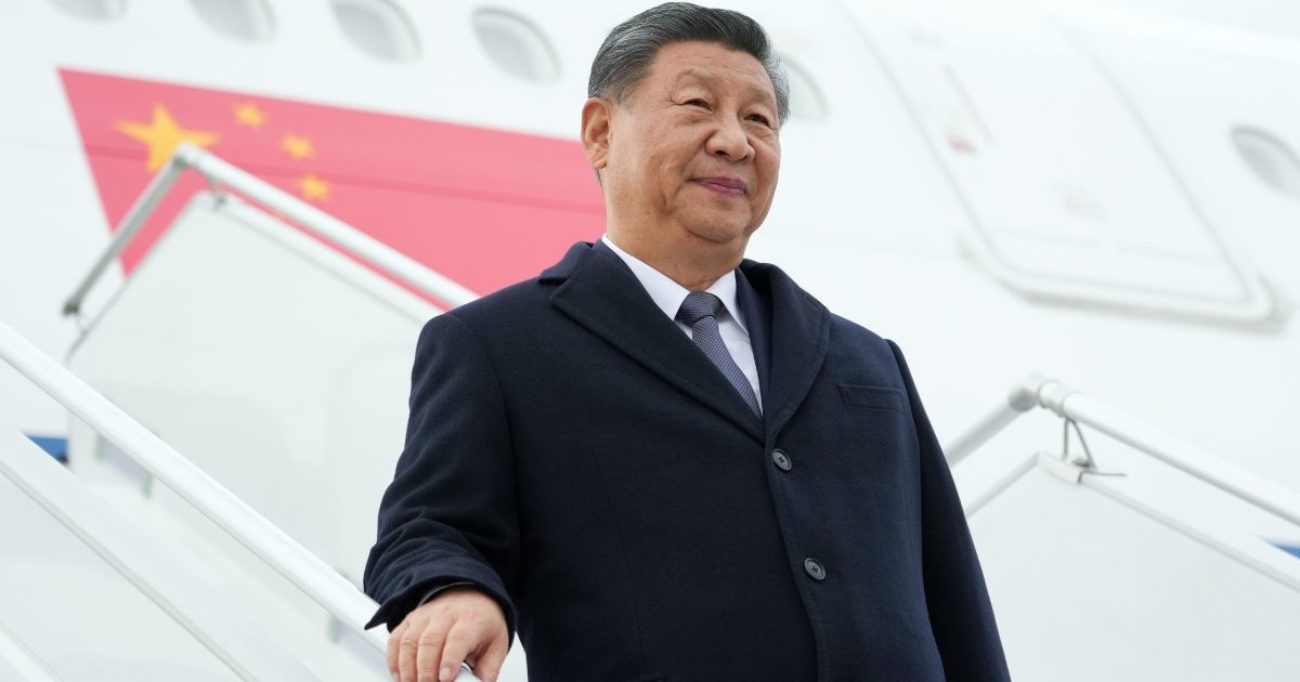Chi è responsabile della nuova ondata di violenza e terrorismo in Afghanistan

I gruppi jihadisti proliferno approfittando di una struttura statale debole, sostenuta da una comunità internazionale che si sta disimpegnando dal paese. L'analisi di Annalisa Perteghella per Ispi
L’Afghanistan è al centro di una nuova ondata di violenza. Oltre quindici anni di missione internazionale non sono riusciti a mettere fine al conflitto civile che ancora insanguina il paese: la recrudescenza degli attacchi terroristici negli ultimi mesi, e soprattutto nel corso degli ultimi giorni, ne è testimone.
Lo scorso 20 gennaio l’attacco all’hotel Intercontinental di Kabul, rivendicato dai Talebani, aveva causato 23 morti; quattro giorni dopo, il 24 gennaio, a essere presa di mira è stata la sede dell’Ong Save the Children a Jalalabad, sei vittime rivendicate dallo Stato islamico nella provincia del Khorasan, la branca locale di Isis.
Sabato 27 gennaio l’attentato con autoambulanza bomba nel centro di Kabul, rivendicato dai Talebani, aveva causato più di 95 morti; nella giornata di ieri, la risposta di Isis è arrivata con un assalto all’accademia militare di Kabul, che ha causato almeno 11 vittime.
Quali sono i motivi della recente ondata di violenza? Quali le conseguenze sulla popolazione civile? Quale ruolo per la coalizione internazionale?
Un paese sempre più fragile
Nonostante il consistente impegno militare internazionale, la violenza non ha mai realmente abbandonato l’Afghanistan.
Lo spostamento degli attacchi dalle zone rurali a quelle urbane, e soprattutto alla capitale Kabul, ha semmai contribuito ad accendere i riflettori dei media internazionali su un conflitto che solo nei primi mesi del 2017 ha causato una media di dieci vittime civili al giorno.
Tra i bersagli privilegiati, oltre ai civili, ci sono proprio le organizzazioni non governative, che con il loro operato cercano di supplire alle gravi carenze nella fornitura di servizi pubblici causate dal malfunzionamento dello stato centrale afghano.
L’attacco alla sede di Save the Children dello scorso 24 gennaio, nel quale hanno perso la vita quattro operatori dell’ONG, un ufficiale di sicurezza e un passante, è infatti solo l’ultimo di una lunga serie: solo nel 2017 sono stati 17 gli operatori umanitari uccisi, 32 i feriti, 47 i sequestrati.
Una escalation che lo scorso ottobre ha portato la Croce rossa internazionale, da sempre attiva nei luoghi di conflitto, all’emblematica decisione di ridurre in modo significativo la propria presenza nel paese.
Dal 2014 il paese è retto da un governo di unità nazionale che vede Ashraf Ghani nel ruolo di presidente e Abdullah Abdullah in quello di capo dell’esecutivo; una forma statuale di compromesso e inedita, voluta dall’ex segretario di Stato USA John Kerry per permettere al paese di uscire dall’impasse post-elettorale causata dalle accuse vicendevoli di brogli tra Ghani e Abdullah.
TPI esce in edicola ogni venerdì
L’accordo tuttavia non ha portato a un reale funzionamento della macchina statuale; l’Afghanistan si sostiene soprattutto grazie all’impegno finanziario e politico della comunità internazionale, che sta però mettendo in atto un graduale disimpegno dal paese.
Il progressivo fallimento dello stato afghano ha rappresentato dunque il contesto ideale per la proliferazione dei gruppi non statuali, che secondo le stime più prudenti controllano oggi il 40 per cento del territorio afghano.
Ancora al centro del jihad globale
Nella proliferazione di gruppi non statuali, sono due gli attori che si contendono il primato: i Talebani, storico gruppo dell’insorgenza afghana, e lo Stato islamico, qui presente con la sua filiale locale Wilayah Khorasan.
Se i Talebani rappresentano ancora oggi un movimento terroristico che porta avanti un’istanza di liberazione nazionale, dunque una lotta limitata ai confini afghani, rivolta contro un governo percepito come illegittimo e una presenza internazionale considerata alla stregua di un’occupazione, lo Stato islamico presenta caratteristiche assai diverse.
Presente nel paese dal gennaio 2015 – quando un gruppo di comandanti di medio rango del gruppo Tehrik-e Taliban, sull’onda delle imprese compiute dallo Stato Islamico in Siria e in Iraq, aveva creato una cellula nell’est del paese – il gruppo ha la sua roccaforte nella provincia del Nangharar, a circa duecento chilometri dalla capitale Kabul, vicino al confine con il Pakistan.
A differenza dei Talebani, lo Stato islamico è impegnato in una causa di portata globale, in linea con l’aspirazione e la vocazione universale del Califfato.
La sua lotta dunque trascende i confini dell’Afghanistan, e si serve di tecniche anche più brutali di quelle impiegate dai Talebani. Non è un caso, dunque, se dal 2015 a oggi la violenza nel paese sia andata aumentando.
Essa non sarebbe però da attribuire alla presenza dello Stato islamico in sé (dato che i Talebani hanno perpetrato un numero maggiore di attacchi), ma piuttosto all’effetto di competizione tra i due gruppi seguito alla nascita di Wilayah Khorasan.
Rimpatri dall’UE: ma l’Afghanistan è sicuro?
A partire dal 2015, più di 400mila afghani hanno fatto richiesta d’asilo in Europa (prevalentemente in Germania e Svezia), rendendo l’Afghanistan uno dei principali paesi d’origine dei richiedenti asilo.
A tale numero si è accompagnato un aumento esponenziale degli ordini di rimpatrio, a cui però corrispondeva spesso un basso numero di ritorni effettivi, a causa di fattori burocratici o politici.
L’Unione europea ha cercato di affrontare questi ostacoli facendo dei rimpatri un obiettivo politico primario. È in questo quadro che si inserisce l’accordo del 2016 tra governo afghano e UE – Joint Way Forward – in materia di immigrazione.
Da un lato, Kabul si impegna a facilitare il ritorno di propri cittadini la cui richiesta d’asilo è stata respinta – secondo dati Eurostat, il tasso di rifiuto è del 52 per cento, piuttosto alto in confronto ai tassi di rifiuto di cittadini provenienti da altre zone di conflitto, come la Siria (5%); dall’altro, Bruxelles si impegna a coprire i costi di rimpatrio e ad assistere gli afghani nel processo di reinserimento.
La firma dell’accordo è avvenuta in concomitanza con il rilascio da parte di Bruxelles di sostanziosi aiuti finanziari all’Afghanistan. L’UE e i suoi Stati membri hanno infatti stanziato 5 miliardi di euro su un totale di 14 miliardi da parte di tutti i donatori per il periodo 2016-2020, rendendo l’UE, nel suo complesso, il più grande partner di cooperazione allo sviluppo dell’Afghanistan.
Sfortunatamente, l’aumento degli ordini di rimpatrio si sovrappone a un aumento dei rischi per coloro che ritornano. La recrudescenza del conflitto civile e la disgregazione del quadro di sicurezza dell’Afghanistan mette in dubbio il suo status di “paese d’origine sicuro”, condizione che permette l’attuazione dei ritorni.
La missione di assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan ha riferito che il 2016 e i primi sei mesi del 2017 hanno segnato un record di vittime civili dal 2009, anno in cui l’ONU ha iniziato a compilare queste statistiche, mentre un rapporto di Amnesty International, pubblicato lo scorso ottobre, descrive alcuni dei numerosi casi di afghani rimpatriati dall’UE che sono stati uccisi, feriti in attentati dinamitardi o perseguitati per loro orientamento sessuale o motivi religiosi.
Alla luce di questa situazione, risulta sempre più complicato coniugare la sicurezza dei Paesi europei con il rispetto dei diritti dei richiedenti asilo: a rischio non solo migliaia di vite umane, ma anche la sostenibilità delle politiche europee di asilo e rimpatrio.
USA: una “nuova” strategia?
Nell’agosto 2017 Donald Trump ha presentato la nuova strategia USA per l’Afghanistan. Pur segnalando che il suo desiderio iniziale era quello di ritirare le truppe – in linea con il disimpegno promesso a livello globale – Trump ha ammesso di aver dato ascolto ai propri consiglieri, che lo hanno messo in guardia circa il fatto che il ritiro dei militari USA avrebbe significato vanificare gli sforzi compiuti dal 2001 a oggi.
Sia il Consigliere per la sicurezza nazionale H.R. McMaster che il segretario alla Difesa Jim Mattis avrebbero sconsigliato Trump dal ripetere l’errore compiuto da Obama in Iraq, dove il ritiro delle truppe USA in un contesto di mancata pacificazione è stato tra i fattori che hanno consentito l’ascesa dello Stato islamico.
Trump dunque ha approvato la strategia delineata da McMaster e Mattis – entrambi hanno combattuto in Afghanistan – che prevede il passaggio da un impegno basato sul tempo a uno basato sugli obiettivi.
Ancora una volta a differenza di quanto fatto da Obama, Trump ha affermato che non esiste una data entro la quale le truppe statunitensi si ritireranno, bensì che il ritiro USA è subordinato al raggiungimento di adeguate condizioni di sicurezza nel paese.
In termini numerici, Trump ha promesso il dispiegamento di 3.900 uomini, che si aggiungono ai circa 7.000 soldati USA già presenti (su un totale di 13.500 uomini della coalizione internazionale impegnata nella missione Resolute Support).
Il presidente USA ha poi segnalato l’intenzione di proseguire con la politica già varata da George W. Bush, che consiste nel fare pressione sul Pakistan affinché metta fine al suo storico sostegno per l’insorgenza afghana.
Si spiega così, dunque, la decisione dello scorso 4 gennaio di sospendere 1,3 miliardi di dollari in aiuti militari a Islamabad. Nella strategia di Trump non sembra esserci spazio però né per il dialogo con i Talebani né per il nation-building, obiettivi che sarebbe invece auspicabile perseguire ai fini della ricostruzione e della pacificazione dello stato afghano.
Senza la creazione di una offerta politica alternativa ai Talebani, che possa sottrarre loro consenso e margine di azione, appare vano ogni tentativo di risolvere la situazione per via militare.
L’analisi è stata pubblicata da ISPI con il titolo “Afghanista: fine pena mai” e ripubblicata in accordo su TPI con il consenso dell’autore.
A cura di Annalisa Perteghella, ISPI Research Fellow