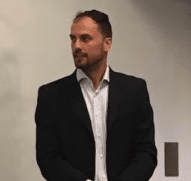In Colombia la polizia sta massacrando le popolazioni indigene che protestano contro il governo

42 civili uccisi dalle forze di polizia, oltre 500 cittadini scomparsi, più di mille arresti. È questo il bilancio provvisorio dei dodici giorni di manifestazioni massive contro il governo di Iván Duque in Colombia. Mentre i colombiani riempiono le piazze del mondo per denunciare le repressioni statali, la violenza della forza pubblica si è riversata sulle popolazioni indigene
La città di Cali è completamente militarizzata. I suoni sordi delle sparatorie contro i civili rimbombano ad ogni ora del giorno. Decine di pick-up bianchi di paramilitari pattugliano le strade cittadine. Con targhe nascoste e vetri oscurati, aprono il fuoco ad altezza uomo nelle zone delle proteste. Da oggi i confini della regione del Valle del Cauca sono chiusi: è sempre più difficile, per giornalisti e associazioni per i diritti umani, raggiungere le zone delle rappresaglie per testimoniare ciò che sta accadendo. In alcune occasioni, la repressione armata delle manifestazioni è stata accompagnata da ‘apagones’: interi quartieri sono stati privati di corrente elettrica, i loro abitanti lasciati privi di luce e connessione internet di fronte agli abusi della polizia nazionale.
Oltre alle decine di omicidi, alle centinaia di persone scomparse e agli arresti di massa, si registrano già dieci casi accertati di violenze sessuali. La “democrazia più solida d’America Latina”, così suole presentarsi al mondo l’istituzione politica colombiana, sta agendo nei confronti dei manifestanti con la brutalità delle più perfide dittature militari della storia recente del continente.
La violenza verso le comunità indigene
I metodi repressivi del governo di Duque hanno però altre radici: quelle del sicariato e del paramilitarismo. Una guerriglia contro la popolazione, i cui responsabili non sembrano intenzionati a nascondere la violenza delle loro aggressioni. Lo hanno mostrato ancora una volta i fatti del 9 maggio, quando i manifestanti di Cali hanno accolto una lunga carovana di indigeni di etnia nasa, misak, yanakona, kokonuko.
Sopraggiunti in migliaia dalla vicina Cordigliera Centrale delle Ande colombiane, gli indigeni hanno accompagnato la protesta sociale con le loro personali ragioni di dissidenza: denunciare uno Stato complice di una guerra ‘contro la terra’ che sta affliggendo le montagne andine, in mano a narcotrafficanti, dissidenze guerrigliere e alle multinazionali del settore minerario.
Gli indigeni a Cali hanno chiesto un incontro con le istituzioni. Sono invece state accolte da ulteriori scariche di proiettili di Stato: pistole, fucili, mitra. Spara la polizia, ma anche gruppi paramilitari e ‘cani sciolti’, estremisti di destra autorganizzati che hanno risposto all’appello dell’ex-Presidente Álvaro Uribe Vélez, padrino politico dell’attuale governo, di reprimere la protesta sociale senza sconti di violenza. Le comunità indigene andine sono già afflitte da anni di persecuzioni armate nei loro territori, dovute a una coraggiosa lotta contro la presenza di narcotrafficanti e di coltivazioni illecite di coca e marihuana.
Oggi a Cali si ritrovano perseguitate da chi dovrebbe proteggerle. Vittime di un fuoco incrociato e di un conflitto armato che lo Stato colombiano, dopo gli accordi di pace “mutilati” con le FARC del 2016, ha scelto di nascondere sotto il tappeto delle periferie dimenticate: una scelta che inevitabilmente avrebbe presentato il conto, portando a un’inevitabile riacutizzazione della tensione urbana. Ma la questione indigena è solo una delle tante chiavi di lettura di queste giornate da incubo per la Colombia.
Dodici giorni di tensione
Le manifestazioni di massa hanno avuto inizio il 28 aprile, quando una larga parte della popolazione colombiana era scesa in piazza per opporsi alla riforma tributaria proposta dal governo di Iván Duque. La riforma era apparsa immediatamente inadeguata sia per i contenuti (aumento delle imposte di servizio su diversi beni di prima necessità) che per i tempi (la Colombia sta attraversando la terza ondata della pandemia ed è uno dei paesi latinoamericani maggiormente colpiti dall’impatto sociale del Covid-19 sui tassi di disoccupazione).
Pochi giorni dopo l’inizio delle manifestazioni massive che hanno coinvolto tutte le maggiori città colombiane, Duque ha ritirato la proposta, promettendo di intervenire sui punti più critici. Parallelamente, ha dato ordine ai capi delle forze armate di reprimere le proteste con le armi. La tensione sociale latente è presto esplosa. Le proteste pacifiche si sono moltiplicate per frequenza e partecipazione, arrivando a coinvolgere milioni di persone.
Le arterie principali di ingresso alle grandi città sono bloccate in segno di protesta. Insieme, sono arrivate le sommosse violente: nella prima settimana di maggio si sono registrati a Bogotá attacchi violenti di alcuni manifestanti nei confronti della polizia, saccheggi di grandi centri commerciali, danneggiamenti a istituti bancari e a strutture private, interruzione forzata dei sistemi di trasporto.
Paramilitarismo di Stato
Disegnare un quadro completo delle vicende di questi giorni è spinoso. Non è chiaro il presunto ruolo dei disturbatori infiltrati nelle manifestazioni, ma neanche quello dei comandi urbani dei gruppi guerriglieri ancora attivi, in particolare delle Dissidenze delle FARC e dell’ELN, che stanno probabilmente provando a sfruttare silenziosamente il terreno fertile del disordine sociale generalizzato a loro vantaggio.
Ciò che rimane senza zone d’ombra sono gli omicidi quotidiani quotidiano di civili disarmati, tramite modalità di azione statale che richiamano distintamente i massacri realizzati dai gruppi paramilitari delle AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) nelle zone rurali della Colombia agli inizi degli anni Duemila.
In quei tempi, il braccio segreto dello Stato interveniva nei confronti di ogni singolo contadino sospettato di essere ‘alleato’ della Guerriglia delle FARC. Per essere considerato un aiutante dei guerriglieri era sufficiente vivere in un luogo in cui le FARC avessero transitato, in una paranoia omicida che è costata la vita a decine di migliaia di contadini nel corso degli ultimi decenni.
Chi protesta?
I massacri di innocenti perpetrati dalle AUC rivivono parzialmente oggi nelle strade di Cali, dove le rappresaglie statali si dirigono verso ogni tipo di dissidenza pacifica. Recriminano le società indigene, ma anche le comunità afrocolombiane, che a Cali si scontrano con un modello sociale profondamente razzista e discriminatorio: Cali è infatti la città delle grandi élite bianche latifondiste e della narcopolitica, epicentro dello sfruttamento degli afrocolombiani nelle immense distese di coltivazioni di canna da zucchero della regione.
Recriminano anche gli abitanti delle periferie urbane, di Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla e Cartagena. Periferie dimenticate dai progetti di sviluppo urbano, così come le città della costa pacifica, da Buenaventura a Tumaco, in cui l’abbandono statale e la corruzione degli agenti delle acque internazionali circostanti ha permesso la trasformazione dei rispettivi porti nei maggiori centri di esportazione mondiale della cocaina, con inevitabili ripercussioni sui tassi di violenza delle città.
Protestano i contadini, martoriati dai Trattati di Libero Commercio con Canada e Stati Uniti che li costringono a buttare buona parte dalla loro produzione, e ancora impantati nelle difficoltà di liberarsi dalle estorsioni dei gruppi armati nelle regioni rurali. Protestano le società amazzoniche, lasciate alla mercé delle multinazionali estrattiviste di minerali, legno, petrolio.
Chi protesta è la Colombia delle periferie, le stesse periferie in cui erano state relegate le macerie del conflitto armato, in cui si adombravano le enormi disparità del modello socioeconomico colombiano. È la stessa Colombia il cui Stato, oggi, sembra voler dichiarare guerra al proprio popolo: è la Colombia di Iván Duque, in cui vengono uccisi in piazza manifestanti, attiviste e attivisti, giornalisti, difensori dei diritti umani.