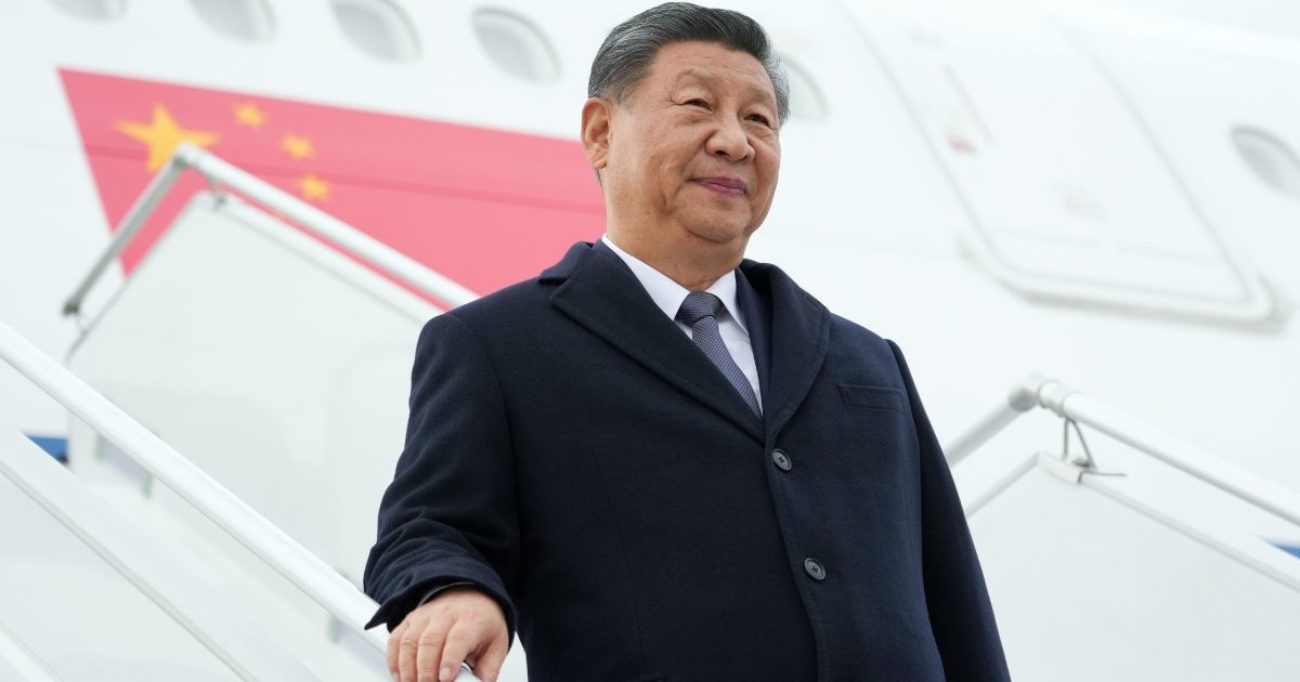Le carceri brasiliane senza guardie né armi

Elvira Zaccari e Camilla Guerrato raccontano come si vive all'interno delle carceri Apac, dove un metodo riabilitativo innovativo sta dando ottimi risultati
In Brasile esistono carceri senza guardie dove sono i detenuti ad avere le chiavi e dalle quali nessuno vuole scappare.
Siamo in Minas Gerais, stato di circa venti milioni di abitanti nel sudest del Brasile, dove a oggi esistono 50 strutture senza agenti penitenziari che ospitano circa 3.500 detenuti. Si tratta delle prigioni Apac, gestite e amministrate dall’omonima organizzazione (Associazione di assistenza e protezione ai condannati) con celle e grate come le galere statali, ma in cui i detenuti fanno a gara per entrare.
Lo dimostrano le decine di lettere che ogni giorno arrivano sulla scrivania di Valdeci Antonio Ferreira, direttore generale della Fbac (Fraternitade brasileira de assistência aos condenados) l’associazione che coordina le Apac.
“La richiesta volontaria di trasferimento da parte del detenuto è il primo criterio per entrare in Apac, per questo riceviamo così tante lettere” spiega Ferreira.
“Chiunque può entrare, indipendentemente dal reato commesso e dagli anni che dovrà scontare, ma deve esserci la volontà dell’individuo e una sentenza definitiva del tribunale. Non solo, è importante che la famiglia abiti nella città in cui il detenuto chiede di essere trasferito, perché essa è parte del progetto Apac”.
Ad aiutarlo nel lavoro che svolge da trent’anni ora c’è anche Rinaldo Claudio Guimarães, ex detenuto Apac e attualmente volontario in quella stessa prigione che lo ha visto riabilitarsi.
Finito agli arresti per peculato e condannato a dieci anni, poi divenuti tre grazie a uno sconto di pena, Rinaldo è stato trasferito al carcere di Itauna pochi giorni dopo il suo arresto perché disabile. È lui a farci capire il perché di tante richieste per entrare in quel carcere e perché, una volta dentro, i detenuti vogliano uscire solo dalla porta principale.
Pareti bianche e azzurre, spazi aperti e un appartamento in cui poter incontrare i familiari e, se sposati, ricevere visite coniugali. Ci si sveglia alle 6 del mattino e si seguono tutte le attività organizzate dai volontari: lavoro, scuola, incontri per la valorizzazione della persona, momenti di spiritualità o di riposo. Alle 10 di sera comincia l’ora del silenzio.
Il sistema di riabilitazione è progressivo ed è diviso in tre fasi. Rinaldo ci spiega che cancelli e sbarre vengono serrati a chiave solo nel regime chiuso. Il semi-aperto prevede meno divisioni strutturali e il recuperando, così vengono chiamati tutti i carcerati in Apac, viene preparato al contatto con l’esterno. Nel regime aperto il recuperando sconta la pena solo di notte, mentre di giorno lavora.
Non ci sono agenti di polizia penitenziaria. Al loro posto solo i volontari dell’associazione, che non portano armi. Le chiavi, invece, sono gli stessi detenuti ad averle. Non tutti, in media uno ogni 25. Le chiavi sono affidate a quei recuperandi che hanno completato il percorso riabilitativo e che vengono incaricati di gestire le celle e monitorare il comportamento dei compagni. Questo, spiega ancora Ferreira, “serve alla responsabilizzazione del detenuto, che è uno dei 12 pilastri del nostro programma”.
TPI esce in edicola ogni venerdì
È proprio il metodo di riabilitazione il vero motivo per cui i detenuti vogliono andare in Apac. “Qui l’uomo riacquista la sua dignità e con essa l’idea di poter avere un futuro. È questo che ci spinge a voler venire qui”, spiega Rinaldo.
Basato principalmente su responsabilizzazione del detenuto, sul coinvolgimento di famiglia e società civile e sul reinserimento lavorativo, il metodo Apac fu formulato dal giurista e giornalista italo-brasiliano Mario Ottoboni negli anni Settanta, a partire dalle testimonianze di chi viveva dietro le sbarre.
“La lezione più importante che apprendemmo con i detenuti, dopo dodici anni di lavoro e studio”, si legge nel suo libro ‘Ammazziamo il criminale?‘, “fu esattamente questa: dei detenuti noi non capivamo niente”.
“Quando entri in Apac, racconta Rinaldo, nessuno ti chiede perché sei finito dentro. Il nostro motto è qui entra l’uomo, il delitto resta fuori. Nel sistema tradizionale tutti vengono identificati attraverso un numero, mentre in Apac vieni chiamato per nome. Questo è il primo passo per la riappropriazione dell’identità personale. È da qui che comincia il lavoro di riabilitazione”.
Il Brasile, con quasi 620mila carcerati, è attualmente il quarto paese al mondo per numero di detenuti. In media l’80 per cento di loro tornerà a delinquere. In Apac la recidiva scende al 10 per cento.
“È con i risultati che siamo riusciti a rompere le barriere del pregiudizio sociale, dell’idea che il carcerato deve soffrire, deve morire, che l’unico malvivente buono è il malvivente morto. Ora è la popolazione stessa a volere l’apertura di nuove Apac”, afferma Ferreira.
Il sistema ha convinto i cittadini ma anche le istituzioni. Attualmente quattro stati brasiliani (Minas Gerais, Maranhão, Paraná, Rio Grande do Norte), hanno deciso di investire soldi pubblici nel progetto Apac.
Hanno cominciato versando il costo pro capite di ogni recuperando, che è di 900 reais, l’equivalente di circa 264 euro (molti meno dei 3.000, circa 880 euro del sistema tradizionale), poi cominciando a finanziare le strutture stesse.
Oggi il modello Apac è sviluppato in 23 paesi al mondo ma ancora in forma embrionale. In Italia un progetto simile è partito a Rimini, prende il nome di Cec, Comunità educante con i carcerati, ed è coordinato da Giorgio Pieri dell’associazione Papa Giovanni XXIII.
“A Itauna in 12 anni non è mai avvenuta una fuga dal regime chiuso”, conclude Rinaldo. “Il motivo? Sta tutto nelle parole di un ex- recuperando che ho conosciuto, José de Jesus: dall’amore nessuno fugge”.
*A cura di Elvira Zaccari e Camilla Guerrato