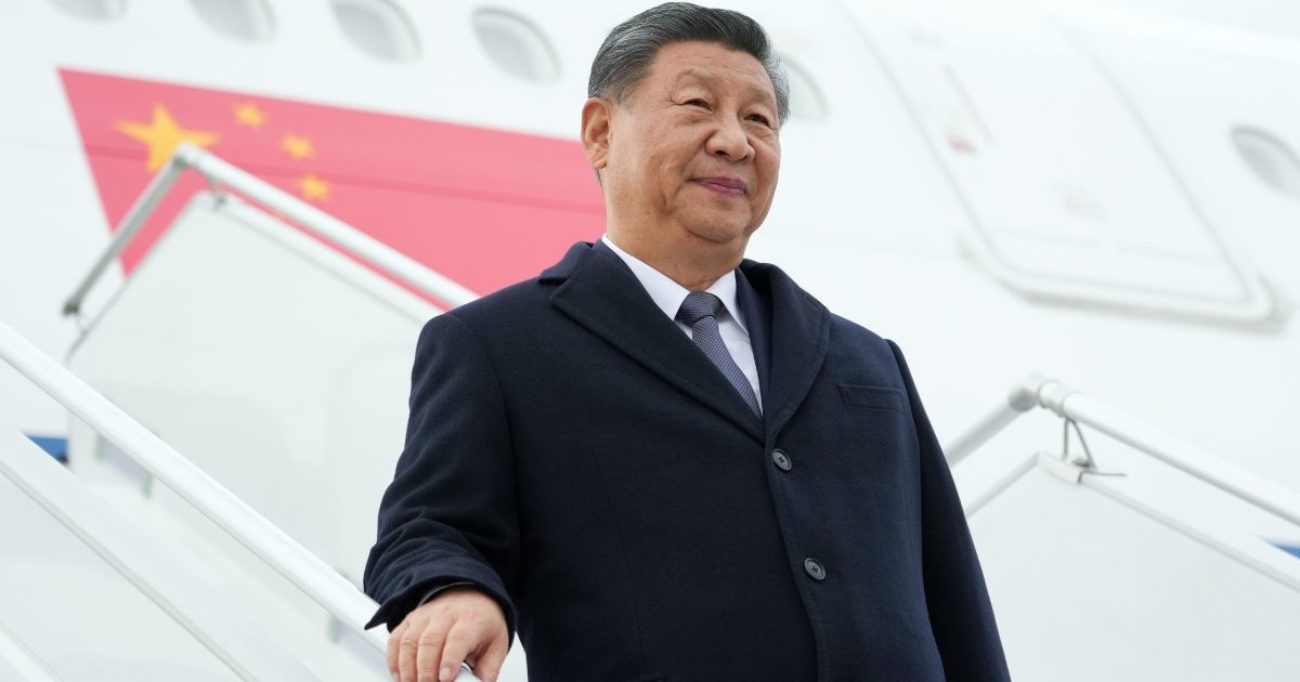Cucinare è una delle principali cause di deforestazione in Africa: anche un fornelletto può salvare il Pianeta

L’80% degli africani cucina con legna o carbone. Così intere foreste rischiano di sparire. E aumentano le emissioni di CO2. Ora una startup italiana prova a invertire il trend a iniziare dallo Zambia. Distribuendo attrezzi per cuocere gli alimenti senza danni alla natura. Intervista al fondatore di Koalisation
“L’Africa è il Paese in cui si giocherà il futuro del mondo”. Ne è convinto Mathieu Meneghini, fondatore e Ceo di Koalisation, una startup italiana che opera in Zambia. L’obiettivo è promuovere lo sviluppo sociale, coinvolgendo le comunità indigene, e rigenerare gli ecosistemi, ad esempio riducendo le emissioni di CO2.
Pochi sanno che la naturale necessità umana di mangiare è una delle principali cause di deforestazione in Africa. Circa 500 milioni di persone, infatti, cucinano utilizzando legna o carbone. Solo in Zambia ogni anno vengono tagliati quasi 300mila ettari di foresta. Il progetto portato avanti da Koalisation fornisce tra le altre cose un sistema di cottura più efficace, veloce, economico e molto meno impattante sull’ambiente.
Dottor Meneghini, come è nata l’idea di questa startup?
“Ero già da tempo un attivista ambientale e lavoravo come consulente in una società illuminata. Mi sono reso conto del fatto che spesso la sostenibilità viene portata avanti solo per marketing o pressione normativa, ma non c’è una reale adesione a questi valori. Così con il mio migliore amico, Jonathan Senesi, abbiamo iniziato a lavorare a questo progetto”.

Da cosa siete partiti?
“Ci siamo licenziati e, con i nostri risparmi, siamo andati in Zambia, per parlare con le istituzioni, le persone, fare ricerca. Solo stando sul posto ci si rende conto di quanto sia enorme il problema. Dopo non poche difficoltà di vario genere, siamo riusciti ad avviare il nostro progetto in una baraccopoli, la seconda più grande dello Zambia”.
Qual è il significato di Koalisation?
“Il nome prende spunto dalla metafora del koala abbracciato all’albero: in questo caso l’uomo è il koala e l’albero è il mondo, sempre più devastato. L’azione del singolo, però, serve a poco, se non c’è una sinergia collettiva”.
Cosa è necessario fare allora?
“Credo che quello della sostenibilità sia un tema cruciale, ma lo si guardi dal punto di vista sbagliato. Per risolvere il problema ambientale bisogna andare alle sue radici, che sono di natura sociale. In Africa 500 milioni di persone non hanno accesso a fonti energetiche rinnovabili, e questo crea un’enorme difficoltà per poter cucinare e quindi mangiare quotidianamente. Una necessità umana, che però rappresenta la prima causa di degradazione forestale, che poi porta alla deforestazione, nell’Africa subsahariana”.
Ci spieghi più dettagliatamente.
“Circa l’80% della popolazione locale cucina mettendo la carbonella in una sorta di lamiera di metallo bucherellata. Per fare un chilo di carbonella ne servono 7-9 di legna. Ci sono quindi persone che nei boschi tagliano una decina di alberi al giorno e poi gli danno fuoco. Questo sta portando alla sparizione di intere foreste”.

Qual è il vostro approccio?
“Come dicevamo, la nostra idea è che per risolvere i problemi ambientali serva andare a monte, cioè lavorare sull’aspetto sociale. Piantare un albero è importante, ma ha un impatto relativo. Serve una progettualità olistica, che cioè intervenga sulle varie aree del problema. Il nostro è un approccio continuativo, non solo sul breve termine, ma in maniera permanente”.
TPI esce in edicola ogni venerdì
Entriamo nello specifico del vostro progetto: cosa state facendo in Zambia per aiutare la popolazione e salvaguardare l’ambiente?
“Iniziamo con una serie di azioni che siano fortemente impattanti. In primis forniamo dei fornelletti (“stoves”), perché, come spiegavo, la cucina è una delle cause principali della deforestazione. Ci sono persone che tagliano per giorni alberi a non finire, li mettono in un fosso e gli danno fuoco. Formano così questo carbone, il “charcoal”, che viene poi distribuito alle famiglie. Anche le persone più benestanti utilizzano questa tecnologia assolutamente obsoleta e inefficace, perché hanno sempre fatto così ed è insito nella loro cultura. Con i nostri fornelletti, invece, tagliamo del 70% l’uso del charcoal. Si tratta di un sistema anche molto più veloce ed efficiente: per cuocere dei fagioli, ad esempio, impiegano 20 minuti, invece delle due ore necessarie in precedenza. È anche un bel risparmio a livello economico, visto che ogni famiglia spende circa il 40% del proprio guadagno mensile nell’acquisto del charcoal. Ma soprattutto salviamo moltissimi alberi, circa 20 già cresciuti all’anno a famiglia”.
Un risparmio non da poco.
“Stiamo inoltre coinvolgendo i produttori di charcoal per produrre dei “green briquettes”, delle mattonelle di biomassa, che tagliano di un altro 30% l’impatto ambientale. Bisogna poi anche comprendere e rispettare gli usi e le abitudini del luogo. Inizialmente pensavo di utilizzare delle stoves a induzione con pannellino solare, visto che avrebbero completamente abbattuto i costi e le emissioni, ma la gente mi ha detto che non le voleva, perché la carbonella e la combustione sono fondamentali per cucinare i fagioli secondo la loro tradizione”.
Come funzionano dunque questi fornellini che state fornendo alle famiglie?
“Si utilizza sempre il charcoal, perché tutti i progetti che hanno provato a sostituirlo non hanno dato risultati, proprio per le questioni di attaccamento culturale di cui dicevamo. Rispetto ai metodi di cottura tradizionali usati dalle popolazioni indigene, queste stoves hanno un efficientamento della camera di combustione e del mantenimento del calore molto superiori”.

Quali sono le altre iniziative che state portando avanti?
“I problemi sono molteplici. Come l’accesso all’acqua potabile. Abbiamo costruito una torre idrica che garantisce l’accesso all’acqua alla clinica e ai beneficiari del nostro progetto. Portiamo quindi dei grandi boccioni e, tramite una pompetta, ne forniamo circa 60-70 litri al giorno a famiglia. In Zambia malattie come il colera imperversano e l’acqua è spesso contaminata, per cui con questa soluzione tante persone possono bere e cucinare in sicurezza. L’idea di base è quella di utilizzare tecnologie molto semplici ma di grosso impatto. Un ultimo aspetto del nostro progetto è quello della biodiversità. Insegniamo agli abitanti del luogo a fare alberi da frutto, da seme o da talea (una fruit forest). La biodiversità permette di ridurre la temperatura media degli ambienti e protegge dalle intemperie. Abbiamo avviato, inoltre, una produzione di alveari: grazie al miele potranno avere un reddito rilevante e totalmente naturale”.
Quali sono i vostri progetti nel medio-lungo termine?
“Siamo partiti con mille famiglie. L’obiettivo è creare un modello da poter replicare in altri Paesi dell’Africa subsahariana, anche fornendo ad altre realtà locali il nostro know-how”.
L’Africa è un continente ricco di risorse, ma che spesso in passato è stato solo depredato.
“Siamo vittime di una visione occidentalocentrica, ma il mondo è molto più complesso. Dobbiamo capire che se non lavoriamo in sinergia con i Paesi in via di sviluppo non ci sarà futuro. Le potenze occidentali si sono appropriate in maniera sistematica del capitale naturale di queste persone. Per questo l’Europa deve in primis riconoscere una sua responsabilità storica, e in seguito capire che bisogna avviare una collaborazione con loro, pur nel rispetto della diversità di cultura e ideali”.
Un’opportunità, dunque. Anche perché non sembrano esserci alternative.
“Ci sono un miliardo e mezzo di poveri al mondo su cui nessuno investe. Ma queste comunità sono fondamentali per preservare gli ecosistemi e rigenerarli. Ed è da ciò che dipende il futuro dell’umanità: da problema, quindi, possono diventare la soluzione”.