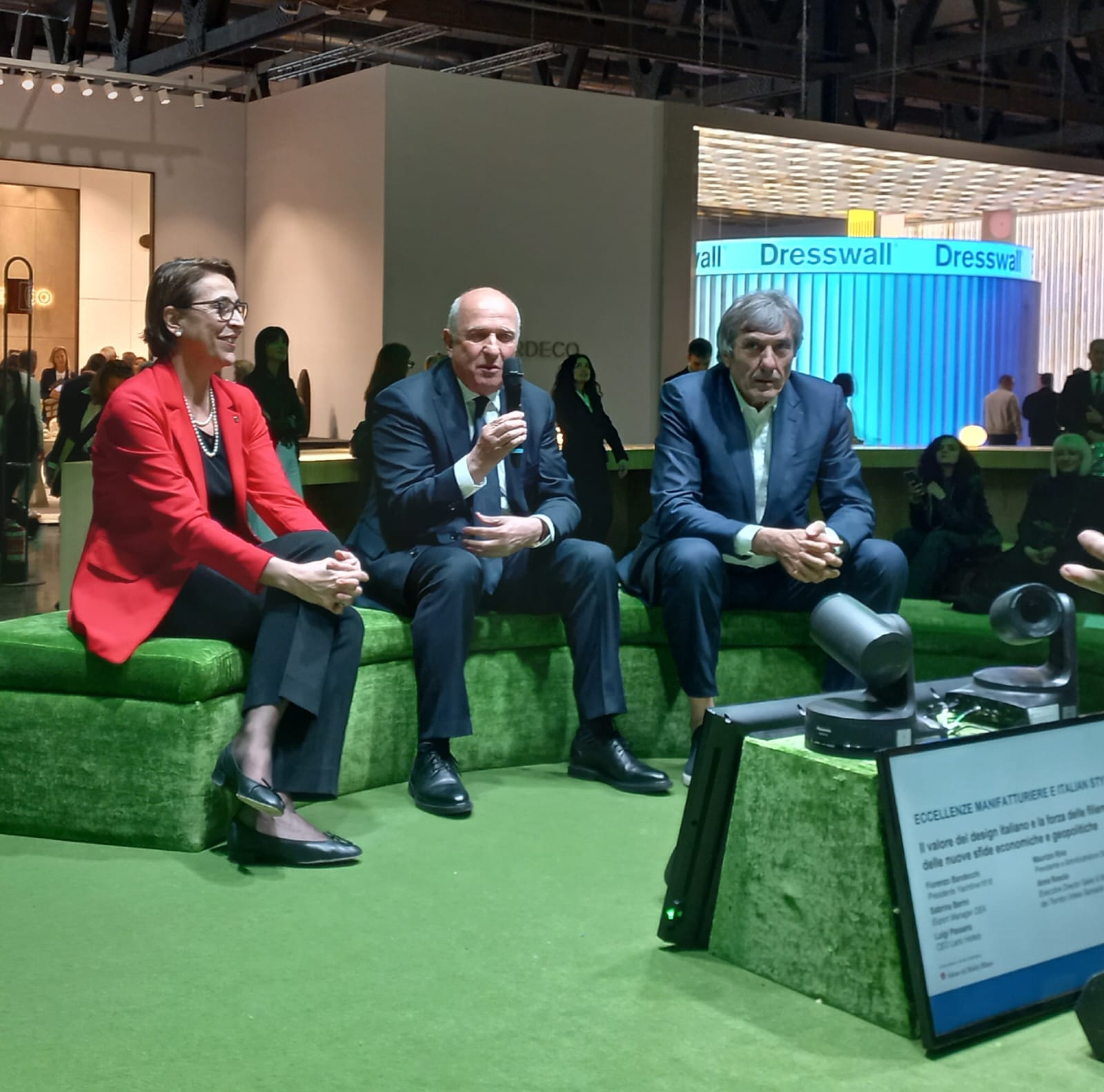Altro che giustizia sociale: la nuova austerity energetica è roba da ricchi

Negli anni ’70 la riduzione dei consumi energetici mirava a cambiare il modello di sviluppo. I razionamenti di oggi invece penalizzeranno i più poveri. Senza intaccare i super profitti delle oil company
Avete visto meno yacht questa estate? No, perché l’industria degli yacht marcia a pieno regime. Così come quella delle supercar, del resto: Ferrari nell’ultimo trimestre ha registrato un aumento del 22% dell’utile netto. I ricchi non temono certo di dover sborsare qualche spicciolo in più per pagare le bollette o per fare il pieno. Solo nel mese di luglio i viaggi dei miliardari francesi a bordo di jet privati hanno generato emissioni di CO2 pari a quelle di un francese medio nell’arco di 52 anni di vita. Nell’Unione europea il 10 per cento dei più ricchi emette quanto il 50 per cento del più povero. Eppure, di fronte all’inflazione più alta dalla crisi degli anni Settanta, generata oggi in Europa in primo luogo proprio dall’aumento dei prezzi dei beni energetici importati, sta dilagando la povertà. La Bank of England stima che il reddito medio delle famiglie britanniche subirà il tracollo più consistente da quando, negli anni Sessanta, sono iniziate le rilevazioni statistiche sul reddito familiare. La Germania dal canto suo ha registrato un passivo della bilancia commerciale per la prima volta dal 1991 a causa dell’aumento dei prezzi delle importazioni energetiche. Quasi il 10 per cento degli italiani (5,6 milioni di individui) sono in povertà assoluta, ai massimi storici dall’avvio delle serie statistiche, con una tendenza all’aumento a causa dell’aumento delle bollette. L’Unione europea si avvia così a un’altra recessione economica dopo quella provocata dal Covid, la cui intensità dipenderà essenzialmente dall’ammontare dei tagli alla fornitura di gas russo.
Per limitare i rincari delle bollette i governi europei stanno agendo in ordine sparso. Alcuni, come quello tedesco, hanno imposto tetti ai prezzi, mettendo in difficoltà le imprese energetiche che devono comprare a prezzi crescenti e servire i clienti a prezzo fisso. Berlino ha preso il controllo del colosso del gas Uniper, sborsando 15 miliardi di euro per evitarne il fallimento. Altri governi, come quello italiano, hanno stanziato soldi per moderare gli aumenti delle bollette per i più poveri e per diminuire le accise sui carburanti, tentando di tassare i così detti “sovraprofitti” delle società energetiche (ma le entrate sono state un decimo di quelle preventivate). Queste misure non bloccano però gli aumenti dei prezzi di mercato del gas nell’Ue (che viaggiano a dieci volte il livello medio del 2021) e quelli dell’elettricità (più di cinque volte quelli dello scorso anno in Germania).
Se, come appare possibile, la Russia oltre a ridurre di quattro quinti le forniture di Gazprom via gasdotti, le taglierà del tutto, i consumi energetici del Vecchio continente dovranno necessariamente calare. I piani europei prevedono un maggiore ricorso al gas naturale liquefatto principalmente proveniente dagli Stati Uniti; la diversificazione delle forniture con un peso maggiore di Algeria, Mozambico, Qatar e Azerbaijan; l’aumento delle rinnovabili nel mix energetico. Nulla però potrà essere fatto in tempo così breve per compensare l’interruzione della più importante relazione energetica dell’Ue: quella con la Russia. Bruxelles invoca una riduzione del 15 per cento dei consumi di gas per l’autunno, visto che, come ha ammesso l’Alto rappresentante per gli Affari Esteri Josep Borrell, «la dura verità è che stiamo raggiungendo i limiti di quanto gas possiamo acquistare da fonti non russe». Il presidente francese Macron invoca la «sobrietà energetica» e chiede misure di carattere volontario, come utilizzare meno i climatizzatori e spegnere il wi-fi. Berlino ammonisce che, se i consumi di gas non saranno ridotti del 20 per cento, il Governo si vedrà costretto a ricorrere al razionamento. Alcuni termini chiave, quali sobrietà energetica, razionamento, tetti ai prezzi, echeggiano il modo in cui in Europa negli anni Settanta si è reagito alla prima grande crisi energetica del secondo dopoguerra: il cosiddetto “choc petrolifero” del 1973. Ma le differenze con quella fase sono significative.
Le domeniche a piedi o l’accorciamento delle giornate lavorative predisposte mezzo secolo fa furono misure per il risparmio energetico che godevano di un qualche supporto popolare e coincidevano con un momento di grande espansione dei salari e delle condizioni materiali di vita degli europei. Gli anni Settanta furono un decennio di massiccio spostamento, economico, politico e culturale dell’Europa nel senso di un maggiore ruolo dello Stato e di più avanzate tutele sociali. L’austerità veniva invocata dal segretario del Pci Enrico Berlinguer come premessa per un cambiamento strutturale del modo di produzione in senso cooperativo e premiando la qualità dei prodotti sulla loro quantità. La valorizzazione di beni collettivi, come il trasporto pubblico, veniva invocata dal trio dei grandi socialdemocratici europei – il tedesco Brandt, l’austriaco Kreisky e lo svedese Palme – come modo per cambiare il «modello di sviluppo», riducendo il consumismo e sperimentando nuove frontiere tecnologiche. In Germania occidentale e in Gran Bretagna vennero create società statali del petrolio, ma anche in Norvegia e in Canada. Il presidente francese Giscard d’Estaing, liberale, dette avvio ad un programma nucleare statale che avrebbe consentito alla Francia nel giro di un decennio di produrre la grande maggioranza dell’elettricità dalle centrali atomiche. In tutti i Paesi europei (dai due lati della Cortina di ferro) i prezzi dell’energia erano controllati da società statali (in Italia da Eni ed Enel) che monopolizzavano il settore su indirizzo governativo. La combinazione tra “politiche energetiche” e misure di austerità portò a una prima riduzione dell’utilizzo del petrolio e fermarono l’impennata delle prezzi delle bollette per famiglie e imprese. La riduzione dei consumi di petrolio peraltro non fu strutturale. Durò fino alla metà degli anni Ottanta, quando il crollo dei prezzi (il cosiddetto “contro choc petrolifero”) bloccò la tendenza verso un radicale cambiamento del modello energetico europeo.
Il libero mercato europeo dell’energia, progressivamente introdotto dall’inizio dagli anni Novanta nell’Ue dopo una massiccia ondata di privatizzazioni, non ha garantito prezzi bassi del gas e dell’elettricità, visto che questi sono cresciuti costantemente più dell’inflazione dal 2009 e che, già nel 2018, almeno 18 milioni di cittadini europei versavano in una condizione di povertà energetica. Né ha garantito la diversificazione degli approvvigionamenti, visto che la Russia fino al 2021 forniva il 55 per cento del gas, un terzo del petrolio e quasi un terzo del carbone utilizzato dall’Ue. Né, infine, ha favorito la spinta delle fonti rinnovabili: il mix energetico europeo resta incardinato sulle fossili così come lo era nel 1990.
Oggi la guerra in Ucraina rappresenta un potente acceleratore di tutti i problemi legati alla transizione verde, tanto che può essere considerata a tutti gli effetti un conflitto ecologico tra “Europa verde” e “Russia grigia”. La ripresa post-Covid e le ripercussioni delle sanzioni economiche alla Russia, pongono in primo luogo la questione dei prezzi dell’energia e del fatto che essa deve tornare a essere considerata, come ha recentemente scritto perfino l’ex premier britannico Gordon Brown, un «bene comune». Ma è possibile allora che sia unicamente la garanzia di profitto di società produttrici e fornitrici a regolarne l’offerta e i prezzi?
Il risultato del libero mercato è che ogni volta che c’è una crisi lo Stato è costretto ad intervenire a spese della collettività – come è già in atto in Gran Bretagna (decine di società energetiche sono fallite e più di 100mila cittadini rifiutano di pagare le bollette), in Francia (nazionalizzazione di Edf), in Germania (nazionalizzazione di Uniper), e come avverrà presto in Italia – per poi riconsegnare al mercato le suddette attività quando le prospettive di profitto torneranno allettanti. Non sarebbe meglio invece sottrarre produzione e fornitura di energia all’arbitrio del “libero mercato” e incardinarle su un sistema di imprese pubbliche focalizzate sulla giustizia sociale, sul riequilibrio territoriale e sull’innovazione tecnologica?
Un discorso simile vale anche per la decarbonizzazione della produzione energetica, che deve fare i conti con l’insufficienza degli investimenti in rinnovabili nelle economie di mercato (non è un caso che la Cina, grazie agli investimenti pubblici, sia il Paese con maggior produzione di rinnovabili, prima di Ue e Stati Uniti). Dove non arriva il mercato dovrà intervenire necessariamente lo Stato, l’unico che può accontentarsi di tassi di ritorno sugli investimenti nulli (o negativi), e che può garantire un boom degli investimenti in rinnovabili e in infrastrutture ad essere legate a prezzi abbordabili per i cittadini. Piuttosto che parlare di incentivi di una generica “transizione energetica” a misura del capitalismo verde, bisognerebbe parlare piuttosto di “pianificazione ecologica ed energetica”, e seguire i modello del passato in cui gli Stati nazionali hanno garantito la distribuzione di capillare di elettricità a prezzi abbordabili sul territorio nazionale.
C’è bisogno di ridurre anche i consumi di energia nonché la produzione di gas, petrolio e carbone. Su questo fronte è stimolante il pensiero dei teorici della “decrescita” (quest’anno ricorrono i 50 anni del celebre rapporto sui “Limiti della crescita” pubblicato dal Club di Roma), che pongono l’accento sullo squilibrio dei consumi energetici tra Paesi ricchi e Paesi poveri, sul fatto che i servizi pubblici sono più efficienti in termini di impronta materiale, sulla necessità di soddisfare i bisogni piuttosto che i consumi (la mobilità, non la macchina), sulla possibilità di una ridistribuzione delle emissioni in modo che chi viaggia in jet paghi in modo esponenzialmente più elevato di chi gira in bicicletta.
In conclusione la «sobrietà energetica» di Macron e il «risparmio energetico» di von der Leyen rischiano di essere subalterni a una logica di austerità molto diversa da quella degli anni Settanta: una logica che penalizza i più poveri lasciando inalterate le sterminate possibilità dei ricchi di muoversi su macchine per la distruzione ambientale (jet e yacht) e intonsi i profitti di società energetiche private (solo nel secondo trimestre di questo anno le prime cinque maggiori società petrolifere al mondo hanno accumulato profitti netti per 55 miliardi di dollari) che hanno fallito nel garantire diversificazione degli approvvigionamenti, prezzi abbordabili e decarbonizzazione della produzione energetica.