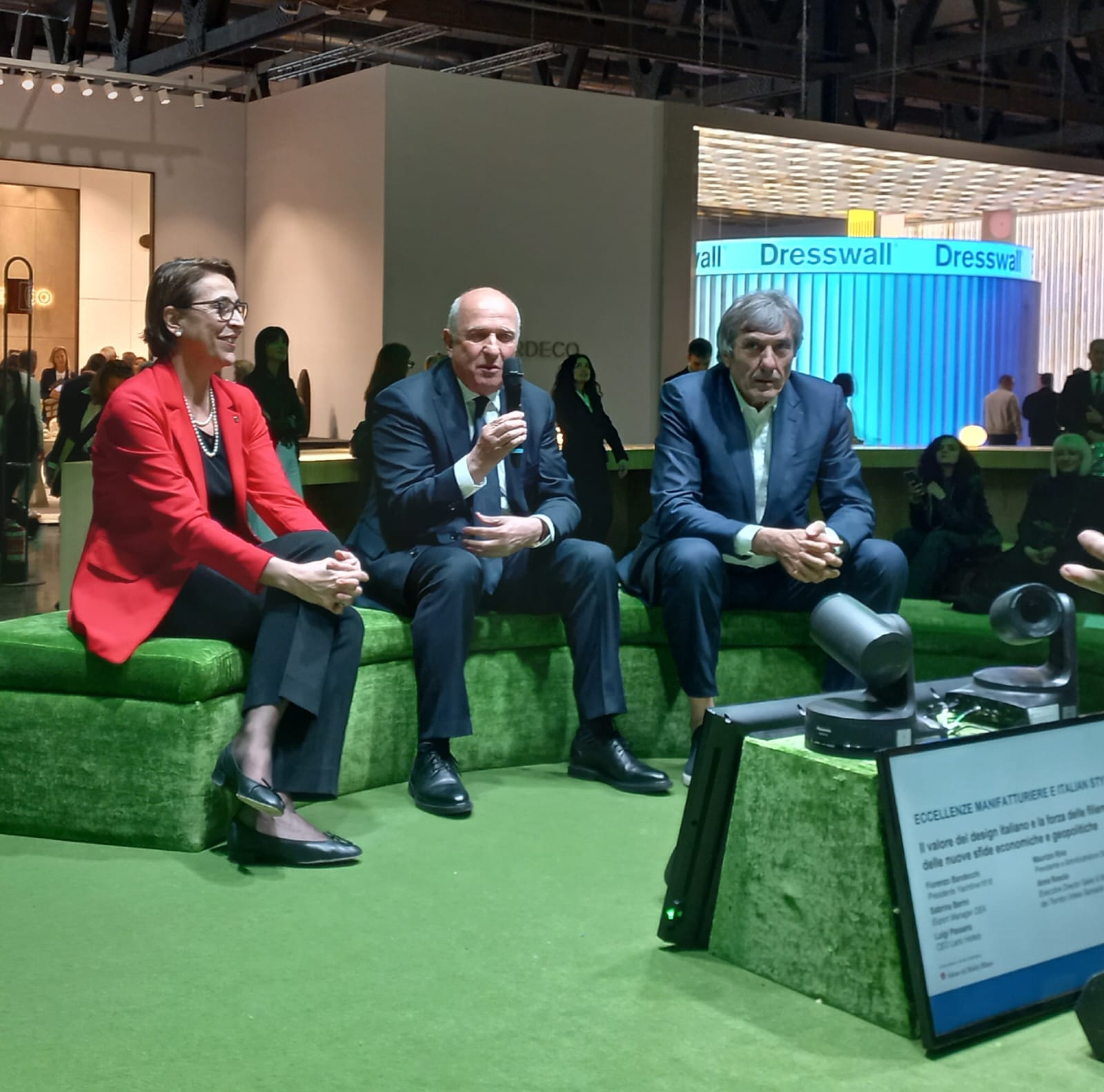“Non sappiamo neanche chi ci ha licenziato”: reportage dalla Marelli di Crevalcore

"I fondi d’investimento non hanno forma fisica, noi parliamo con i manager ma non è un’interlocuzione affidabile, loro fanno quello che la proprietà gli dice di fare, ci sembra una controparte limitata, inconsistente, senza potere contrattuale"
La storia industriale dell’Italia degli ultimi trent’anni è costellata da decine di eventi simbolici quanto laceranti, che dagli anni Novanta ad oggi in maniera lenta e inesorabile hanno eroso il patrimonio produttivo di quella che, molti anni fa, era arrivata ad essere la quinta potenza mondiale, fino a farla scivolare alla nona posizione di oggi.
A partire da quell’incontro più o meno informale rimasto agli annali come “l’incontro del Britannia”, dove nel 1992 la Regina Elisabetta in compagnia di diversi finanzieri delle banche d’affari (Union Jack) ospitò sul suo Royal Yacht Britannia l’alto comando dell’economia di Stato italiano – il presidente di Bankitalia Ciampi, l’allora presidente della commissione Bilancio Andreatta, i vertici delle aziende di Stato di Eni, Iri, Comit, Ina e, non da ultimo, il direttore generale del Tesoro Mario Draghi – il concetto di “politica industriale” sembra scomparso da ogni programma di governo.
La storia economica e produttiva del Paese in quei mesi invertì rotta in maniera radicale. Iniziò da lì il grande ciclo delle privatizzazioni dell’industria statale, invocato come la panacea per tutti i mali. Risale a quel periodo, e a quella precisa fase storica, l’affermarsi di quella dottrina poi divenuta egemone che va sotto il nome di “liberismo” e che da lì agli anni a seguire, darà la stura finale al fenomeno della globalizzazione.
Sono passati molti anni ed è ormai sotto gli occhi di tutti il danno irreparabile che questa politica economica e industriale sta continuando a portare al comparto produttivo dell’Italia, al di là della ingloriosa storia che poi hanno avuto le privatizzazioni degli asset fondamentali del Paese, vedi Alitalia, la consuetudine di svendere, delocalizzare, chiudere, dismettere e liquidare interi comparti sia dell’industria che della Pmi italiana, è diventata un triste rito ricorrente, in cui le vittime sono i lavoratori, gli operai, i tecnici specializzati, spesso protagonisti dell’eccellenza della manifattura italiana, mentre gli artefici sono impalpabili fondi d’investimento, entità sovranazionali senza volto né sostanza umana. Soggetti anonimi rispetto al vecchio capitalismo italiano delle grandi famiglie con il quale almeno si riusciva a sapere con chi prendersela.
Solito copione
Raggiungo al presidio della Fiom Mimmo Lisi, operaio metalmeccanico che mi racconta la vicenda Magneti Marelli, oggi Marelli Holdings, storica azienda e vanto dell’automotive in Italia da quasi cinquant’anni: «A 49 anni faccio parte di quella fascia di mezzo, non so se vedrò mai la pensione».
Lisi lavora in Marelli dal 1996, prima a Bologna e poi a Crevalcore, uno stabilimento di cui è stata dichiarata la chiusura il 19 settembre: «Avevamo 1.400 dipendenti quando ho iniziato, oggi ne siamo rimasti 229».
Nel momento in cui scriviamo, i lavoratori in stato di agitazione sono in attesa dell’incontro con il ministro dello Sviluppo Economico Adolfo Urso il 3 ottobre a Roma: «Abbiamo chiesto la presenza di un rappresentante della proprietà Kkr», il fondo d’investimento proprietario della Magneti Marelli.
«Non sappiamo neanche noi chi sono, i fondi d’investimento non hanno forma fisica, noi parliamo con i manager ma non è un’interlocuzione affidabile, loro fanno quello che la proprietà gli dice di fare, ci sembra una controparte limitata, inconsistente, senza potere contrattuale».
Mimmo, qualche settimana fa, si è visto recapitare un’email dove veniva annunciata la chiusura di uno storico stabilimento dell’automotive a Crevalcore nel bolognese. Combattivo quanto disilluso, ha parole chiare verso l’ipocrisia dell’azienda: «Kkr dice che lo stabilimento è in perdita ormai costante negli ultimi anni per diversi milioni di euro, ma la cosa è saltata fuori all’improvviso. Non ci è mai stato detto nulla delle perdite, ci hanno sempre comunicato che eravamo in equilibrio finanziario, come mai queste informazioni importantissime saltano fuori solo ora? A noi sembrano cose fantasiose, senza riscontro, per giustificare azioni di dismissione del nostro storico stabilimento… Anche in Regione Emilia Romagna, in tavoli ufficiali avevano recentemente confermato che la linea di produzione Euro7, che oggi è finita a Bari, sarebbe stata montata entro fine agosto e che quindi avremmo aumentato la capacità produttiva. A settembre abbiamo chiesto ragione del perché non arrivava la nuova linea, è stato risposto dall’azienda che c’erano problemi di pagamenti con i fornitori e che l’operazione stava slittando di qualche settimana. Il 19 settembre invece è arrivata la dichiarazione di chiusura…».
Sono dinamiche tipiche di quella pratica cancerogena che va sotto il nome di finanziarizzazione dell’economia, dove l’economia reale diventa impalpabile e insignificante, un numero senza nessun riferimento in termini di valore, se non sul solo valore numerico, usato a sua volta come parametro su cui applicare una leva al ribasso o al rialzo, un oggetto su cui speculare, un modo per scommettere se si vince o si perde.
TPI esce in edicola ogni venerdì
In questo sistema è secondaria la competitività, la qualità, la professionalità: sono termini di un capitalismo superato, importa solo chi scommette e quanto scommette perché un’impresa, un comparto produttivo, a volte un intero Paese, possa farcela o invece fallisca. In questo scenario un neo-colonialismo economico finanziario ha di fatto depredato e spesso delocalizzato intere filiere del Made in Italy.
Si pensi al comparto del lusso, dell’alimentare, dell’industria: in tutti questi segmenti è successo che, cadenzate in più volte all’anno, arrivino le vertenze di lavoratori con lettere, pec, a volte sms, di esubero o licenziamento. Ne abbiamo viste tante, da Whirlpool a Gkn, dall’Ilva agli stabilimenti Fiat. Sempre lo stesso copione: dichiarazione di esuberi, diversificazione dell’investimento, delocalizzazione; punti chiave ricorrenti di un’economia canaglia, che senza nessun riguardo oltraggia il tessuto economico-sociale dei territori spesso lasciando deserti produttivi.
Americani
Prendo appunti, mentre Simone Selmi, segretario provinciale della Fiom Cgil Bologna, mi racconta della vicenda Magneti Marelli di Crevalcore, una vicenda che ha visto una improvvisa accelerazione da parte della gestione della fabbrica verso la dismissione di un intero impianto dello storico marchio dell’automotive italiano a favore di un’incomprensibile delocalizzazione della produzione di componenti in plastica allo stabilimento di Bari e di una chiusura della linea produttiva legata alla produzione dell’alluminio per auto.
Sono 229 le famiglie che rischiano di rimanere sul lastrico, proprio in quella Motor Valley emiliana dove il valore aggiunto della professionalità dei lavoratori è indiscutibilmente un asset nazionale, uno stabilimento importante per un’azienda storica fiore all’occhiello del Made in Italy, che da quasi mezzo secolo fornisce l’automotive di tutta Europa.
Per decenni la Magneti Marelli è stata proprietà diretta del gruppo Fiat. Nel 2019, poco prima dell’ingresso di Fiat nel gruppo Stellantis, la fabbrica più importante della componentistica per veicoli in Italia, viene venduta per la ragguardevole cifra di 6,2 miliardi di euro alla giapponese Calsonic Kansei, a sua volta controllata dal fondo d’investimento americano Kkr (Kohlberg Kravis Roberts).
Kkr è un gigante del private equity, con quasi 400 miliardi di dollari di transazioni all’anno e 63 miliardi di dollari di capitalizzazione. Un gigante sovranazionale che con centinaia di miliardi di giro d’affari si muove tra le economie mondiali alla ricerca del maggior profitto per gli azionisti, e che gestisce circa una quarantina tra corporation, aziende, e altri asset strategici in tutto il pianeta.
La prossima grande acquisizione del fondo in Italia potrebbe essere la rete di Tim. Il 15 ottobre, infatti, l’azienda, che ha raccolto l’eredità della vecchia Sip si vedrà recapitare l’offerta di acquisto da parte di Kkr per tutto l’asset scorporato dell’infrastruttura tecnologica di cablaggio nazionale della rete.
L’accavallarsi delle due trattative, entrambe legate a Kkr, è quanto meno una strana coincidenza. Resta il fatto che sia il mondo politico-istituzionale, almeno quello emiliano romagnolo, sia il segretario della Cgil Maurizio Landini, non intendono lasciare campo libero alle decisioni del fondo statunitense.
Giù la maschera
Intanto i lavoratori della Marelli, in attesa dell’incontro con il Governo, annunciano le loro richieste: «Chiediamo il ritiro della procedura di chiusura e la contestuale apertura di un tavolo serio con l’azienda sulla riconversione dello stabilimento. Un progetto di riconversione o re- industrializzazione che sia simbolico per la continuità lavorativa del territorio, abbiamo la produzione avviata fino al 2028 quindi abbiamo il tempo per riconvertire, puntiamo a che Marelli rimanga», mi dice Mimmo. «Noi stiamo mandando un allarme e un segnale al governo per smascherare l’affidabilità di Kkr. Se l’operazione in Marelli è solo di dismissione, la domanda che si deve fare il Governo è: se vendiamo Tim, cosa accadrà?».
Marelli è passata in quattro anni da circa 10mila lavoratori a meno 6mila. Il centro Prototipi, Progettazione e Sviluppo di Bologna ha perso 300 dipendenti negli ultimi tre anni, di cui 135 a giugno di quest’anno. Molti ingegneri specializzati sullo sviluppo e la riconversione in elettrico stanno abbandonando l’azienda, viste le scarse prospettive di sviluppo.
Conclude Mimmo mentre mi saluta per tornare al presidio: «È un segnale d’allarme che stiamo lanciando… A fronte di un impegno su Tim da parte del Governo, si chiedano a Kkr garanzie sul mantenimento dei livelli produttivi, occupazionali, non solo di Tim ma anche di Marelli congiuntamente a un forte investimento verso lo sviluppo di nuove tecnologie che guardino alla riconversione ecologica».
Richieste lungimiranti almeno quanto le politiche che dovrebbero essere messe in atto dai governi e dalla classe imprenditoriale di un Paese che ha la settima manifattura più importante del mondo, la seconda più importante in Europa, e che intende investire ancora sui suoi lavoratori.