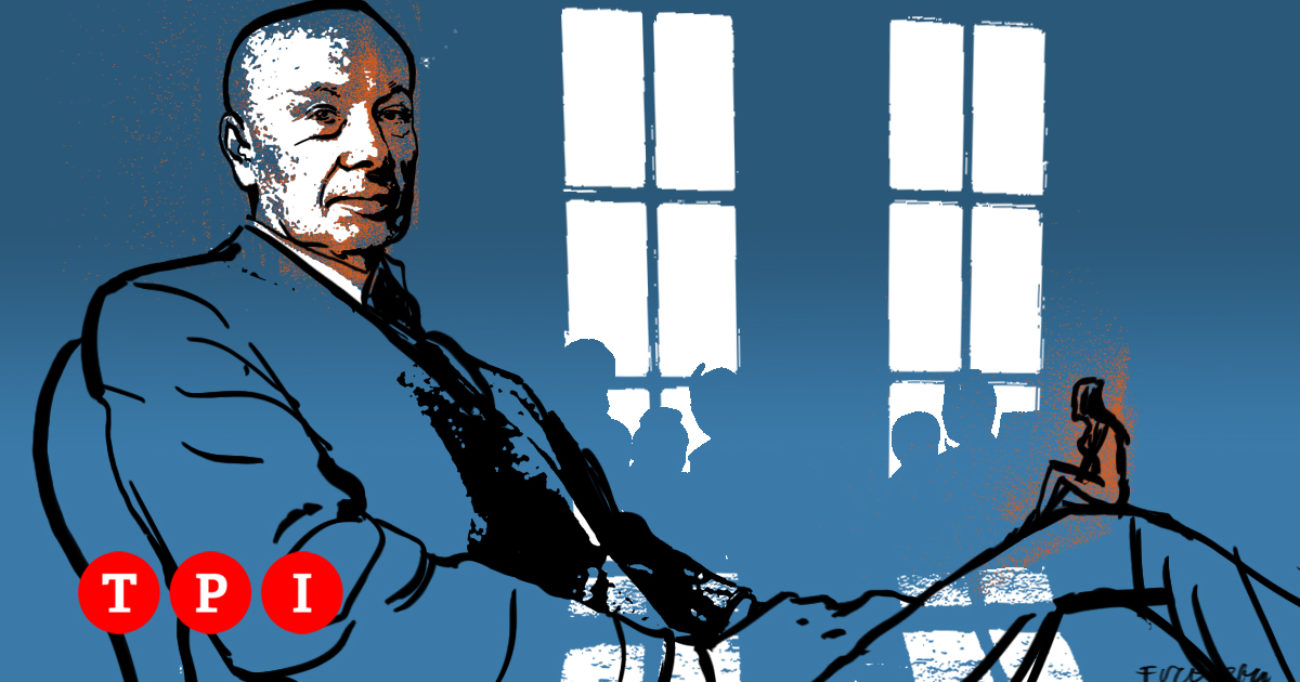Scomodo e controcorrente: “Virilità” è ciò di cui abbiamo bisogno nell’epoca della cancel culture

Quando alla fine degli anni sessanta, per le caotiche strade di New York, la femminista radicale Valerie Solanas vendeva, a venticinque cent per le donne e a cinquanta per gli uomini, le copie del suo SCUM Manifesto, il femminismo era nel pieno della sua battaglia per la emancipazione, spesso radicale, delle donne: e la stessa Solanas, il cui testo corrosivo e swiftiano propugnava, non senza ironia ultravioletta, la eradicazione del genere maschile, finì per aderire un po’ troppo alle sue tesi, tanto da attentare, come noto, nel giugno del 1968 alla vita di Andy Warhol, prendendolo a revolverate.
Ma se la Solanas, sofferente di una grave forma depressiva, aveva dimostrato una qualche barbarica ironia nel proprio scrivere e teorizzare e impugnando quella pistola alla fine si era dimostrata molto più coerente di tante altre teorizzatrici della violenza di cartapesta, decenni dopo la cultura della cancellazione, nella sua declinazione femminista e di sessualità neutra, ha proposto lo stesso genere di servizietto, ma in maniera molto più ipocrita, a programmi accademici, opinione pubblica, riviste, libri.
Una delle prime vittime di questa ondata di isterico politicamente corretto è proprio la ‘virilità’, termine che ormai fa quasi sorridere o inorridire, dipende dai punti di vista: nel migliore dei casi, desueto, antiquato, relitto di un’altra era geologica, nel peggiore manifestazione semantica del tanto aborrito patriarcato.
Mannerbund, fratellanza oscura e medievale, legame di sangue virile che sembra escludere dal panorama sociale la donna. Proprio per questo, il politicamente corretto ha aggredito con inusitata virulenza il concetto stesso di uomo: di uomo, cioè, che sia consapevole del proprio essere maschio e di incarnare una tradizione millenaria non propriamente scarna anche in termini latamente simbolici.
Il revival della mascolinità, ora che alle femministe piace molto abbellire il termine con l’epiteto della tossicità, ha prima imboccato le carsiche vie della controcultura: è così per il testo ‘La via degli uomini’, di Jack Donovan, in Italia edito da Passaggio al Bosco. Ma se Donovan, con il suo intreccio di iper-mascolinità alla Mishima, paganesimo tribale postmoderno, marzialità esibita e cura del corpo, sembra appannaggio di una ristretta cerchia impossibilitata ad incidere sul dibattito pubblico, non lo stesso può dirsi della penna brillante e ficcante di un accademico illustre come Harvey C. Mansfield, il cui ‘Virilità’ esce questi giorni per la sempre coraggiosa Liberilibri.
Mansfield, liberale classico di orientamento conservatore, studioso di Machiavelli, Burke, Tocqueville, è stato a per decenni professore ad Harvard ed è riconosciuto come uno dei massimi esperti di scienza politica a livello mondiale.
‘Virilità’ è un testo scomodo, controcorrente, e che sono certo alcuni cantori del deliquio politicamente corretto troveranno ripugnante nella sua serena razionalità e nel suo aver messo in fila, in maniera sistematica e metodologicamente ineccepibile, il senso della virilità nel passare dei secoli e nella filosofia politica.
Un testo quindi necessario, proprio in questo momento. Per rimettere ordine e riportare frammenti di luce nel gorgo di tenebra in cui ci ha calati la psicosi politicamente corretta.
Ad onore di Mansfield va anche detto che il volume è del 2006, originariamente edito dalla Yale University Press, periodo quello in cui il politicamente corretto, già manifestato nella sua morfologia deprimente, non aveva ancora invaso, colonizzato e inquinato il discorso pubblico e i programmi accademici nella maniera totalizzante e brutale che possiamo riscontrare oggi: le statue erano ancora al loro posto, l’autrice di Harry Potter non ancora definita una ‘transfobica tossica’, Shakespeare non ancora giudicato un miserabile maschilista suprematista bianco, e se già certamente si poteva incorrere in qualche problema dimostrando scarsa consapevolezza dei nuovi codici semantici le conseguenze non erano ancora da morte civile, come purtroppo sta avvenendo nel tempo presente.
Proprio per questo, ora invece che la cancel culture sembra aver devastato l’orizzonte, le università, la mente degli intellettuali, sempre più timorosi di esprimere le loro opinioni, il testo di Mansfield si dimostra per la sua consistenza preziosa e genuinamente libera.
TPI esce in edicola ogni venerdì
L’autore passa in rassegna la grottesca fenomenologia concettuale e filosofica della società sessualmente neutra, le responsabilità di un certo femminismo radicale, la battaglia per e sul linguaggio: la trasformazione della lingua, la cancellazione di parole ormai reiette e ritenute foriere di reiterare l’oppressione patriarcale, o razziale, finiscono per innestare un cortocircuito di sempre crescente povertà intellettiva. Reclamando una impossibile e innaturale eguaglianza, come se la biologia non conoscesse differenza tra uomo e donna, questo femminismo ha tradito la propria originaria missione di riconoscimento di pari diritti, divenendo una chimera malata di iper-identitarizzazione, il cui esito ultimo è ovviamente la ghettizzazione.
E se un tempo si poteva sorridere delle tesi della femminista radicale Andrea Dworkin la quale per identificare il maschio utilizzava nelle proprie opere la locuzione ‘il nazista’ e per le donne desiderose di una relazione eterosessuale ‘le collaborazioniste’, identificando nel rapporto sessuale etero una violenza ontologica, una conquista e una sottomissione, oggi si può pensare che la Dworkin passerebbe quasi per una moderata.
Il secondo, bellissimo, capitolo di ‘Virilità’ incarna in certa misura la sostanza stessa del volume. La virilità come stereotipo.
Mansfield ricorda come Lippmann e Allport abbiano sempre sostenuto che nel fondo di uno stereotipo alberghi un certo quoziente, per quanto minimale, di verità: d’altronde lo stesso potremmo dire della banalità, la quale comunque finisce con il replicare una porzione della realtà, in una schematica e popolana semplicità.
Con il tempo al contrario si è ritenuto che lo stereotipo fosse, o meglio dovesse essere, del tutto destituito di fondamento e che esso fosse solo un dispositivo di reiterazione della discriminazione sociale, o sessuale, o razziale. E proprio così facendo si cade preda di una nuova forma di scienza sociale decostruzionista, dalla metodologia incerta, infarcita di ideologia, che inizia a minare le fondamenta della nostra società occidentale, senza però premurarsi, dopo aver innervato elementi destruens, di fornire una chiave di ricostruzione di un modello alternativo.
Mansfield, in realtà, ne ha anche per l’applicazione alla teoria sociale del darwinismo; la virilità, come insieme di caratterizzazioni ascrivibili al comportamento e all’essenza dell’uomo, mal si concilia con la visione monca e distorta che il darwinismo finisce con il rimandare.
Certo, la violenza è un dato a corredo della possibilità di sopravvivenza e di perpetuazione della specie, esattamente come l’adattamento, ma come rileva Mansfield l’uomo virile non è interessato alla perpetuazione di un dato corredo genetico, come avviene al contrario nel mondo animale: l’uomo virile protegge sé stesso e i suoi cari e al massimo un insieme sociale in cui si riconosce, l’istituzione, la nazione, la patria.
Si tratta di una analisi accurata e raffinata del darwinismo, funzionale a sgomberare il campo dalla principale accusa delle femministe e del politicamente corretto all’uomo: se l’uomo rimane virile, quindi non neutro come ambirebbe lo sdilinquimento attuale, sarà propenso e incline all’esercizio della violenza. Contro i suoi simili e contro le donne. Per questo, la lezione di Mansfield si dimostra assai preziosa, proprio per scardinare un pregiudizio del genere.
Il libro, in generale, è una ampia disamina di filosofia con non episodiche incursioni nel campo della cultura popolare, ampiamente godibile per estro, brio e stile di scrittura: ed è così che a fronte di Socrate, Platone, Hobbes, Spinoza, Mill, troviamo anche John Wayne, Superman ed esempi di virilità presi dalla letteratura, in una parabola oscillante da Robert Louis Stevenson a H. Rider Haggard.
Di ogni autore, Mansfield verifica il concetto stesso formulato ed utilizzato di virilità, constatando amaramente come lo stesso sia stato strumentalmente inquinato da una certa vulgata femminista, a cui l’autore dedica un intero capitolo, significativamente titolato ‘nichilsmo femminile’.
C’è un altro aspetto che mi preme sottolineare: la stretta connessione tra la virilità e la libertà. Mansfield fa infatti giustizia di un luogo comune che vedrebbe nel diffondersi dei principi del liberalismo la causa primaria dell’arretramento, fino quasi alla scomparsa, della virilità dall’orizzonte delle idee e dei concetti nella società d’occidente.
Nel capitolo ‘il liberale virile’, lo studioso ripercorre alcuni dei principali equivoci concettuali che hanno punteggiato lo sviluppo del pensiero filosofico: ed è così che ci troviamo al cospetto di un Hobbes che piega la virilità a funzione della sovranità per la costruzione della compagine statale, capace di porre fine all’arbitrio della guerra di tutti contro tutti.
Il Leviatano di Hobbes, simbolicamente, incarna le fattezze di un uomo, finendo per sublimare le virtù virili dei cittadini che si consociano in un patto di reciproca rinuncia: in questa prospettiva pertanto l’unica virilità accettabile diviene quella collettiva, impersonata dallo Stato. E proprio in questa medesima prospettiva, ma molto prima, già Platone aveva edulcorato il senso profondo della virilità relegandola a funzione di sorveglianza, morale ed effettiva, della città, facendo degli uomini virili i filosofi custodi spogliati della istintiva e ferina virilità.
Qui Mansfield si confronta con Spinoza e John Locke, il primo incapace di applicare convincentemente i principi di libertà senza cadere in stereotipi di genere e finendo col postulare i diritti quasi esclusivamente in capo ai soli uomini, il secondo invece in grado di traslare una parte della virilità presente nello stato di natura in seno al consesso sociale organizzato, rendendola viva e presente in latenza, sorta di motore invisibile.
L’autore chiude quindi il capitolo focalizzandosi su John Stuart Mill e su Edmund Burke, facendo giustizia di tutta quella oleografia che della virilità ha preteso di fare canone belluino, selvaggio, fisiologicamente votato alla guerra e al conflitto.
Perché l’uomo de-virilizzato, che tanto sembra piacere a femminismo radicale, politicamente corretto e decostruzionismo postmodernista, non è destinato alla quiete e alla pace, ma a un senso immane di frustrazione e ad accumulare un carsico, ctonio fiume di violenza inespressa che col passare del tempo rischia di deflagrare, travolgendo tutto.