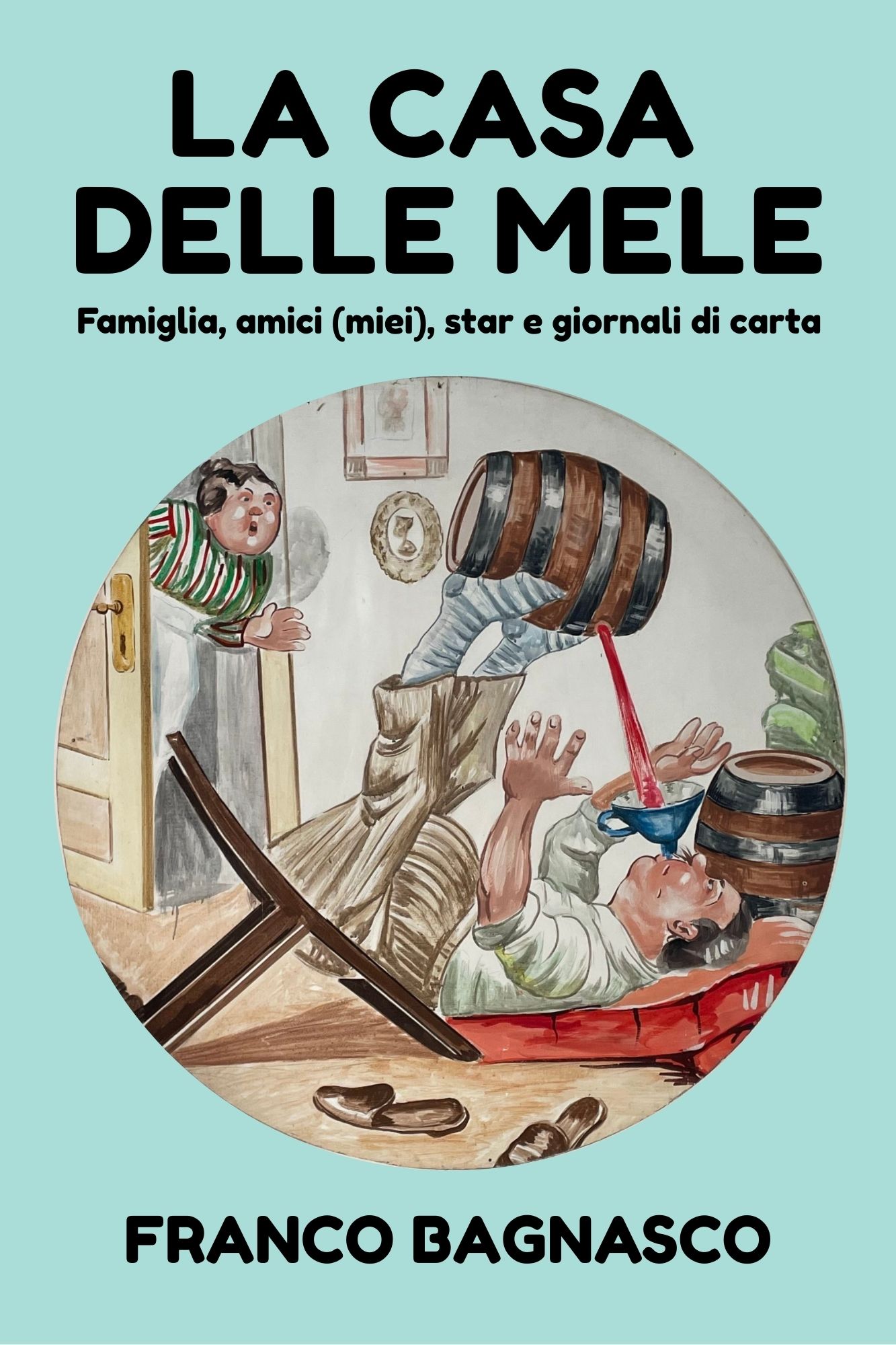Elena Ferrante è Anita Raja. Ma i media fanno finta di niente e assecondano il gioco della casa editrice

Dal 6 febbraio scorso è partita la serie televisiva Storia di chi fugge e di chi resta, tratta dal terzo romanzo della tetralogia napoletana L’amica geniale, dell’autrice che si firma come Elena Ferrante. Sono passati quasi sei anni dalla pubblicazione dell’inchiesta giornalistica in cui, dopo aver seguito il flusso degli introiti di quei bestseller, ho rivelato che dietro a quel nom de plume si nasconde Anita Raja, traduttrice di Edizioni e/o (l’editore della famosa tetralogia) e moglie dello scrittore Domenico Starnone. Eppure la cosa sembra ancora sfuggire a (quasi) tutti. In questi sei anni la scrittrice non ha smesso di scrivere, né di nascondersi dietro quel nome, ormai famoso in tutto il mondo. Non ha smesso neppure di fare cucù ai mass media da dietro il proprio pseudonimo, continuando a tirare il sasso (con dichiarazioni o interviste sui temi più vari) e nascondere la mano (dietro la palizzata della posta elettronica). Un gioco di stimolo alla visibilità mediatica più che legittimo in una società come la nostra, in cui si esiste solo se si appare; ma in aperta contraddizione con l’intenzione letteraria dichiarata: quella di focalizzare l’attenzione dei lettori su opere e testi anziché sul profilo biografico dell’autrice.
Gioco di specchi
In questi anni, gli stessi media, nazionali e internazionali, hanno continuato a stare al gioco, e quindi a parlare di lei come se la sua identità fosse ancora un mistero. Spesso e volentieri hanno anche disconosciuto la femminilità della sua voce, insinuando che dietro allo pseudonimo si nasconda Starnone. La qual cosa è un oltraggio sia alla Raja, evidentemente non ritenuta all’altezza delle opere in questione, sia a Starnone che, avendo già pubblicato libri con il proprio nome, si sarebbe potuto inventare l’escamotage del nom de plume solo a fini di becero marketing. Questo gioco degli specchi continua però ad avere anche un costo “letterario”. A pagarlo è la nostra capacità di riflettere sulle opere della Ferrante, collocarle nel contesto a cui appartengono e arrivare a una comprensione o rielaborazione critica compiuta della scrittrice italiana vivente più famosa al mondo. In particolare, continuando a nascondere la sua identità, si continua a ignorare un elemento chiave delle sue opere, e cioè il loro ancoramento all’identità ebraica dell’autrice. Il mondo intero rimane invece fossilizzato sulla sua napoletanità (altrettanto presente e vera, ma non esclusiva). Ma, prima di approfondire questo punto, ritengo opportuno affrontare tre questioni. Ha una scrittrice il diritto all’anonimato se questo è ciò che vuole? È legittimo per un giornalista svelare il mistero dell’identità che si cela dietro lo pseudonimo letterario più famoso al mondo? Conoscere identità e background di un’autrice di bestseller internazionali contribuisce a una più approfondita e ragionata conoscenza delle sue opere?
Privacy violata
Dopo che il Sole 24 Ore, New York Review of Books, Frankfurter Allgemeine Zeitung e Mediapart hanno simultaneamente pubblicato la mia inchiesta in italiano, inglese, tedesco e francese, nell’ottobre del 2016, da ogni parte del mondo sono partiti attacchi che si potrebbero definire “di genere”. Da maschio sono stato infatti accusato di aver «violato» l’espresso desiderio di anonimato di una donna. Era un’asserzione che poteva venire solo da chi ignora – o sceglie di ignorare – la differenza tra letteratura e giornalismo investigativo. Se nei romanzi si inizia infatti con un soggetto/protagonista che si ha ben chiaro in mente, nel giornalismo investigativo si inizia con una domanda alla quale si cerca risposta. Poiché da anni circolavano sospetti proprio su Starnone, quando ho iniziato il mio lavoro investigativo non avevo alcuna certezza che Elena Ferrante fosse effettivamente una donna. Non poteva dunque esserci da parte mia alcuna profanazione di natura sessista. Legittimo invece domandarsi se una persona che pubblica libri ricorrendo a un nom de plume per motivi che possono essere i più svariati – uomo o donna che sia – ha il diritto di mantenere sconosciuta la propria identità. Tra i fan della Ferrante, molti mi hanno accusato di aver violato questo diritto. A questa critica rispondo che a violare il desiderio di privacy di Elena Ferrante non sono stato io, bensì i suoi editori, Sandra Ozzola e Alessandro Ferri, e la stessa autrice.
Non mi riferisco alla grancassa mediatica alimentata da Edizioni e/o a suon di interviste da anni concesse da un’autrice che diceva di volersi nascondere. No, mi riferisco a come Sandra Ozzola aveva risposto al desiderio di conoscere «la persona dietro l’opera» coltivato da milioni di lettori sparsi per il mondo. Dopo aver riconosciuto come «sano» quel desiderio, in una “lettera aperta” all’autrice, Ozzola aveva infatti sostenuto che la curiosità dei suoi lettori «meriterebbe forse una risposta più generale. Non solo per placare quanti si perdono nelle ipotesi più arzigogolate sulla tua reale identità, ma anche per un sano desiderio dei tuoi lettori di conoscerti meglio». Questo invito era stato accolto dalla scrittrice che, quasi venti anni fa (nel 2003), aveva scritto e pubblicato in Italia La Frantumaglia, un saggio sedicente autobiografico dal quale i suoi fan avevano appreso che la scrittrice aveva tre sorelle e che sua madre era una sarta napoletana incline a esprimersi «nel suo dialetto». Tredici anni dopo, nell’autunno del 2016, sempre per rispondere a quel «sano» desiderio di conoscerla «meglio», espresso questa volta dai lettori anglofoni, Edizioni e/o si apprestava a pubblicare lo stesso testo in inglese. È stato solo allora, e cioè quando ho scoperto che gli editori stavano per cavalcare l’ondata di interesse per la scrittrice napoletana, lanciando negli Stati Uniti la traduzione di quell’«autoritratto letterario», che ho deciso di usare le tecniche di giornalismo investigativo da me praticate su temi di tutt’altra natura per capire chi si nascondeva dietro il nome di Elena Ferrante.
C’era un solo modo per farlo senza timore di essere smentiti: appurare chi aveva beneficiato del successo commerciale dei libri. Seguendo i flussi di cassa della casa editrice della tetralogia, ho così scoperto che da quando il libro ha cominciato ad avere successo commerciale, le retribuzioni ad Anita Raja sono letteralmente esplose. Da corrispettivi relativamente contenuti attribuibili alle sue traduzioni dal tedesco, ha infatti cominciato a percepire compensi sempre più importanti e spiegabili solo se frutto delle royalties sui libri della Ferrante. Ma a quel punto non si trattava più di svelare un mistero, bensì di smantellare una bugia. Nessuno dei dettagli personali rivelati in La Frantumaglia corrispondeva infatti alla vita di Anita Raja.
Come la madre di Elsa Morante, scrittrice che aveva influenzato la scelta del nom de plume, la sua era infatti un’insegnante, non una sarta. E non era affatto napoletana ma ebrea. Anche la madre di Morante era ebrea, ma era nata a Modena mentre la madre di Raja era nata a Worms, in Germania, da una famiglia emigrata dalla Polonia e parlava italiano con un evidente accento teutonico. In più, Raja non ha sorelle, solo un fratello minore, e a Napoli è nata ma ha trascorso solo i primi tre anni di vita. In realtà è cresciuta e ha sempre vissuto a Roma.
I due comproprietari di Edizioni e/o, Sandra Ozzola e Sandro Ferri, hanno respinto qualsiasi confronto, e in una breve conversazione telefonica Ferri è stato perentorio: «Noi siamo abbastanza seccati da questa violazione della privacy, nostra e di Ferrante, e se l’articolo è in quella direzione, le dico che mi dispiace ma noi non possiamo collaborare». Non sono mai riuscito a reperire il cellulare di Raja, ma ho lasciato messaggi a quello di suo fratello e quello di Starnone elencando le evidenze finanziarie da me trovate per portare la scrittrice a riconoscere la propria identità. Ma lei non ha mai risposto né accettato un contraddittorio. È stata questa reticenza che mi ha “costretto” a scrivere dell’improvviso e rilevantissimo salto di entrate e patrimonio registrato dalla Raja in seguito al successo dei libri della Ferrante. Cosa che ho fatto con il massimo del rispetto possibile, e cioè senza menzionare cifre di compensi o indirizzi di proprietà.
Ma più che l’identità dell’autrice, a me interessava trovare una chiave di lettura biografico-culturale ai suoi romanzi. Insomma, nelle mie intenzioni, lo ”smascheramento” doveva esser il mezzo, non il fine. Tant’è che ho dedicato molto più tempo all’analisi della complessa storia familiare di Anita Raja che alla caccia dei suoi soldi. Ho trascorso mesi a esplorare archivi e contattare testimoni sparsi in quattro Paesi – Italia, Svizzera, Regno Unito e Israele – allo scopo di ricostruire in dettaglio le vicende di Goldi Petzenbaum, madre di Anita Raja. Ho così portato alla luce pogrom in Polonia, persecuzioni naziste in Germania, soprusi razziali in Italia e la grande bestia dell’Olocausto che aveva divorato i bisnonni e una dozzina di altri membri della famiglia.
Nata nel 1927 a Worms da genitori ebrei fuggiti dalla Polonia, nel 1937 Goldi aveva lasciato la Germania con i genitori, trasferendosi a Milano. Il 18 settembre dell’anno successivo, dal balcone del municipio di Trieste, Mussolini aveva annunciato i primi «provvedimenti per la difesa della razza» che avevano avviato le persecuzioni fasciste contro gli ebrei, in particolare stranieri, rendendo l’esistenza della famiglia di Goldi estremamente precaria. Il 15 giugno del 1940, cinque giorni dopo l’entrata in guerra dell’Italia, il ministero dell’Interno aveva poi emanato un ordine di arresto per tutti gli ebrei stranieri, che aveva in seguito causato la deportazione della famiglia Petzenbaum nel più grande campo d’internamento per ebrei stranieri d’Italia, quello di Ferramonti, in provincia di Cosenza. Lì il nonno della scrittrice, Abraham, detto Wrumek, aveva ricevuto cartoline dal padre, all’epoca chiuso con la madre nel ghetto di Cracovia, da sua sorella Gusta, prigioniera nel ghetto di Tarnow e, dopo che questa era stata trasferita in un campo di sterminio, anche dai suoi figli, Sarah e Joshua. Nessuna di queste persone è sfuggita all’Olocausto. Per Goldi la tragedia non si era conclusa con la liberazione del campo di Ferramonti da parte degli Alleati che stavano risalendo l’Italia dal sud. Prima che questa avvenisse, Wrumek l’aveva fatta fuggire a Milano, da un’amica di famiglia, e dopo la nascita della Repubblica di Salò Goldi era stata costretta a rifugiarsi in Svizzera, dove era rimasta fino all’estate del 1945, quando era finalmente riuscita a ricongiungersi con i genitori, andati a vivere a Napoli.
Scoprendo che la madre della scrittrice era sopravvissuta non solo a due esili ma anche a tre delle più grandi tragedie del ventesimo secolo – nazismo, fascismo e Olocausto – emergendo non come vittima bensì come donna forte e indipendente, avevo pensato di aver trovato una chiave di lettura tanto inedita quanto pregnante. Che cosa è la tetralogia napoletana di Elena Ferrante se non una storia di sopravvivenza femminile, con Lenù e Lina che riescono a far fronte alle grandi sfide economiche, sociali e culturali di un mondo a loro avverso? Queste rivelazioni avrebbero permesso a critici (e lettori) di interpretare la letteratura di Ferrante in modo del tutto nuovo. E sicuramente andavano ben oltre quella che Michel Foucault aveva definito «la morale da stato civile che regna sui nostri documenti». La drammatica storia di Goldi Petzenbaum era presentata in uno dei due lunghi articoli da me pubblicati quell’ottobre del 2016, ma il putiferio social-mediatico creato dall’altro articolo – quello che documentava la vera identità dell’autrice – l’ha interamente sopraffatta. E quella che io ritenevo fosse la vera “notizia” della mia inchiesta, e cioè che il milieu culturale in cui era cresciuta l’autrice era tanto ebraico quanto napoletano, è stata dai più ignorata. E lo è tuttora.
Elena Ferrante rimane ancora oggi nota solo come napoletana, e non come anche ebrea, quale invece è. Lo dico non tanto perché la trasmissione della ebraicità è “matrilineare”, quanto perché l’ambiente culturale in cui è cresciuta è stato napoletano da parte di padre – il magistrato Renato Raja – ed ebraico da parte di madre (e dei nonni materni, che lei andava spessissimo a visitare a Napoli). Più che l’appartenenza a una minoranza religiosa, nel caso di Ferrante/Raja ritengo conti l’imprinting culturale. E quell’imprinting è a mio giudizio presente nelle opere della scrittrice attraverso uno dei tratti caratteristici del “canone letterario ebraico”: il dolore della lacerazione.
Chiudo con un parallelo forse azzardato o forse no. Neppure nei romanzi che Ettore Schmitz, figlio della borghesia ebraica triestina, ha pubblicato con lo pseudonimo di Italo Svevo, emerge l’ebraicità dell’autore. Per il critico Giacomo Debenedetti era qualcosa che l’autore aveva scelto di tener nascosto, forse addirittura frutto di una volontà di rimozione. Ma secondo un altro critico, Luca De Angelis, la segretezza e il riserbo sono elementi distintivi di tutti gli autori ebrei, da Svevo a Bassani, in quanto frutto di un’inclinazione esistenziale all’intimità basata su secoli di oppressione e segregazione. De Angelis fa addirittura il paragone con un aspetto del marranismo, e cioè il fenomeno di quegli ebrei che, per sopravvivere alle persecuzioni dell’Inquisizione, si erano convertiti ma non del tutto, mantenendo viva la propria ebraicità nel segreto delle loro case. Insomma, quel “gusto del segreto”, per usare un termine associato al filosofo ebreo francese Jacques Derrida, sarebbe una sorta di inclinazione naturale dell’anima ebraica dovuta alla sua condizione esistenziale. Mi domando se, nel profondo, sia questo a spingere Anita Raja a rimanere nascosta dietro al suo nom de plume. Se lo fosse, vedrei la sua scelta sotto tutt’altra luce. E la capirei di più.