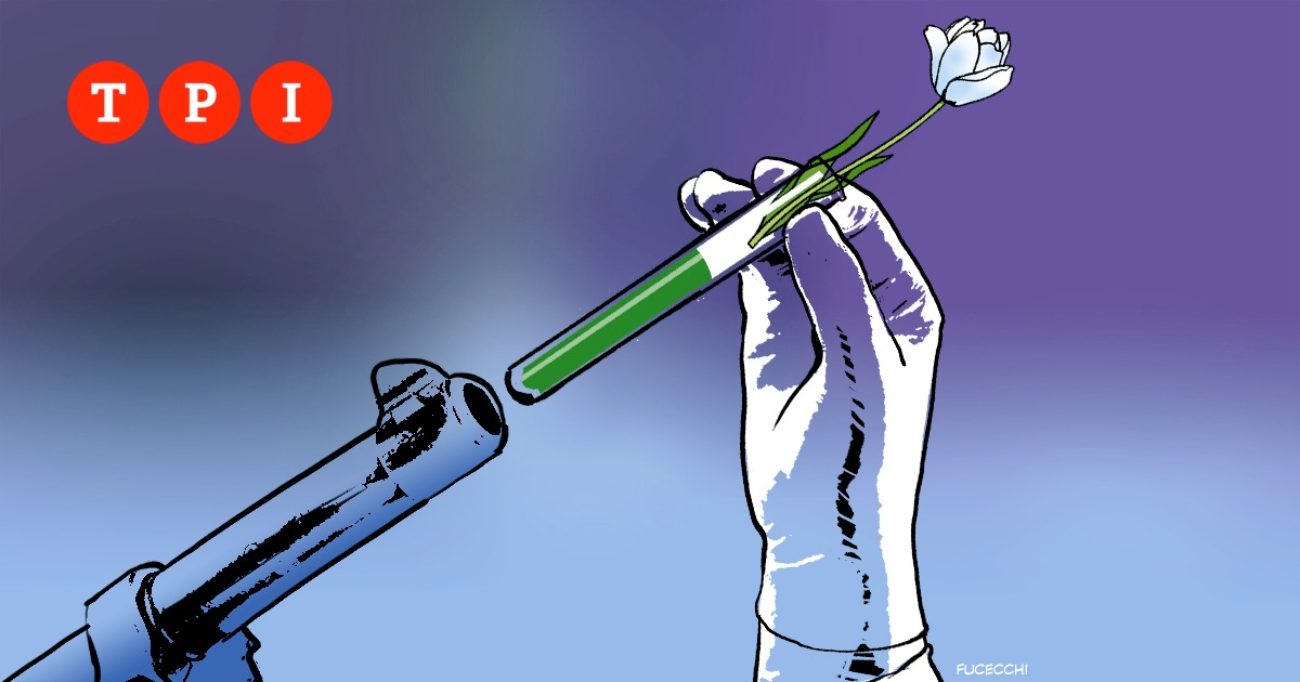La spesa militare aumenta, ma per la ricerca solo le briciole
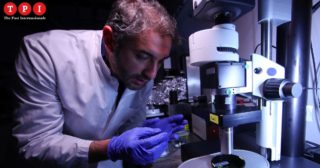
I soldi per le armi ci sono (e subito) ma per l’università non si trovano da anni: così stiamo compromettendo il nostro futuro. Sul nuovo numero di TPI, in edicola da venerdì 25 marzo, le voci di chi lavora nel mondo della ricerca
«Fino a pochi giorni fa in Parlamento si discuteva di misure sulla ricerca, poi invece c’è stata una decisione precisa: tutto ciò che non riguardava spese militari è stato chiuso. I parlamentari ce lo hanno comunicato in modo laconico: “non c’è spazio”. Il giorno dopo è uscito il provvedimento sull’aumento della spesa militare». A raccontarlo a TPI è Claudio Argentini, del coordinamento dell’Unione sindacale di base (Usb) per la Ricerca, a pochi giorni dall’approvazione da parte della Camera dell’ordine del giorno collegato al cosiddetto “decreto Ucraina”, con cui il governo si è impegnato ad alzare la spesa miliare italiana fino al 2 per cento del Pil (dagli attuali 25 miliardi di euro annui a circa 38 miliardi).
La ricerca non è certo l’unico ambito di spesa pubblica che, al contrario della Difesa, si trova a fare i conti con i mancati investimenti, ma è uno dei settori più danneggiati dall’inizio del periodo dell’austerity in poi. Dal 2008 al 2017, secondo l’Associazione delle università europee, l’Italia ha registrato un taglio del 17,3 per cento dei finanziamenti pubblici per l’istruzione terziaria. Anche se negli ultimi anni la tendenza mostra un progressivo aumento delle risorse, la spesa per Ricerca e Sviluppo (R&S) in rapporto al Pil nel nostro Paese è pari all’1,4 per cento, ben inferiore rispetto al 2,07 per cento della media europea, come ha evidenziato una ricerca della Fondazione Fadoi e Fondazione Roche presentata lo scorso novembre.
«Mi ha colpito che l’aumento delle spese militari sia stato votato da un giorno all’altro, senza alcun dibattito pubblico», sottolinea a TPI Francesco Sylos Labini, direttore di ricerca al Cref – Centro ricerche Enrico Fermi e fondatore del sito Return on Academic Research (Roars) dedicato alla discussione di temi della politica dell’università e della ricerca. «Tutti coloro che si schierano sempre contro l’aumento della spesa pubblica, per qualsiasi motivo, stavolta non hanno detto una singola parola. Ogni investimento per l’università negli ultimi 10 anni era visto come acqua versata in un secchio bucato. Invece la spesa militare chi la monitora? Chi la valuta? Niente, di questo non si discute».
«L’aggressione della Russia all’Ucraina pone molti dilemmi anche a chi, come me, è stato sempre a favore della riduzione delle spese militari e il controllo degli armamenti», commenta Daniele Archibugi, dirigente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr). «Eppure, non si può ignorare che molte delle armi prodotte dall’Occidente, Italia inclusa, sono oggi usate da tutte e due le parti. Il che ci fa vedere che, piuttosto che aumentare la spesa militare, sarebbe più efficace ridurre drasticamente la produzione di armamenti e controllare il loro commercio».
«L’investimento sull’istruzione e la ricerca è proprio il contraltare delle spese militari», sostiene Francesca Farruggia, segretario generale dell’Istituto di Ricerche Internazionali Archivio Disarmo (Iriad) e ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche dell’Università La Sapienza di Roma. «Papa Francesco, nel suo messaggio per la LV Giornata mondiale della pace, alcuni mesi fa invitava i responsabili di governo a invertire il rapporto tra gli investimenti pubblici nell’educazione e i fondi destinati agli armamenti. Su questo tema è stato un precursore». Farruggia ricorda che nell’ultima classifica Eurostat l’Italia è l’ultimo di 31 Paesi per percentuale di spesa pubblica allocata per istruzione. «Se lo confrontiamo con la spesa per la Difesa, in cui l’Italia si colloca all’undicesimo posto nella classifica mondiale – e al quarto in Europa – questo diventa un dato allarmante. Ma a impensierirmi è soprattutto il dato Ocse sull’indice di analfabetismo funzionale del nostro Paese, che si attesta al livello 3 per il 46,3 per cento della popolazione tra i 16 e i 65 anni, mentre il 21 per cento non supera il livello 1, che è quello in forma grave. In questo momento storico ciò è particolarmente pericoloso, perché per essere un Paese pienamente democratico ogni persona dovrebbe essere in grado di valutare in modo idoneo le informazioni».
Per il ricercatore Fabrizio Stocchi, membro della Federazione Lavoratori della Conoscenza (Flc) Cgil Nazionale, se già in tempi normali è giusto fare un ragionamento sul rapporto tra spese militari e spese per la ricerca, in questo momento la riflessione si pone in maniera ancora più urgente. «Oggi il punto non sono le spese ordinarie che il Paese versa sul settore militare, che sono una questione di visione strategica, ma l’impegno straordinario che è stato stabilito. E questo per noi è una scelta politica». Per questo i lavoratori di Flc Cgil hanno organizzato uno sciopero del settore per venerdì 25 marzo, insieme al movimento Fridays for Future. «Gran parte del ragionamento fatto sul tema dell’energia dopo lo scoppio del conflitto sembra essere stato sospeso: dal nucleare agli armamenti, sembra di essere precipitati negli anni Cinquanta. Invece c’è un orizzonte strategico che l’Europa deve ritrovare, a partire dallo sviluppo green». Per quanto riguarda i finanziamenti alla ricerca, Stocchi evidenzia che «in parte ci sono, ma secondo noi sono ancora insufficienti rispetto agli obiettivi di questa fase, che è quella di costruire un’infrastruttura che consenta al Paese un salto in avanti per il suo sviluppo».
«Mi occupo di sociologia del lavoro e questioni di genere, quindi ho studiato il tema del sottofinanziamento all’università anche per le mie ricerche», racconta a TPI Annalisa Dordoni, assegnista di ricerca post-dottorato presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. «Dal 2007-2008 c’è stato un drastico calo dei finanziamenti all’istruzione in generale, ma in particolare all’università, che è andato avanti fino ad ora. Nell’ultimo periodo c’è stata una ripresa, ma soprattutto tramite finanziamenti straordinari, come il Pnrr, che comunque non sono paragonabili ai finanziamenti ordinari di cui l’università e la ricerca necessitano per andare avanti. Ciò ha delle conseguenze dal punto di vista delle asimmetrie di genere in accademia, ma anche a livello generazionale, territoriale e di classe: chi non ha le risorse economiche personali o familiari fa fatica ad andare incontro a contratti precari, che spesso hanno dei buchi da un anno all’altro». Le conseguenze degli scarsi finanziamenti, spiega Dordoni, non sono solo per chi lavora in ambiente accademico, ma anche per la ricerca in genere, che è un settore strategico per il Paese e per gli stessi studenti universitari, che si trovano in aule sovraffollate e possono contare su meno risorse spese per ciascuno di loro da parte dell’ateneo. «È incredibile pensare che da un giorno all’altro si riescano a tirare fuori miliardi per aumentare le spese militari, e allo stesso tempo un settore strategico come quello dell’università possa contare su finanziamenti scarsi, anche a confronto degli altri Paesi Ocse».
«Negli ultimi 5 anni eravamo riusciti a recuperare per l’80-90 per cento i tagli per la ricerca effettuati dal 2006 al 2017», spiega Claudio Argentini dell’Usb, sottolineando che il sindacato si avvia verso una mobilitazione. «Ma chiaramente questo era il recupero di una situazione non florida, permetteva appena agli enti di sopravvivere. Un anno fa, col ruolo che la ricerca stava avendo su due aspetti fondamentali, il clima e il Covid, vedevamo una possibilità di ripresa concreta sugli investimenti. Invece poi non è stato così. Anche la distribuzione del Pnrr per noi è stata deludente, perché poco andrà alla ricerca di base, e quasi tutto all’impresa, inclusa quella militare. Questa secondo noi potrebbe essere l’ultima pietra messa dal governo sopra la ricerca».Continua a leggere sul settimanale The Post Internazionale-TPI: clicca qui.