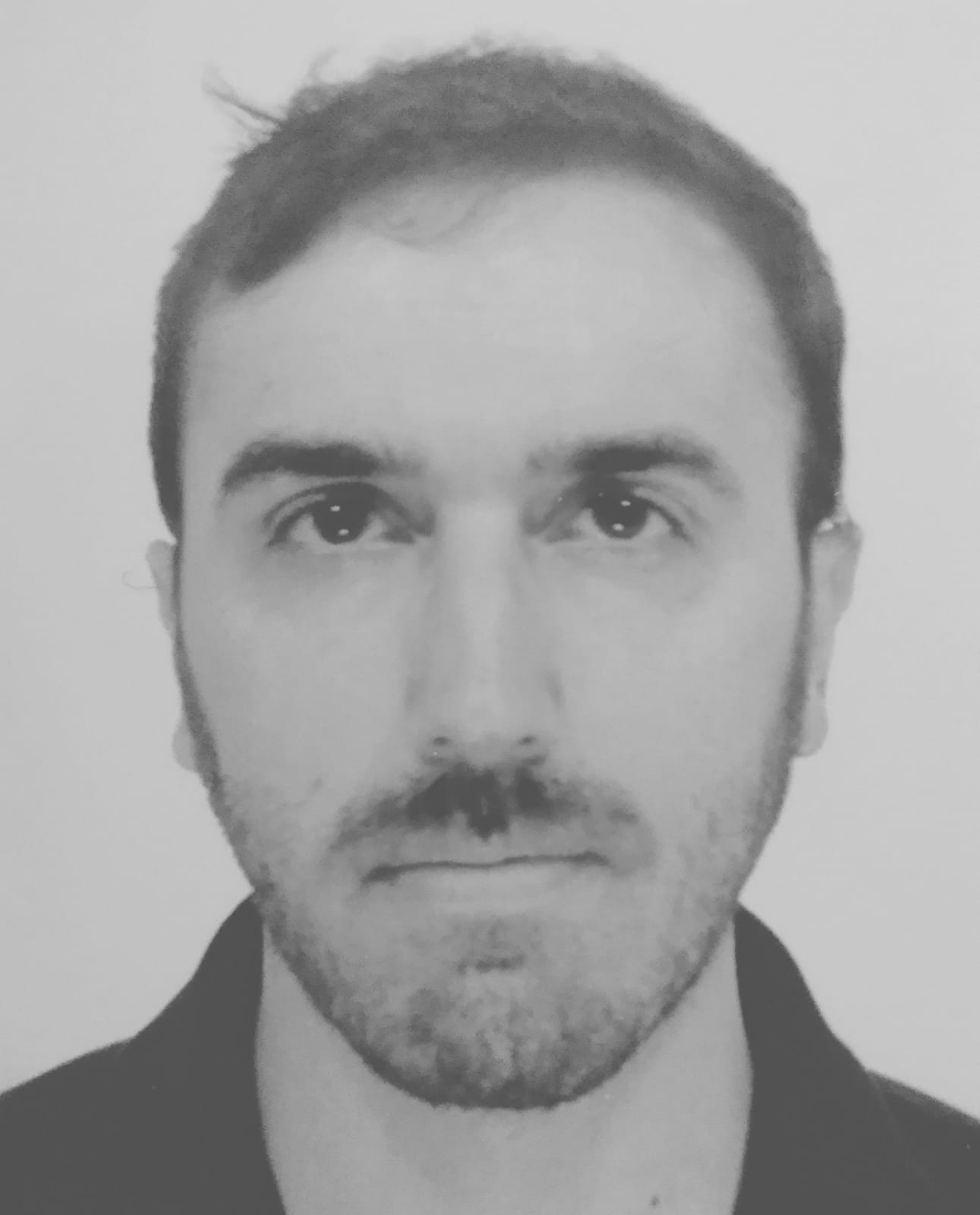Altro che divorzio da Putin, i giacimenti africani da cui compreremo il nuovo gas sono co-gestiti dalle società del Cremlino

Lo scorso 28 febbraio, pochi giorni dopo i primi raid russi su Kiev, il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani ci metteva in guardia: «Ci vorranno 24 mesi per cominciare ad avere una sensibile riduzione» della dipendenza dal gas di Putin. La settimana successiva, intervistato su RaiTre, il ministro correggeva il tiro: serviranno «24-30 mesi». Ma già poche ore dopo, intervenendo al Senato, allontanava ulteriormente il traguardo: «Tra 24 e 36 mesi». Il 22 marzo, davanti alla Camera, si spingeva ancora più in là, parlando di «orizzonte minimo di 3 anni». Poi il Governo ha iniziato a negoziare accordi per la fornitura di metano con Paesi africani e mediorientali. E a sorpresa, il 21 aprile, intervistato da Alan Friedman su La Stampa, Cingolani ci ha dato buone notizie: «Potremo cominciare veramente ad avere una quasi totale indipendenza entro il secondo semestre dell’anno prossimo». Vale a dire fra solo un anno e mezzo, ovvero tempi dimezzati sulla tabella di marcia, quindi ottimismo a profusione. Peccato invece che pochi giorni fa, il 3 maggio, rispondendo alle domande di Luca Fraioli su la Repubblica, Cingolani ci ha scaricato addosso una nuova doccia fredda: «Dovremmo essere autonomi entro la seconda metà del 2024», ossia fra circa due anni e mezzo. Difficile capire qualcosa in un tale marasma comunicativo.
Comunque sia, in attesa della prossima giravolta del ministro (e di un chiarimento dall’Ue sulla querelle dei pagamenti in euro o rubli a Gazprom), è bene non farsi illusioni: se si esaminano una per una le situazioni dei singoli Paesi a cui il Governo italiano si sta rivolgendo per compensare le forniture russe, si scopre – come vi abbiamo raccontato la scorsa settimana su questo giornale – che, ad esempio, l’Algeria utilizza il proprio gas principalmente per soddisfare la crescente domanda interna e avrà bisogno di lunghi e costosi investimenti prima di poter aumentare la produzione. Oppure che il Qatar e l’Azerbaijan hanno un canale preferenziale con i clienti asiatici rispetto a quelli europei. Sarà insomma molto difficile recuperare altrove nel giro di appena due o tre anni i 29 miliardi di metri cubi di gas che la Russia ci ha pompato nel 2021 e che rappresentano oggi circa il 40% dei nostri consumi. A meno che non rinunciamo a una parte dell’energia necessaria per riscaldamento, aria condizionata e soprattutto produzione industriale. Mettendo in conto magari pure qualche fastidioso blackout.
Ma c’è anche un altro elemento da considerare quando si ragiona di come sganciarci dai metanodotti di Putin. E cioè che il mercato del gas, visto dall’attuale prospettiva italiana, sembra un labirinto nel quale tutte le strade portano a Mosca. Molti dei giacimenti africani ed eurasiatici che dovrebbero assicurarci l’indipendenza dalla Russia, infatti, sono gestiti da consorzi di imprese tra cui figurano le grandi partecipate di Stato ex sovietiche, come Rosneft e Gazprom. Ciò significa che anche comprando il gas da altri Paesi potremmo ritrovarci ad arricchire (seppure in misura imparagonabile rispetto a oggi) le casse del Cremlino.
Prendiamo l’Egitto. Il mese scorso, dopo un incontro fra l’amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi e l’autocrate Abdel Fattah Al-Sisi, Eni ha annunciato un accordo con Il Cairo per la fornitura, già quest’anno, di 3 miliardi di metri cubi di Gnl (gas naturale liquefatto che, una volta arrivato via nave in Italia, andrà rigassificato). Il Cane a sei zampe opera da oltre mezzo secolo in Egitto, dove produce oggi circa 12 miliardi di metri cubi di gas annui, la maggior parte dei quali utilizzati per soddisfare il fabbisogno locale. Nel 2015 Eni ha scoperto nelle acque territoriali egiziane un enorme giacimento offshore di gas naturale, Zohr, considerato la maggiore riserva del Mar Mediterraneo. Ma il 30% di questo pozzo del tesoro – messo a produzione nel 2017 (oggi sforna 87 milioni di metri cubi annui) – è stato presto venduto a Rosneft, la compagnia petrolifera di Stato russa, il cui amministratore delegato è Igor Sechin, soprannominato Dart Fener, ex agente del Kgb vicinissimo a Putin, nonché sanzionato da Unione europea, Regno Unito e Stati Uniti in risposta all’invasione dell’Ucraina.
Sempre in Egitto, Eni detiene il 76% della concessione Merged Meleiha, nel Deserto Occidentale: l’altro 24% è in mano a Lukoil, altro colosso moscovita degli idrocarburi. Lukoil è un’azienda privata, ma paga al Cremlino le tasse sui suoi profitti, che l’anno scorso hanno superato i 7 miliardi di dollari. L’azienda sarebbe tra le più colpite in caso di embargo sul petrolio russo. E ad aprile il suo presidente, l’oligarca Vagit Alekperov, è stato costretto a dimettersi dopo essere stato incluso nella lista delle persone sanzionate da Regno Unito e Australia.
La stessa Lukoil è in società con Eni anche in Congo, un Paese ancora arretrato nelle infrastrutture per la produzione e l’esportazione di gas ma dal quale il Governo italiano – dopo la missione in loco di Cingolani insieme al ministro degli Esteri Di Maio e al solito Descalzi per Eni – confida di ottenere stabilmente 4,5 miliardi di metri cubi di Gnl nei prossimi anni. In Congo, dicevamo, Lukoil è socia al 25% di Eni nella
gestione del blocco Marine XII, lo stesso da cui dovrebbe sgorgare il metano da esportare in Italia. E ancora: il gigante del petrolio russo controlla il 25,5% del giacimento azero di Shah Deniz, nel Mar Caspio, dal quale proviene il gas che arriva in Puglia tramite le condutture del Tap. Nel 2021 il Trans Adriatic Pipeline ci ha fornito 7 miliardi di metri cubi di metano, ma, ora che c’è da svincolarsi da Putin, i ministri Cingolani e Di Maio puntano ad aumentare il flusso, sebbene le capacità di carico dell’infrastruttura siano limitate.
Tornando in Africa, il Paese su cui il Governo fa maggiore affidamento per superare la dipendenza energetica dalla Russia è l’Algeria: già oggi, con 21 miliardi di metri cubi di gas attraverso il metanodotto Transmed, Algeri è il nostro secondo fornitore dopo Mosca. Non a caso, il mese scorso si è scomodato persino il nostro presidente del Consiglio, Mario Draghi, per andare a stringere la mano al capo di Stato algerino Abdelmadjid Tebboune: l’intesa prevede di raggiungere entro un paio d’anni i 30 miliardi di metri cubi annui. L’obiettivo è complicato da concretizzare per le ragioni esposte all’inizio di questo articolo, ma c’è un altro grande problema: l’Algeria ha un rapporto di ferro con la Russia, come ha dimostrato ad esempio astenendosi nel voto sulla risoluzione dell’Onu che condannava l’invasione dell’Ucraina. Pochi giorni dopo la visita di Draghi, il presidente Tebboune ha ricevuto una telefonata di Putin, al quale ha confermato la «intenzione di continuare il coordinamento bilaterale nel formato Opec Plus e nel quadro del Forum dei Paesi esportatori di gas per assicurare la stabilità dei mercati energetici globali». Un patto che si traduce, ad esempio, nel rafforzamento – annunciato a febbraio, appena prima della guerra – della collaborazione fra la compagnia statale algerina Sonatrach e la russa Gazprom, con quest’ultima che detiene il 49% dell’impianto di estrazione El Assel, operativo dal 2025.
Gazprom – controllata dal Cremlino – è ben radicata anche in Libia, che un tempo era un grande esportatore di idrocarburi mentre oggi è un territorio devastato da anni di conflitti: nel 2021 il gasdotto Greenstream – che parte dalla Tripolitania – ha trasportato 3 miliardi di metri cubi di metano fino alla Sicilia. Il Governo italiano spera di racimolare qualcosa di più nei prossimi anni. Magari attingendo dal bacino di Ghadames, gestito dal colosso di Stato russo. Poi, se proprio vogliamo notare il pelo nell’uovo, ci sarebbe da ricordare anche che l’emirato del Qatar – da cui Cingolani spera di drenare 4 miliardi di Gnl – è azionista al 19% di Rosneft tramite il proprio fondo sovrano, e che quindi acquistando da Doha si finanzia di fatto un socio indiretto di Putin.
Vero è che trovare sul mercato un fornitore di gas che sia totalmente immacolato rispetto a legami con la Russia è impresa ai limiti dell’impossibile. D’altra parte però è anche importante essere consapevoli del fatto che la superpotenza energetica del Cremlino ha ramificazioni così fitte e prolungate che finiranno per toccarci anche dopo il divorzio da Mosca. Così come sarebbe interessante conoscere le condizioni degli accordi che il nostro governo sta trattando in giro per il mondo, intese che invece – poiché stipulate da una società privata, Eni – sono coperte da riservatezza.
Sarebbe interessante conoscere sia le clausole economiche, per capire quanti soldi stiamo promettendo a Stati non propriamente democratici e quali costi aggiuntivi dovremo sopportare (per aggiudicarsi la fornitura di Gnl ci sarà da vincere la forte concorrenza dei Paesi asiatici), sia quelle sulla durata dei contratti. Come ha spiegato la scorsa settimana su TPI Francesco Sassi, ricercatore in geopolitica e mercati energetici presso il centro Ricerche industriali ed energetiche di Bologna, «il gas necessita di infrastrutture che sono molto costose e legano il Paese importatore e quello esportatore nel lungo periodo». Ciò significa che con questi contratti rischiamo di vincolarci per decenni a un combustibile fossile che era stato individuato dalla Commissione europea come mera fonte di transizione verso il completo passaggio alle rinnovabili. Rinnovabili che per l’Agenzia internazionale dell’Energia (Iea) nel 2050 dovranno alimentare il 90% dell’economia globale. Così, oltre alla guerra con la Russia, si sta complicando anche la strada del Green New Deal.